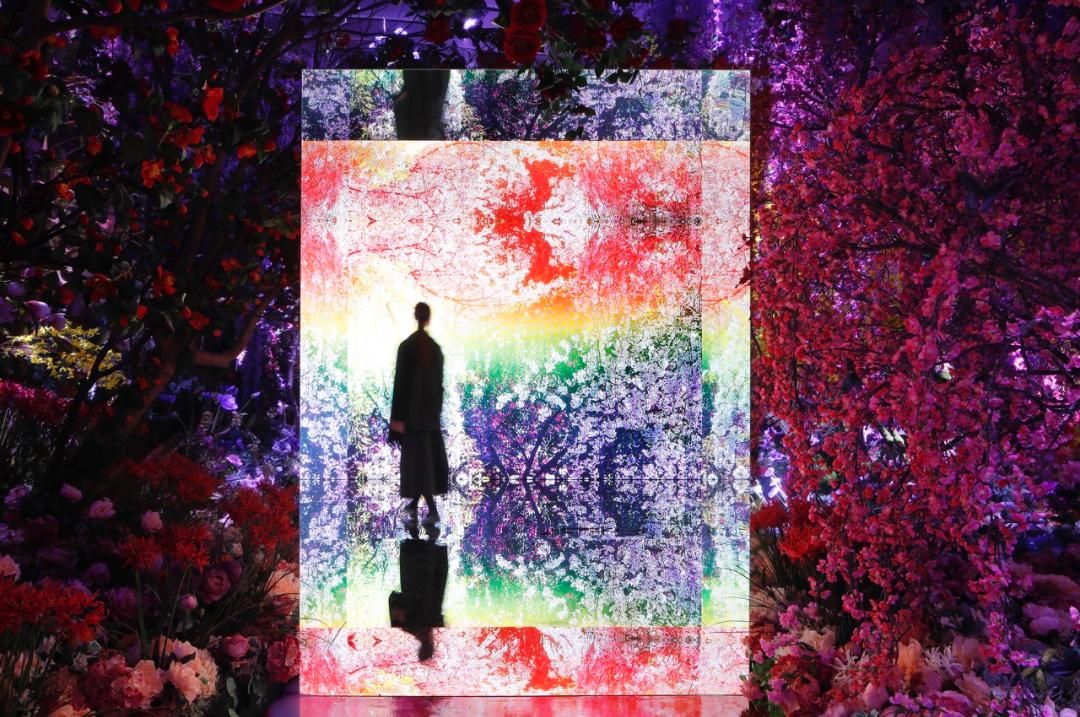Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Michela Moro
Leggi i suoi articoliUna proposta globale per il nostro futuro prossimo, che riflette sul presente e propone mille suggestioni di riflessione. Questa è la 19. Mostra di Architettura della Biennale di Venezia dal titolo «Intelligens. Natural. Artificial. Collective», tema indicato dal curatore Carlo Ratti e declinato dai 750 partecipanti.
L’Arsenale è nella visione di Ratti, primo italiano alla conduzione dell’imponente manifestazione dopo quella del 2000 di Massimiliano Fuksas, un grande organismo pulsante, che permette all’architettura, sapere inclusivo per eccellenza, «di attingere a tutte le forme di intelligenza: naturale, artificiale, collettiva. Nell’età dell’adattamento, l’architettura deve rivolgersi a più generazioni e a più discipline, dalle scienze esatte alle arti, deve ripensare il concetto di autorialità e diventare più inclusiva, imparando dalle scienze, diventare flessibile e dinamica, proprio come il mondo per cui sta progettando».
L’ingresso dell’Arsenale è la rappresentazione plastica di eventi temuti e già sperimentati: inondazioni e calore tossico, condizionatori che sputano aria calda su un mare nero (collaborazione tra Transsolar, Bilge Kobas, Daniel A. Barber, Sonia Seneviratne e Fondazione Pistoletto Cittadellarte). Poi, letteralmente, si scollina: «The Other Side of the Hill», l’altra faccia della collina, un’esposizione di come l’umanità, arrivata al picco della crescita demografica, dovrà necessariamente mutare, guardando anche alle gigantesche comunità di batteri, realizzate con materiali biodegradabili ed estratti dalla laguna. In questa prima stazione è riassunta l’intera dinamica di questa Biennale: il gruppo è composto dal fisico Geoffrey West, dal biologo Roberto Kolter, dai teorici dell’architettura Beatriz Colomina e Mark Wigley, e dall’architetta e designer Patricia Urquiola, quindi una vasta compagine di rappresentanti di tutte le discipline che dialogano in mille modi, non solo architetti, è la collettività che spinge verso un futuro all’apparenza disastroso ma che si spera trovi soluzioni, con materiali innovativi o riciclati, bandito lo spreco.
Da lì in poi le Corderie, il lunghissimo spazio in cui venivano realizzate le cime delle grandi navi veneziane, si frantumano in una sequenza di progetti grandi e piccoli che seguono le tre declinazioni del titolo «Naturale, Artificiale e Collettivo» e che spaziano tra robot, ricerche sul campo, materiali mai incontrati prima e invenzioni stupefacenti. L’impatto è di grande densità espositiva, il visitatore può essere disorientato ma se, come sostiene Ratti, le intelligenze permettono assonanze, poi i percorsi e i linguaggi si dispiegano più chiaramente. Le didascalie esaustive sono sorpassate dai riassunti in IA sul medesimo pannello. Presenti nomi illustri da Kengo Kuma a Norman Foster e a Emilio Ambasz, quest’ultimo con un progetto avveniristico nel verde di circa cinquant’anni fa.

Una veduta del Padiglione del Regno del Bahrain con «HeatWave, Canicola». Courtesy of La Biennale di Venezia. Photo: Andrea Avezzù
Nel percorso sono come sempre inclusi molti padiglioni nazionali, che hanno accolto le linee del titolo per affrontare i temi secondo le proprie realtà. Si passa dal «Cantico Tiberino: Cradle of More-than-Human Intelligences», Roma 2050, (Laboratorio Roma050, Enrico Alleva, Davide Curatola Soprana, Frame by Frame, Federico Pastorelli) dal titolo esplicativo, alle pietre fumanti che attivate da speciali batteri accelerano la rimozione dell’anidride carbonica atmosferica, a Material Bank (Stefano Capolongo, Ingrid Maria Paoletti, Margherita Palli Rota, Konstantin Novosëlov), collegamento tra persone e natura, e Circularity Handbook (Pills, Jin Arts, typo_d, Archi-Neering-Design/And Office, Róng Design Library, Xiaoqing Cui, Zhengwei Tang) spettacolare connubio tra delicatezza artigianale e tecnologia. Si arriva a «Resourceful Intelligence: Enhance Urban Mining in the Built Environment», progetto urbano milanese già in fase di realizzazione (Park, Accurat, Gabriele Masera, Francesco Pittau, Michele Versaci) in cui l’Hotel Michelangelo e il Palazzo Missori di Marcello Piacentini vengono rispettivamente demoliti e ricostruiti, e riqualificati con il recupero e il riutilizzo di materiali preesistenti quali klinker e vetro.
Non c’è differenza tra i Paesi, le voci arrivano dal Nord e dal Sud del mondo; è in mostra la vera globalizzazione, come dimostrano i premi assegnati. Le menzioni speciali a «Alternative Urbanism: The Self-Organized Markets of Lagos» (Tosin Oshinowo, Oshinowo Studio) ed «Elephant Chapel» (Boonserm Premthada), la Cappella degli Elefanti, uno dei landmark del percorso, realizzata dai thailandesi con mattoni durevoli in sterco di elefante. Leone d’Argento per una promettente partecipazione meritatissimo a «Calculating Empires: A Genealogy of Technology and Power Since 1500» di Kate Crawford, Vladan Joler, una monumentale mappa che meriterebbe di essere letta da cima a fondo per seguire le infrastrutture digitali e sociali che si sono sviluppate in modo interdipendente nel corso dei secoli. Berremo caffè di acqua di laguna con il Leone d’Oro per la migliore partecipazione alla 19. Mostra «Canal Cafè» (Diller Scofidio + Renfro, Natural Systems Utilities, Sodai, Aaron Betsky, Davide Oldani), dimostrazione di come Venezia possa fungere da laboratorio per immaginare nuovi modi di vivere sull’acqua, offrendo al contempo un contributo concreto allo spazio pubblico veneziano.
Nutrita la partecipazione di Nazioni giovani, almeno come espositori in Biennale. Vince il Leone d’Oro per la miglior Partecipazione Nazionale il Regno del Bahrain, con «HeatWave, Canicola» (Shaikh Khalifa bin Ahmed bin Abdullah Al Khalifa, President Bahrain Authority for Culture and Antiquities, Andrea Faraguna, Wafa Al Ghatam, Eman Ali, Alexander Puzrin, Mario Monotti), proposta concreta per affrontare condizioni di calore estremo. «L’architettura deve affrontare la doppia sfida della resilienza ambientale e della sostenibilità. L’ingegnosa soluzione può essere impiegata negli spazi pubblici e nei luoghi in cui le persone devono vivere e lavorare all’aperto in condizioni di calore estremo. Il padiglione utilizza metodi tradizionali di raffreddamento passivo tipici della regione, che richiamano le torri del vento e i cortili ombreggiati».

Una veduta di «Opera Aperta» nel Padiglione della Santa Sede. Photo: Marco Cremascoli
L’immenso Padiglione Italia racconta le nostre coste con un’esposizione che dovrebbe essere itinerante e visitata dalle scolaresche. «Terræ Aquæ. L’Italia e l’Intelligenza del mare» (Angelo Piero Cappello, Guendalina Salimei) è frutto di una open call che ha disposto le proposte in sequenza, con video e molte foto puntualizzate da opere d’arte contemporanea, il tutto organizzato da una struttura di tubi innocenti che riporta a biennali passate.
Interessante il Padiglione Ukbekistan, «A Matter of Radiance», curato da Grace (Ekaterina Golovatyuk, Giacomo Cantoni), su uno degli ultimi grandi progetti scientifici Urss, Sun Heliocomplex, uno dei due forni solari esistenti al mondo. Premio dei visitatori per la miglior borsa omaggio argento catarifrangente molto ambita.
Coraggioso il Padiglione Granducato di Lussemburgo, «Sonic Investigations» (Valentin Bansac, Ludwig Berger, Anthea Caddy, Mike Fritsch, Alice Loumeau, Peter Szendy) esclusivamente sonoro.
I Giardini sono quest’anno in versione ridotta, sia per l’assenza di vari padiglioni nazionali, tra cui Russia, Israele, Venezuela e Ungheria, mentre il Padiglione Centrale è chiuso per ristrutturazione, e riporta sulla facciata «Constructing La Biennale» (Politecnico di Torino, Barabasi Lab, Center for Design Northeastern University) una nuvola di punti larga 30 metri, a tracciare graficamente la storia della Biennale Architettura (1974-2023).
Nonostante ciò, grande folla ovunque. Menzione speciale come Partecipazione Nazionale alla Santa Sede, sempre emozionante e raccolta, e alla Gran Bretagna, «Geology of Britannic Repair»: un dialogo tra Regno Unito e Kenya sul tema della riparazione e del rinnovamento (senza menzionare colonialismi) che trasforma l’esterno del padiglione in un coloratissimo edificio e l’interno in un interessante percorso geologico etnografico. (Sevra Davis, British Council, Owen Hopkins, Kathryn Yusoff, Kabage Karanja, Stella Mutegi, cave_bureau, Palestine Regeneration Team-Part, Mae Ling Lokko & Gustavo Crembil, Thandi Loewenso).
La Svizzera, come Giappone, Corea e altri, rileggono il proprio padiglione. Piace molto la Danimarca decostruita, gli italiani sorridono all’Austria, che ipotizza un connubio tra il meglio di Vienna e di Roma, incuriosisce il Qatar. Già, il Qatar. Avrà un padiglione vero e proprio al posto dell’accogliente e provvisorio padiglione di quest’anno, Community Centre, della pakistana Yasmeen Lari, parte della mostra «Beyti Beytak. My home is your home. La mia casa è la tua casa», presentata sia ai Giardini che a Palazzo Franchetti. È la prima volta dal 1996, anno dell’inaugurazione del Padiglione Corea, che uno stato riesce a conquistare l’ambìto luogo. Prima di allora, nel 1987, il Padiglione Australia. Negli anni ci hanno provato in molti senza risultato. Alla presentazione del progetto a Palazzo Franchetti, da parte della Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, commissario del Padiglione del Qatar e presidente di Qatar Museums, e dell’architetta libanese Lina Ghotmeh, attiva da anni a Parigi e vincitrice del concorso per il futuro padiglione, assisteva un parterre de roi trasversale e di tutto rispetto, da Alejandro Aravena a Patrizia Sandretto, dal past president Biennale Roberto Ciccutto a Giuseppe De Bellis, Art Basel, a Marva Griffin, Salone del Mobile, e Luca Molinari, sofisticato curatore di mostre di architettura. Nessuno ha parlato di cifre in sala, ma è ovviamente vantaggioso l’accordo che il Comune ha chiuso con l’Emirato del Qatar, 50 milioni di euro non ufficialmente riportati, «per soddisfare le pressanti esigenze della Città nella gestione di un patrimonio unico ed estremamente complesso, che trascende i confini e rappresenta un tesoro per l’umanità». Classica e raffinata la mostra che accompagna il padiglione, con disegni e documenti d’antan, come i filmati in cui Hassan Fathi parla delle abitazioni arabe.
L’osmosi tra Biennale e Venezia è totale, e se l’architettura fa la parte del leone, mille iniziative punteggiano come sempre i tre giorni pre-inaugurazione. Particolarmente affollata, a ragione, la mostra curata da Hans Ulrich Obrist negli spazi della Nicoletta Fiorucci Foundation: «Tolia Astakhishvili, to love and devour». Nel palazzo da ristrutturare l’artista lavora in modo poetico ma vigoroso su architettura, strutture e contenuti, col desiderio di sfumare i confini tra opere d’arte individuali e collettive, invitando a dialogare diversi artisti, tra cui Ketuta Alexi-Meskhishvili, Zurab Astakhishvili, Thea Djordjadze, Heike Gallmeier, Rafik Greiss, Dylan Peirce, James Richards e Maka Sanadze.
Ultima nota: la grande quantità di cartoline, proprio quelle con la foto che si usava spedire un tempo, a disposizione dei visitatori in tantissimi padiglioni e anche nel nuovo Palazzetto Querini, la casa di Palazzo Bentivoglio, Bologna, in occasione della presentazione dell’ultimo lavoro di Yuri Ancarani «Il Miracolo degli uccelli»; forse le nuove tecnologie hanno scoperto anche come riattivare l’antica cassetta postale.

Una veduta del Community Centre con l’installazione di Yasmeen Lari per il Padiglione del Qatar. Photo: Giuseppe Miotto-Marco Cappelletti Studio
Altri articoli dell'autore
Il progetto a lungo termine ideato da Giorgio Pace per l’Engadina trasforma l’Hotel Eden in una piattaforma culturale diffusa tra arte, design e nuove visioni, in attesa di diventare uno spazio fisico permanente
Marta Orsola Sironi e Mauro Umberto Mattei reinventano lo spazio espositivo con un modello ibrido tra galleria, residenza per artisti, Art Trust e programma pubblico, inaugurando con la mostra «Corale» che celebra la polifonia e l’universalità della creatività contemporanea
Technogym ridefinisce il wellness tra artigianalità, sostenibilità e visione contemporanea
Al Kmska di Anversa una novantina di opere del maestro surrealista allestite seguendo un discorso ricostruito utilizzando una voce generata dall’AI tratta da sue interviste note