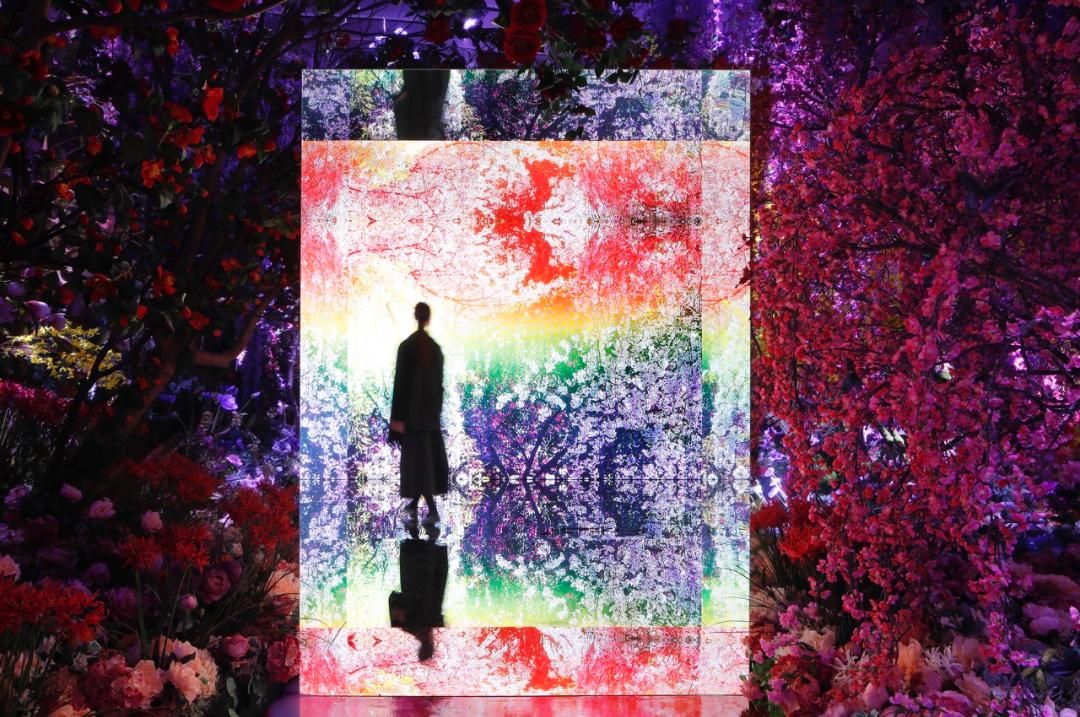Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Valeria Tassinari
Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI
«E se fosse stata Lisbeth Sachs, invece di Bruno Giacometti, a progettare il Padiglione svizzero?». Cercando risposta a questa domanda, nel contesto della Biennale Architettura 2025 il Padiglione elvetico invita a visitare un ambiente pacato, definito e curato in ogni dettaglio, nitidamente strutturato in un luminoso gioco di bianchi e grigi, pieni e vuoti, luci e ombre. Armonia. Eppure la base di partenza è un’ipotesi paradossale: ricostruire ciò che non solo non venne mai costruito, ma nemmeno mai pensato per quello spazio.
In questa 19ma edizione, in cui prevalgono cantieri in corso, spazi ibridi tra uomo e natura, ancestralità e futuri possibili, il Padiglione elvetico appare come uno dei più architettonici in senso classico, in quanto, nonostante la domanda di ispirazione dialoghi apertamente con l’impossibile, l’ideazione punta molto sulla concretezza e sull’accuratezza della costruzione, una ricerca che si esprime nella realizzazione rigorosa e particolarmente attenta ai dettagli e ai materiali.
Commissionato dalla Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia e curato da Elena Chiavi, Kathrin Füglister, Amy Perkins, Axelle Stiefel e Myriam Uzor, il progetto di questo gruppo totalmente femminile riflette sulla differenza di genere senza perdersi in recriminazioni, ma, riconoscendone l’evidenza tra ricerca storica e analisi oggettiva dei dati, porta l’attenzione sulle differenti sensibilità e condizioni che questo ha a lungo comportato nel settore dell’architettura.
Il titolo «Endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt» («La forma finale è determinata dall’architetto sul cantiere») indica, infatti, un’esplicita considerazione della centralità della persona dell’architetto e del suo ruolo identitario, partendo da un interrogativo solo apparentemente visionario. La sfida è comprendere come sarebbe oggi il Padiglione, che fu disegnato in stile modernista dell’architetto Bruno Giacometti nei primi anni Cinquanta, se l’incarico fosse stato affidato alla sua contemporanea Lisbeth Sachs (1914-2002), una delle prime architette in Svizzera, pioniera di talento ma sempre sottovalutata rispetto ai colleghi. Il gioco iniziale, che immagina di poter dare forma all’intenzione di cambiare retroattivamente la storia, non rimane però sospeso in un’astratta riflessione, e non si fissa su una rivendicazione sociale. Il progetto delle cinque giovani autrici (quattro architette e un’artista) riconosce ma supera il tema della dicotomia tra le identità di genere, dando forma a una spazialità nuova che le include e mette in equilibrio.
Le due distinte visioni e sensibilità sono poste in relazione attraverso l’inserimento nella rigorosa struttura ortogonale di Giacometti di ampie pareti libere curvilinee, di morbide cortine e di una grande cupola tessile, tratte dal progetto per un padiglione dedicato al lavoro femminile che Sachs aveva ideato nel 1958 per l’esposizione Saffa a Zurigo (la Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit, «Esposizione svizzera del lavoro femminile», fu una manifestazione nazionale tenutasi nel 1928 a Berna e nel 1958 a Zurigo, organizzata dall’Alleanza Svizzera delle società femminili, Ndr). Dall’incontro delle due visioni progettuali ne è nata così una terza, la cui forza evocativa di futuri possibili e inclusivi è rafforzata dall’introduzione di un’installazione sonora site specific che cattura conversazioni dall’ambiente e li restituisce al visitatore, in una dinamica di intima interazione, insieme a storie e memorie che sembrano trapelare dalle pareti stesse.
La centralità dell’approccio collaborativo e inclusivo, qui espressa con puntuale controllo delle forme e degli esiti estetici, si inserisce con garbata precisione nel tema generale della Biennale, il cui titolo «Intelligens. Natural. Artificial. Collective» rivela un’attenzione per il superamento delle dicotomie e delle disuguaglianze attraverso processi partecipativi. Un’ipotesi di buone pratiche, in cui la memoria dei conflitti non scompare, ma sfida a trovare percorsi di conciliazione e a restituirli in esempi tangibili.

Una veduta di «Endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt» nel Padiglione della Svizzera alla 19ma Biennale dell’Architettura di Venezia. Photo: Marco Zorzanello. Courtesy of La Biennale di Venezia