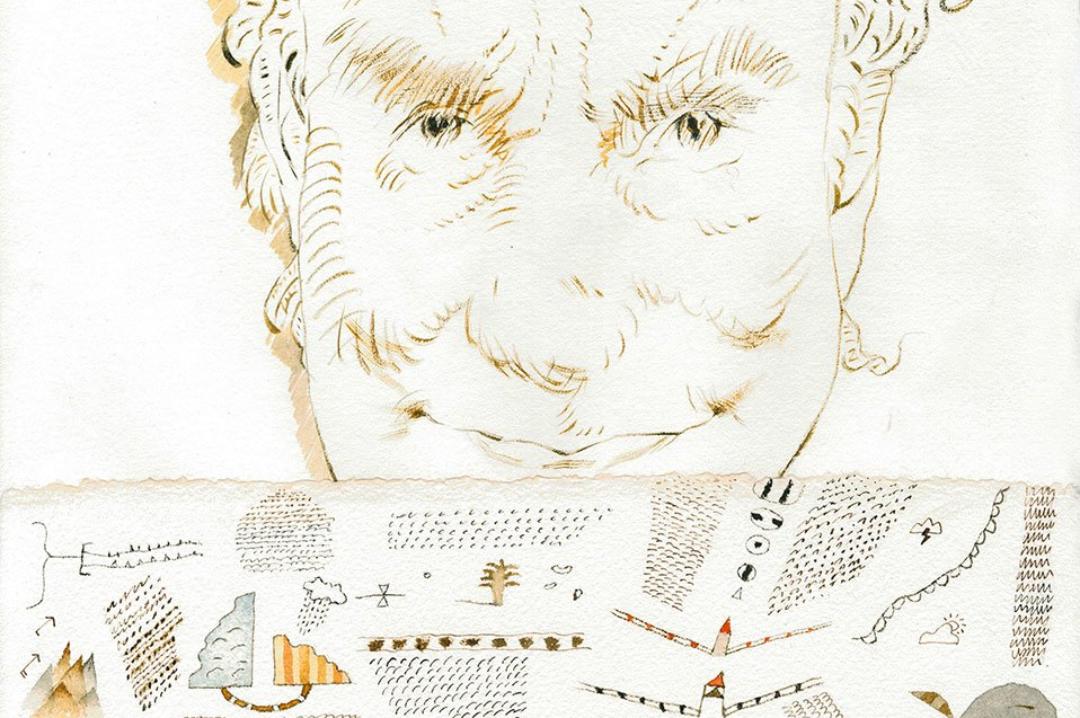Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Stefano Causa
Leggi i suoi articoliIl XX secolo ha visto la progressiva esplosione delle grandi mostre, diventate tappe obbligatorie di un pellegrinaggio che non ammette omissioni: «le imperdibili». In realtà le mostre sono spesso libri di storia e geografia travestiti. E i cataloghi sono sostituti delle monografie di studio per utenti cui l’arte è sconosciuta: «Eleganti parallelepipedi da tavolo»
Mostre e musei tra primo piano e sfondo
Per come ha preso forma nel ’900, la storia dell’arte si snoda lungo un serpentone di mostre. I musei italiani, che con le mostre avrebbero dovuto trovarsi in rapporto vicendevolmente fruttuoso, stanno ormai sullo sfondo. Il mestiere dell’arte non è un affare di musei ma di mostre. Di tre tipi per cominciare: le buone, le mezzanelle o le balorde, come le sezionava Roberto Longhi che, dai ragionati margini d’una mostra, si staccava velocemente per spingersi al largo. Il suo Giudizio sul Duecento, chiuso in un cassetto per anni, è il consuntivo di una mostra fiorentina del 1937. Viatico per cinque secoli di pittura veneziana a una rassegna tenutasi a Venezia nel ’45. Con titoli simili (Viatico, Giudizio, Frammenti, Momenti, Aspetti, Officina ferrarese) non si verrebbe ammessi neanche ai gironi eliminatori dell’abilitazione universitaria (senza contare quei referee che oggi taccerebbero Longhi di pretenziosità, accusandolo di attendere al suono più che al significato delle parole). Lo stesso Francesco Arcangeli, il più fragile e meno allineato degli allievi di Longhi, trasformò la recensione alla mostra milanese organizzata da Lamberto Vitali nel 1952 in una delle rarissime requisitorie della cultura moderna contro Van Gogh; e non mancò, qualche mese dopo, di argomentare la sua insoddisfazione montante nei confronti di Picasso dopo aver visitato le mostre romane e milanesi, le prime italiane di colui che rimane, a occhio, il maestro più mostrificato della storia.
Un atlante delle mostre
Ma Longhi e Arcangeli a parte, che di questi tempi faticherebbero a farsi pubblicare su una rivista di fascia A, nessun lettore di questo giornale, dagli affezionati della prima ora agli ultimi saliti a bordo, ha bisogno di farsi soffiare all’orecchio il valore e i limiti del circo delle esposizioni nel ’900. Un atlante delle mostre ci racconterebbe dello stato di salute della critica nel nostro Paese e di progetti di allestimento discreti o prevaricanti; farebbe emergere le difficoltà di accordare sperimentazione e comunicazione, senso dello spettacolo e rispetto della filologia; oltre che, naturalmente, metterci a parte dell’ingente quantità di danaro necessaria a condurre in porto operazioni tanto complesse quanto imprevedibili (le mostre sono tra i fossili economici della vita recente).
Parlare di una mostra significa scavare nel costume di casa. E un atlante delle esposizioni del secolo scorso, che rivela una mappatura del Paese più articolata di quella cui siamo avvezzi, lo si sta già mettendo a punto da svariate angolazioni. Da Firenze, da Parigi o soprattutto da Napoli. Bisognerà solo premurarsi di aggiornarlo dando per fermo che, tra i filoni di ricerca più sollecitanti e solleticanti del mercato editoriale, le mostre d’arte siano libri di storia e geografia travestiti.
Anche i più accorti tra gli storici contemporanei lo sanno e non lo sanno. Ma l’esposizione del 1938 sui tre secoli della pittura napoletana, dal Caravaggio a Gemito, fu la più organica operazione di propaganda di regime alla vigilia dell’entrata in guerra (nell’ultimo secolo Caravaggio è stato tirato da tutte le parti; ma difficilmente si potrebbe dimostrare che, ove si fosse trovato a operare durante il ventennio, sarebbe diventato fascista come Sironi, Donghi o Achille Funi. Tra le camicie nere Caravaggio finì per essere arruolato a forza, sia pure per opera. Ma in camicia nera non sapremmo figurarcelo neanche in spirito). Piaccia o meno, ritagliare, di tutta l’arte napoletana, solo tre secoli sforbiciando, a non dir altro, la scultura e le arti decorative, fu operazione tanto incongrua quanto fortunata. Tutte le mostre seicentesche organizzate a Napoli sono, nel bene e nel male, una postilla ragionata a quella del 1938. D’altronde nulla restituisce meglio il clima di attesa e riprese che si respirava a Torino nei primi anni ’60 più della rassegna sul Barocco piemontese messa su da Vittorio Viale nel 1963. Così come si riflette nella mostra sul ’600 fiorentino, voluta da una studiosa rigorosamente non fiorentina come Mina Gregori, il balletto di adesioni e resistenze di una città che, proprio quarant’anni fa, non si era ancora trasformata nel parco a tema sul Rinascimento e le fiction sui Medici.
Le mostre siamo noi
Le mostre siamo noi. Abbiamo vissuto inseguendole nel passa parola o nelle recensioni. Non tutte lo meritavano. Ma è da poco che abbiamo imparato a difenderci dai brutti film, dalla pessima musica e da esposizioni sotto il livello di guardia (quella mostra non l’ho vista e non mi piace! per parafrasare Giorgio Manganelli che lo diceva di alcuni libri). Ma bisogna riconoscere che, tra una mostra e l’altra, si è incuneato il grosso del nostro lavoro. Nella selezionata collana dei «Testimoni dell’arte» di Allemandi vi sono, tra i titoli irrinunciabili, due collazioni di recensioni di mostre (La Cultura dell’ignoranza di González-Palacios del 1983 e, dello stesso anno, La Faccia nascosta della luna di Luigi Carluccio che ripete, nel titolo, un celebrato lavoro dei Pink Floyd uscito dieci anni prima).
Figli o nipoti più o meno degni di Longhi e dei suoi interlocutori, non abbiamo fatto che spalancare note e precisazioni a un allestimento o a una sistemazione catalogica. E i cataloghi che, al di là del valore, riportavamo sempre a casa per un imperativo morale, sono la spina dorsale del mestiere. In principio si potevano consultare nelle sale. Le mostre su cui Longhi ha rifondato la storia dell’arte italiana erano scortate da libricini ridottissimi; talvolta con appena i dati delle opere esposte. Nel 1938 il monacale catalogo di Melozzo e del Quattrocento romagnolo, stampato dagli editori del «Resto del Carlino», costa 30 lire ed è un viaggio virato in bianco e nero (la scoperta dei borghi più belli d’Italia, prima che un’escogitazione da tv generalista, è nata nei cataloghi di mostre).
La rassegna sui Fiamminghi e l’Italia, apertasi al Museo di Bruges nell’estate 1951, è un tascabile di ottanta pagine. Il delizioso catalogo sull’Età Neoclassica in Lombardia, inauguratasi nell’estate del ’59 alla Villa Comunale dell’Olmo a Como, Angela Ottino Della Chiesa timoniere e Gronchi patrono, reca un saggio introduttivo di una quarantina di pagine (il resto sono foto e schede in stile telegrafico). Dieci anni dopo, presidente della Repubblica Saragat, i Pittori genovesi a Genova nel ’600 e nel ’700 non è solo la prima ribalta di una delle più grandi scuole del secolo, ma anche il trionfo della zarina delle arti genovesi, Caterina Marcenaro, che, nell’agosto del 1969, firma una prefazione al catalogo lunga ben cinque pagine (5)!
Titoli e sottotitoli
Queste esposizioni s’intitolano in modo schietto e assolutamente banale. «Mostra di Caravaggio e dei caravaggeschi». «Andrea Mantegna». «Mostra della pittura napoletana dei secoli XVII-XVIII-XIX». Nessuna strombazzatura. Nessun gioco di parole. Nessun effetto speciale. Non è ancora invalso l’uso di inalberare sulle locandine un gancio calamitante accompagnato da un sottotitolo esplicativo (nel 1990 si apre, a Castel Sant’Elmo a Napoli: «All’ombra del Vesuvio. Napoli nella veduta europea dal Quattrocento all’Ottocento»; o, che so, «Splendori di pietre dure. L’arte di corte nella Firenze dei Granduchi» per una mostra a Firenze del 1988; oppure ancora, l’anno dopo e per finire il decennio in bellezza, «Diana Trionfatrice. Arte di corte nel Piemonte del Seicento», Allemandi).
E non è neanche ancora nata l’abitudine di annunciare, nel titolo, un maestro ritenuto di seconda lista e, nel sottotitolo, in qualità di garanti o specchietti per le allodole, uno o due maestri di primissimo cartello (per dire: «Cagnacci protagonista del Seicento tra Caravaggio e Reni», Forlì 2008).
Nel secondo dopoguerra, in volontaristiche stagioni di ripresa, occorre arrivare al sodo prima che al soldo; i titoli sbarazzini e le strizzatine d’occhio avrebbero ingenerato fraintendimenti. L’informazione, anche storico artistica è, nominalmente, tenuta dentro un codice regimental. I testi saranno altra cosa; ma chi si fermi alla copertina deve sapere cosa compri, patrocini e sponsorizzi. Caravaggio. Giorgione. Crivelli. Antonello da Messina. Lotto o Tiziano. Mantegna o Ghiberti.
Veloci come uno sparo, i nomi degli artisti dominano titoli e copertine. Fino agli anni ’70 le mostre fanno a gara nel dotarsi di vademecum poveri ma belli, dentro i quali si esercita il talento dei giovani critici. Ma già il catalogo della mostra di Mantova del 1986 è un librone fatto e finito su Giulio Romano; e Duccio a Siena, 2003, è servito da un maxivolume di oltre cinquecento pagine. La mutazione del catalogo da mero strumento di consultazione a elegante parallelepipedo da tavolo connota l’industria editoriale di questo mezzo secolo. Il sonno della ragione, per riappropriarsi della più abusata delle parafrasi, non genera mostre; ma pesanti cataloghi di mostre. Inclini a fare empimento ma non sostanza.
La Madre di tutte le mostre
Nel 1979 non c’è casa di notai, avvocati, dentisti o liberi professionisti dove non faccia vista di sé il catalogo di «Civiltà del ’700 a Napoli», la Madre di tutte le mostre. Stampato da un editore fiorentino (Centro Di, Ndr), quel cofanetto è il regalo da mettere sotto l’albero e chiude in un segnale di distensione, se non di speranza, il decennio delle stragi. Che poi lo si aprisse o meno è un altro paio di maniche (l’astuccio lo promuoveva a soprammobile, tenendolo al riparo da ogni tentazione di lettura). L’importante era dotarsene: come un distintivo di status e un kit salvavita se la conversazione dovesse languire (era come avere nel 1959 il quintetto di Miles Davis o, nel ’67, il sergente Pepe dei Beatles). In due volumi ti portavi a casa il ’700 migliore prodotto dalle nostre parti: architettura, pittura disegno e arti decorative.
Al progetto lavorò un comitato impressionante di esperti facendosi aiutare da giovanissimi laureati, tanto motivati quanto inesperti. Ma vuoi mettere: avevi il catalogo della mostra. Culturalmente eri assolto. Ora non è che ci si fosse d’improvviso accorti dell’esistenza di una cosa chiamata storia dell’arte (che era e sarebbe rimasta sconosciuta al pubblico). Semplicemente, con un titolo capiente e generico, «Civiltà del ’700» fa intendere anche ai non addetti la possibilità di un accostamento non specialistico alle discipline. Scegliere di scrivere in copertina «civiltà» significava annettersi storia e tradizioni popolari; ricostruzione dei contesti, usi, costumi e volontà artistica. Voleva dire tutto e niente (e quella antropologica parve anche allora l’uscita di sicurezza per quanti cominciassero a perdere il contatto con le opere d’arte).
Certo «Civiltà del ’700» è un titolo alquanto più attraente di un irrefutabile «Settecento lombardo» (la pur bellissima rassegna milanese del 1991). Quella delle civiltà fu una formula che divenne un format da reiterare impunemente (da «Civiltà del ’600» a «Civiltà dell’800»). Non si era mai vista tanta civiltà a Napoli a distanza di così pochi anni da una mostra all’altra.
Eventi
Però a Capodimonte a vedere il ’700 borbonico ci salì realmente un sacco di gente, mentre ci si illudeva che le mostre potessero funzionare da volano per i musei che le accoglievano. Non è andata così, come sappiamo fin troppo bene. Ma con ottimismo commovente, negli uffici della Soprintendenza capitanata da un Raffaello Causa cinquantacinquenne, s’immaginò un visitatore tipo che integrasse la visita alla mostra con quella alle collezioni permanenti, aperte dal ’57 e rimaste semivuote per vent’anni. Un circolo virtuoso tra museo e mostre, come a dire tra stabile ed effimero, che di lì a qualche anno sarebbe diventato vizioso. Ma a quel punto, mentre i musei recedevano sullo sfondo, le mostre rimbalzavano in proscenio. Con un nome diverso. EVENTI.
Cataloghi e monografie
D’altronde nelle case degli italiani i cataloghi non rubarono subito la scena. La biblioteca dei Longhi marito e moglie è ricca di romanzi, fonti, saggi e riviste. Ma già le scaffalature di uno storico dell’arte nato tra le due guerre cresceranno specificandosi nella corsia delle mostre. Un’occhiata ai dorsi basta a evincerne una geografia che è un itinerario di formazione e un’educazione sentimentale. I cataloghi sono idealmente segnati in rosso, le monografie in blu (come le strade secondarie negli stradari americani che dilatano lo spostamento fino allo smarrimento). Alcuni tra i più bei viaggi in Italia della letteratura recente sono cronache di esposizioni raccolte in volume: da Arbasino a Briganti, da Praz a Zeri, a Marina Causa fino a Manganelli stesso.
Storici dell’arte, scrittori e critici militanti scendono e s’incontrano sullo stesso campo da gioco: le mostre. Un tempo dai cataloghi si esigeva rapidità. Destinate agli operatori del settore, le monografie avrebbero sancito il diritto all’indugio, eventualmente raddoppiando i volumi. Ma tutto si è capovolto. Le monografie, che stanno ai cataloghi come i musei alle mostre, hanno provato a rimodularsi sulla sveltezza dei cataloghi; mentre i cataloghi, specie a partire dagli inoltrati anni Settanta, rallentano per appaiarsi alle monografie, ingigantendosi e criptando lo stile (oggi i direttori dei musei, che non devono obbedire al gradimento dei commissari universitari, sono costretti a suggerire ai curatori di scrivere saggi fruibili da utenti cui l’arte è sconosciuta). Nella fase più sperimentale la critica invade i cataloghi tenendosi a distanza dallo specialismo.
Nell’introduzione di Longhi al catalogo sui «Pittori della realtà in Lombardia» abbondano i riferimenti alla scena contemporanea che, nel 1953, schiera il Neorealismo contro l’Astrattismo. In questa mostra di Milano, cui non arrise il successo di «Caravaggio 1951», Longhi oppone i ritratti di Moroni alla secchezza di Mondrian. La storia dell’arte scontava faziosità e passione, mescolando antico e moderno ma rischiando, come in questo caso, di rompersi il collo. Mondrian, dal canto suo, sfuggì totalmente ai radar di Longhi, ma questo è il male minore. Fatto sta che soprattutto nella palestra delle mostre avrebbe avuto modo di sfogarsi l’attitudine militante della migliore critica dello stile.
Livori in corso
In sedi ospitanti antiche e nuove (in Palazzo Abatellis a Palermo o a Castelvecchio a Verona, alle Scuderie del Quirinale o al Palazzo della Pilotta a Parma) le esposizioni sono luoghi di incontro e scontro, di riconciliazione e livori in corso; per qualcuno di promesse di amore. I migliori litigi della nostra vita sono avvenuti dinanzi ai quadri di un’esposizione. Ripassarle in ordine cronologico è come scorrere l’album di famiglia. C’erano cose bellissime esposte male e illuminate peggio; si leggevano bene oppure il vetro ne falsava la lettura? Francis Bacon raccomandava dinanzi ai suoi polittici vetri riflettenti di modo che lo spettatore si ferisse gli occhi, sforzandosi di entrare nell’opera corpo e anima! E come sarebbe stata più persuasiva la mostra con venti o trenta opere in meno (è quanto suggeriva un viaggiatore disincantato come Giuliano Briganti uscito dalle sale di «Ribera» in Castel Sant’Elmo a Napoli nel 1992). Erano le mostre del nostro scontento o le mostre per cui anche un solo quadro valeva la fila o il prezzo del biglietto.
In un primo momento gli allestimenti delle mostre, una branca tra le più interessanti dell’architettura contemporanea, avrebbero potuto in qualche modo alleggerire i proverbiali rigori di un museo. Magari ci saremo irritati della stupidità di certi accostamenti o doluti del fatto che, come nelle sale da concerto, gli architetti facessero un passo avanti rispetto alle opere e mai due indietro (la parata di italiani del «Secolo di Caravaggio», apertasi a Parigi nel 1988, si ricorda anche per le invenzioni di Pier Luigi Pizzi). Alcune mostre ci hanno insegnato a vedere le cose in modo diverso o ci hanno, né più né meno, reso indicibilmente felici («Pittura di Luce» a Firenze nel 1990 o il «Secolo di Tiziano» a Parigi nel ’93). Altre le abbiamo dimenticate con la velocità con cui le avevamo evitate (quasi tutte le esposizioni in Italia dove comparissero i nomi di Monet e Van Gogh). Ma abbiamo scoperto cose che sarebbe stato difficile vedere altrimenti. In qualche caso ci siamo rassegnati al fatto che, rispettando i codici di messa in sicurezza, le mostre siano un male inevitabile o, specularmente, un bene evitabile. Come la promessa di un dono da scartare.

Una fase dell’allestimento della mostra milanese del 1951 su Caravaggio e i caravaggeschi

L’ingresso della mostra del 1951 su Caravaggio nel Palazzo Reale di Milano

Una sala della mostra del 1964 sulla «Natura morta italiana» nel Palazzo Reale di Napoli

Una sala di «Pittori genovesi a Genova», una mostra tenutasi a Genova nel 1969

Cataloghi di mostre storiche del Novecento
Altri articoli dell'autore
Il vero spirito del Natale è nella luce dorata di un capolavoro del Sassoferrato conservato nel Museo di Capodimonte
Henry Beyle pubblica in edizione limitata immagini e parole di una conversazione «fuori dai denti» del 1980 dei due grandi compagni di strada. Ogni lettura è un furto con scasso ripetono; ogni quadro pure
Atteso che, col 31 dicembre, si chiuderà il primo quarto del primo secolo del nuovo millennio, ricordiamo La Folie Baudelaire di Roberto Calasso
Nel nuovo libro di Maria Grazia Gargiulo, arte e mercato rivivono dalle pagine dimenticate de «L’Artista moderno», embrione di una rivoluzione editoriale