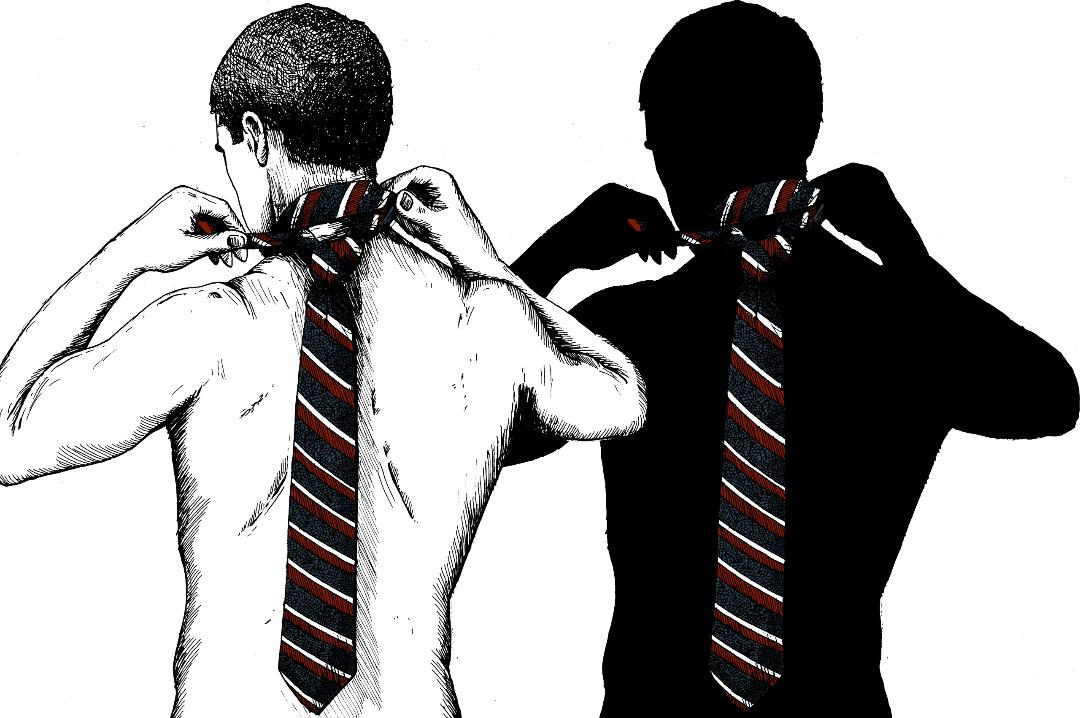Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Alessio Vannetti
Leggi i suoi articoliCorre il mese di ottobre dell’anno 2025, siamo in autunno e il mondo della moda ha archiviato il più roboante reset creativo di sempre. Un momento che passerà alla storia e che è stato segnato da un ricambio eccezionale di direttori artistici e visioni stilistiche. Secondo «Business of Fashion», che ha coniato il termine di «fashion reset», questo è un «anno senza precedenti» per avvicendamenti ai vertici creativi di diversi marchi. Case di moda storiche come Chanel, Dior, Dries Van Noten, Balenciaga, Gucci, Jean-Paul Gaultier, Celine e persino Versace, solo per citarne alcune, stanno scommettendo su nuovi designer per rilanciare la propria immagine e alimentare il desiderio del pubblico in un momento di flessione dei consumi. Attorno al tavolo del contemporaneo si sono autoinvitati diversi elementi di discussione: i prezzi altissimi a cui i marchi ci hanno abituato negli ultimi anni, un management che fa fatica a orientarsi in un mercato sottomesso allo scenario sociopolitico, movimenti (pseudo) culturali che stanno rendendo trasparenti, se non cancellando, le microcomunità attive nella moda. Eradicare l’influenza della cultura «woke» nel settore della moda comporta l’adozione di criteri uniformi per le collezioni, le sfilate, le campagne pubblicitarie e in generale per la comunicazione aziendale, conformando tutto a standard di «buon gusto» che mirano a una clientela omogenea e poco variegata. Le nicchie di mercato sono le fondamenta su cui il fashion business si regge da sempre e sono attivabili quando l’offerta è posizionata in modo che possa essere desiderabile da quel cliente ipotetico. Il prezzo diventa quindi un fattore cruciale: desiderare fortemente qualcosa di irraggiungibile può provocare frustrazione e creare un’aura negativa attorno all’oggetto stesso. Questa negatività potrebbe persino scoraggiare anche i clienti disposti a spendere di più, che potrebbero sentirsi a disagio nell’essere associati a quel particolare marchio. Michele Ciavarella, vicedirettore di «Style Magazine» del «Corriere della Sera» e penna di moda autorevole, ci ricorda da qualche tempo con le sue pillole video su Instagram che: «La moda ha deciso una separazione non consensuale proprio con quella fascia di clienti che la sostiene e soprattutto le dà il senso del suo significato: essere un segnale di rottura del consueto. Oggi si è rifugiata tra i super ricchi alla ricerca di un profitto che sembra arricchirla ma le toglie il senso». Seguendo questa logica, il «senso» è quella parte di business che non è né altissima, né aspirazionale ma generata da amanti della moda che non sono le basi del business ma bensì i pilastri progettuali dello stesso. Se quei pilastri sono inclusi nella conversazione al tavolo ma non invitati alla festa, c’è qualcosa in più su cui riflettere e che travalica il mero cambio di poltrone di stilisti.
Può la moda essere ridotta a mera esperienza? Anche solo a esperienza d’acquisto?
A partire delle esperienze di shopping, per non parlare delle sfilate o delle operazioni museali ed espositive, il fashion system si è sempre nutrito (e a sua volta ha nutrito) di territori «altri» che hanno permesso di creare memorie uniche. Le mostre di moda e sulla moda, in parte già affrontate sull’edizione del mese di settembre di quest’anno, sono sia strumento educativo sia divulgativo di cui il sistema si nutre da tempo. Judith Clark, Maria Luisa Frisa e Olivier Saillard sono tra le migliori menti curatoriali messe a disposizione dell’industria della moda. Nel già citato numero di settembre di questa pubblicazione abbiamo raccontato l’esposizione curata da Saillard che ha aperto in questi giorni al Museo del Tessuto di Prato, i due titani della couture: «Alaïa e Balenciaga. Scultori di forma», un progetto che mira a scolpire l’immaginario. Guardando più indietro, tra le mostre che hanno ridefinito il linguaggio espositivo della moda, «Malign Muses: When Fashion Turns Back», curata da Judith Clark per il ModeMuseum di Anversa e poi approdata nel 2004-05 Victoria & Albert Museum di Londra con il nome edulcorato di «Spectres: When Fashion Turns Back», rappresenta un punto di svolta metodologico e teorico. Lontana da ogni tentazione celebrativa, la mostra, sviluppata in dialogo con i testi di Caroline Evans, esplorava la moda come campo di tensione tra memoria e oblio, tra la fascinazione del passato e la spettralità che accompagna ogni gesto di ripetizione. Clark costruiva un percorso in cui l’abito non era semplice reperto ma apparizione: un frammento di tempo sospeso, un dispositivo narrativo capace di evocare la storia più che di raccontarla. In questo senso, «Spectres» anticipava la sensibilità curatoriale contemporanea, quella che trasforma la mostra in un atto di pensiero visivo, un dispositivo semiotico dove la moda parla di sé attraverso le sue ombre. In epoca recente, una delle mostre più emblematiche e in linea con questo approccio è senza dubbio «Memorabile. Ipermoda», curata da Maria Luisa Frisa, prodotta per il MaXXI di Roma e conclusasi alla fine dello scorso aprile. In questo progetto curatoriale Frisa indaga la dimensione della «iper-moda» come fenomeno culturale e sensoriale, mettendo in dialogo capi d’archivio, video, installazioni sonore e materiali documentari: un percorso che cerca di restituire la moda non solo come oggetto estetico, ma come ambiente vivente, stratificato, carico di memorie superficiali e attuali.

Ipermoda. Photo: Luca Sorrentino. Courtesy Fondazione MaXXI
Ma è con «Uniforme: ordine e disordine», presentata alla Stazione Leopolda di Firenze dal 11 gennaio al 18 febbraio 2001 nell’ambito di Pitti Immagine Uomo, che Maria Luisa Frisa, insieme a Francesco Bonami e Stefano Tonchi, inserisce la nozione di «divisa» (militare, professionale, ideologica) all’interno di una griglia curatoriale che decostruisce la relazione tra ordine e trasgressione nel sistema del vestirsi come dispositivo simbolico. Attraverso un dialogo tra abiti, fotografie, uniformi storiche e sperimentazioni contemporanee, la mostra rivela come l’uniforme non sia soltanto un segno di potere o di appartenenza, ma un dispositivo liminale che oscilla tra identità collettiva e scarto individuale. Qui, Frisa, insieme ai colleghi Bonami e Tonchi, anticipa un tema che attraversa anche l’attuale autunno parigino di mostre di e sulla moda, ovvero la moda come campo di rinegoziazioni, dove gli schemi regolatori (morfologici, sociali, simbolici) vengono continuamente messi in crisi. In «Uniforme», la divisa diventa figura dell’ambiguità e costruisce una tessitura concettuale tra autorità e mutamento, tra reazionario e rivoluzionario, una zona di luci al tramonto che risuona con i percorsi di sovversione estetica che si evidenziano nei progetti espositivi di «Rick Owens: Temple of love» e «Virgil Abloh: The Codes».

Uniforms. Courtesy Pitti Immagine
Il primo progetto, aperto al pubblico lo scorso giugno al Palais Galliera di Parigi (fino al 4 gennaio 2026) è di fatto la prima retrospettiva dedicata al «principe oscuro» della moda. Curata dalla direttrice Miren Arzalluz insieme ad Alexandre Samson e dallo stesso Owens in veste di direttore artistico, la mostra non si limita a esporre abiti ma costruisce un percorso scenografico totalizzante. Gli spazi neoclassici del museo sono stati letteralmente invasi dall’estetica Owens: 30 monoliti di cemento spuntano nel giardino come cenotafi brutalisti, le statue sulla facciata sono velate da tessuti ricamati di paillettes quasi fossero figure in lutto rituale, e all’interno è stata perfino ricreata la camera da letto californiana del designer, completa della presenza totemica della sua amica, compagna, moglie, antitesi e musa Michèle Lamy. Oltre 100 look iconici popolano le sale, affiancati da installazioni inedite, disegni, video, taccuini e persino opere d’arte (da Gustave Moreau a Joseph Beuys) che rivelano le influenze e ossessioni del creatore. Il risultato è a metà tra galleria e reliquiario, travolgente e intimo al contempo: non una semplice sfilata musealizzata, bensì la santificazione dell’universo di Rick Owens, fatto di contrasti, ritualità e bellezza radicale. Il visitatore non si limita a «vedere» abiti, ma viene invitato a sottomettersi a un’esperienza, uscendo con la sensazione che la moda, per Owens, non sia effimera frivolezza bensì qualcosa di quasi liturgico.

Una veduta della mostra «Rick Owens, Temple of Love» al Palais Galliera-Musée de la Mode de Paris. © Gautier Deblonde-Palais Galliera-Paris Musées
Con «The Codes», presentata al Grand Palais di Parigi nel settembre 2025, viene analizzata la carriera di Virgil Abloh. Dopo uno stage nel 2009 presso Fendi insieme a Kanye West, Abloh ha iniziato ad intrecciare musica, arte e moda, fondando nel 2013 il marchio milanese Off-White, da lui definito «l’area grigia tra il nero e il bianco», che ha contribuito alla ridefinizione dello streetwear di lusso. Nel 2018 è stato nominato direttore artistico della collezione uomo di Louis Vuitton, distinguendosi come uno dei pochi designer afrodiscendenti ai vertici di una maison francese, ruolo attraverso il quale ha introdotto codici urbani, cultura pop e rigore concettuale. Scomparso prematuramente nel 2021 all’età di 41 anni, Abloh ha lasciato un’impronta significativa che va oltre il settore della moda, coinvolgendo riflessioni sulla progettualità creativa, sull’ibridazione culturale e sull’inclusione. All’interno delle sale del Grand Palais, la sua presenza viene rappresentata in un percorso curatoriale che supera la retrospettiva tradizionale, proponendosi come dispositivo critico e di approfondimento. L’archivio, disseminato tra moda, architettura, grafica, musica e oggetto d’uso, diventa un campo semantico in cui ogni codice è un gesto sociologico, un’azione di traduzione tra linguaggi e culture. La mostra, concepita come un laboratorio vivo, interroga l’idea stessa di «forma», scardinando la nozione di permanenza che l’archivio tradizionalmente presuppone: il codice non custodisce, ma genera. In questo senso, «The Codes» si pone in una tensione dialettica con «Uniforme: ordine e disordine» (Stazione Leopolda, Firenze, 2001), la mostra in cui Frisa, Bonami e Tonchi, avevano già articolato la divisa come simbolo di potere e controllo, ma anche come potenziale di deviazione, di individualità dentro la regola. Lì, la curatela si faceva pratica di disvelamento: mostrare come la forma (la divisa, il taglio, la ripetizione) potesse contenere la propria sovversione. Abloh, ventiquattro anni dopo, rovescia il paradigma: il «codice» prende il posto dell’«uniforme», la moltiplica e la dissolve in una lettura scomposta, dove l’ordine non è più imposto ma scelto, rinegoziato, remixato. Entrambi i progetti, pur separati da un’epoca e da una semantica, condividono una stessa matrice curatoriale: l’atto di esporre come esercizio critico. Infatti, la parte probabilmente più interessante, risulta essere l’innesto di una parte «commerciale» dentro la mostra stessa. C’è stato un tempo, a Parigi, in cui le urgenze creative dettate dalla curatela degli stilisti nei confronti della loro opera venivano raccolte in uno spazio di vendita, anch’esso curato anziché gestito. Colette non è stato soltanto un indirizzo (213 Rue Saint-Honoré), ma una postura intellettuale. Non è un caso che quell’eco sia ritornato tra le navate del Grand Palais, proprio dentro il racconto su Abloh, dove Colette Roussaux e Sarah Andelman vengono omaggiate con un progetto-installazione che ricostruisce il negozio come fosse organismo curatoriale. Non è una semplice boutique riesumata, ma la dimostrazione di come il commercio possa farsi narrazione, e l’atto dell’acquisto un gesto di lettura estetica. È qui che riaffiora una verità dimenticata: il buyer come curatore ante litteram. Un tempo, la scelta di un capo, di un oggetto, era un atto di montaggio narrativo, un esercizio di composizione che prefigurava la mostra prima ancora della vendita. Ogni pezzo era un segno, ogni disposizione in vetrina un pensiero espresso nello spazio. Colette aveva fatto di questa grammatica un linguaggio, calibrando il visibile come un museo temporaneo dell’adesso.

L’allestimento della mostra «Virgil Abloh: the Code» al Grand Palais di Parigi. Photo: Thomas Razzano/BFA.com. © BFA
Se le mostre di Owens e Abloh hanno portato la moda nel museo, diversi stilisti hanno portato la pratica curatoriale nei loro show. Dario Vitale ha trasformando la sua prima sfilata per Versace in un’esperienza immersiva e narrativa paragonabile a una mostra capace di suscitare emozioni e di disturbare il visitatore sino all’ossessione. Il debutto milanese di Vitale, che ha segnato l’inizio di una nuova era per la maison, dopo la lunga direzione di Donatella Versace, si è svolto in una cornice altamente simbolica: la Pinacoteca Ambrosiana, istituzione culturale di Milano colma di capolavori d’arte antica. Lungi dall’essere un semplice sfondo scenografico, questo luogo ha dettato il tono di una presentazione fuori dagli schemi, quasi declassata: Vitale ha inscenato una sorta di happening decadentista, inserendo nel lussuoso contesto museale elementi di quotidianità disordinata e vissuta. Al centro di una sala affrescata campeggiava un letto sfatto, circondato da bicchieri vuoti, un portacenere colmo e confezioni di pasticche rovesciate a terra, dettagli che suggerivano una narrazione: sesso! Un backstage intimo del glamour. Questo espediente installativo ha creato nel pubblico la sensazione di entrare in una performance artistica più che in una tradizionale sfilata: esattamente come in una mostra curatoriale, lo spettatore è chiamato a decodificare segni e simboli, a chiedersi quale storia venga raccontata attraverso gli oggetti e l’atmosfera. A enfatizzare la dimensione curatoriale della sfilata è stata anche la ricchezza dei riferimenti inseriti dallo stesso Vitale. Il designer ha esplicitamente citato «Teorema» di Pier Paolo Pasolini come metafora narrativa del suo arrivo in Versace. Nel celebre film, l’irruzione di un misterioso ospite in una famiglia borghese sconvolge equilibri e convenzioni, liberando pulsioni sopite. Allo stesso modo, Vitale si è posto come «forza perturbatrice» in casa Versace, intenzionato a scuotere l’establishment del fashion system e della maison della medusa per provocarne, riuscendovi pienamente, un risveglio creativo.

Alcune vedute del set dello show di Dario Vitale per Versace alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano
Se Vitale chiama in causa Pasolini ed espone, Michele utilizza lo stesso autore ma espone sé stesso, lasciando che il proprio disegno diventi megafono di un messaggio più ampio: quello di una moda che nel silenzio ritrova la voce, grazie appunto all’opera di Pasolini. Siamo in un’altra città ma sempre durante le sfilate primavera-estate 2026, a Parigi per la precisione e la collezione è quella di Valentino. È qui che Alessandro Michele si è mostrato non solo come stilista, ma come curatore di un pensiero, riportando la moda dentro la zona a lui più cara: quella in cui il gesto estetico coincide con quello etico. Con «Fireflies», questo il nome della collezione, Michele compie un’operazione di sottrazione, quasi di purificazione. Ha pulito il linguaggio, asciugato la retorica decorativa, per lasciare affiorare la struttura nuda del suo design, quella grammatica di tagli, tessuti e proporzioni che, finalmente, torna a parlare per sé. È un atto di chiarezza, ma anche di coraggio: in un momento in cui la moda strilla la novità del nuovo corso creativo post fashion reset, Michele sceglie di sussurrare. La passerella, immersa in una luce intermittente, è attraversata da un’unica voce: Pamela Anderson, che legge frammenti di Pasolini, tratti dalle Lettere luterane, sulle lucciole, l’invocazione a «disarmare gli occhi e riaccendere lo sguardo». È in quella voce che si condensa la sua curatela: non una celebrazione della nostalgia, ma un atto di resistenza poetica. Le lucciole pasoliniane, simbolo di una bellezza che sopravvive all’accecamento del progresso, diventano metafora di una moda che vuole ancora illuminare, anche solo per pochi istanti, l’oscurità del presente. Michele non cita Pasolini come icona, ma lo convoca come coscienza: fa del testo un filtro attraverso cui interrogare l’immagine, la memoria, il desiderio. Il designer romano trova, con questa sfilata e il progetto a essa collegato, il registro con cui allineare il proprio senso del bello con la bellezza utilizzata, storicamente, come simbolo assoluto dalla maison romana che dirige creativamente da poco meno di due anni.

La collezione «Fireflies» di Alessandro Michele da Valentino a Parigi. Courtesy of Valentino
In pieno controcanto, di minor effetto, ma sempre nella Ville Lumière, il debutto di Duran Lantink per Jean-Paul Gaultier, presentato negli spazi industriali del Musée du quai Branly, propone una riflessione sul concetto di museo, trasformandolo in un backstage urbano. L’evento insegna a ripensare gli ambienti espositivi come parte integrante della città stessa. La sfilata, che è stata accolta da una lunghissima ondata di critiche negative, ha lavorato sulla provocazione non come effetto speciale ma come metodo. «Junior» è sia titolo-chiave sia dichiarazione di intenti che riattiva il lato street del marchio mentre il designer rifiuta programmaticamente di entrare subito in archivio per costruire un’immaginazione autonoma. È l’assenza totale di curatela da parte del giovane designer che restituisce il lessico che Gaultier ha consegnato alla storia (coni spostati e deformati, marinière avvolte a elica, tatuaggi resi tridimensionali, trench smontati), ma filtrato da un’energia dispettosa che spinge il corpo oltre la forma, fino ai bodysuit anatomici e ai pantaloni ridotti a due strisce tese: disturbare i «grandi» è parte del progetto. È qui che Lantink dialoga con l’«enfant terrible» originale: non citazionismo, ma una «dose di veleno contro la nostalgia» che restituisce a Gaultier la sua disobbedienza strutturale. La passerella diventa così un atto sociale ordinato, curato ma non curatoriale. Non vetrina di oggetti, bensì il montaggio di codici e comportamenti, una regia che seleziona, riassembla e mette in frizione iconografie note per far emergere nuovi significati. Metodo, al posto di archeologia. Anche per questo la riapertura del prêt-à-porter, a più di un decennio dallo stop, suona come «un nuovo battito» per la maison: una mostra in movimento dove la storia è materiale vivo, non reliquia.

La sfilata-debutto «Junior» di Duran Lantink per Jean Paul Gaultier nei sotterranei del Musée du quai Branly. Photo: Yannis Vlamos
Tornando alla Milano Fashion Week per qualche istante, è facile creare un link tra la narrazione sul corpo di Lantik e il progetto «Superliquidator» di Sara Leghissa, in collaborazione con il marchio Cormio, una delle idee più intense e politicamente densa di questa edizione. Un’idea che si è configurata come gesto curatoriale radicale, riportando il corpo, la sua vulnerabilità e la sua forza di resistenza al centro del discorso sociale. Più che una mostra o una performance, «Superliquidator» è stato un dispositivo di autodifesa collettiva, costruito a partire da muscoli, memorie e archivi, in opposizione alle norme che determinano chi può o non può difendersi. In un contesto dominato dall’immagine, dal consumo e dalle estetiche del potere, l’opera, prodotta da Beniamino Marini e articolata tra i testi di Elsa Dorlin e Jules Gill-Peterson, ha incarnato una forma di curatela espansa, in cui moda, filosofia e attivismo si sono intrecciati fino a diventare pratica politica e poetica insieme. «Superliquidator» ci ha ricordato che la moda, quando torna a partire dal corpo, può ancora essere un campo di possibilità, una piattaforma capace di generare soggettività nuove e consapevoli, restituendo al corpo il ruolo di primo, irriducibile territorio d’espressione.
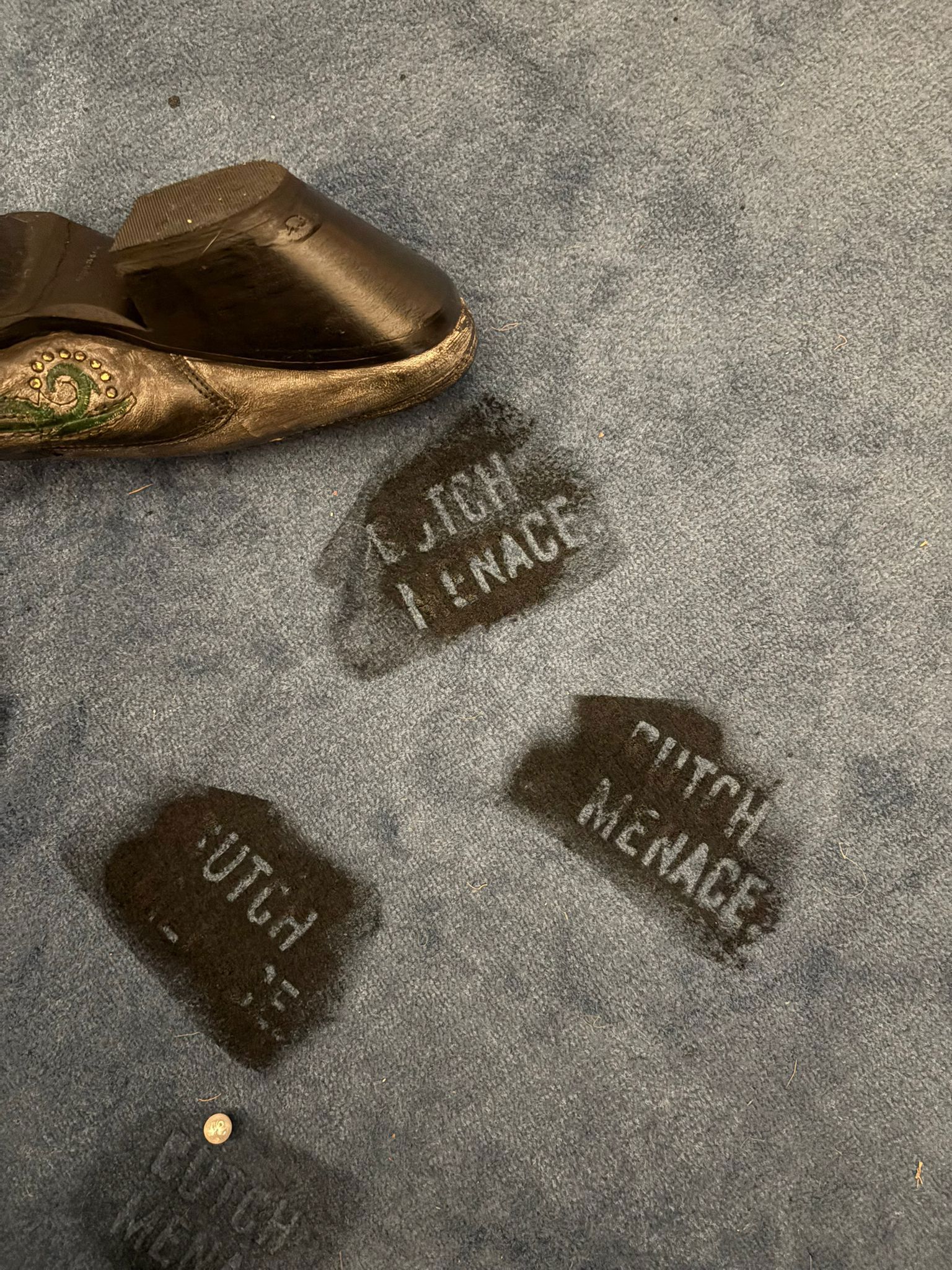
«Superliquidator» di Sara Leghissa in collaborazione con Cormio alla Milano Fashion Week
E quindi, può la moda essere ridotta a mera esperienza?
Risposta retorica a una domanda retorica: NO, perché anche la più pura esperienza d’acquisto contiene un atto di senso, un racconto, una curatela. Il valore culturale di un marchio non determina il prezzo, ma fonda la sua legittimità creativa e commerciale. La moda è un mestiere creativo che non vuole salvarsi, ma continuare a trasformarsi. In un oggi che sembra aver già esposto tutto (archivi, collezioni, memorie, trasgressioni, idee), la vera curatela consiste forse nel togliere, nel lasciare spazio al silenzio tra un abito e lo sguardo. È in quel vuoto attentamente illuminato, tra passerelle, vetrine e sale museali, che la moda può riguadagnare spazio critico; là dove il senso si deposita e il desiderio si rinnova.
Altri articoli dell'autore
Quattro mostre, diverse per tono e ambizione, studiate da altrettanti curatori: Fabiana Giacomotti insegna; Angelo Flaccavento interpreta; Olivier Saillard scolpisce; Demna riassume
Dove la cravatta è più memoria che funzione, più evocazione che necessità
Nata come atto di resilienza contro la banalità, la techno è architettura sonora, pratica sociale, invito al disallineamento. Ne troviamo i segni nella letteratura, nel design, nella moda e nelle arti visive
A Roma, la Fondazione Garavani Giammetti mette in dialogo alcuni abiti firmati dalla maison romana e una selezione di opere d’arte moderna e contemporanea. Il tutto con un’unica parola d’ordine: rosso