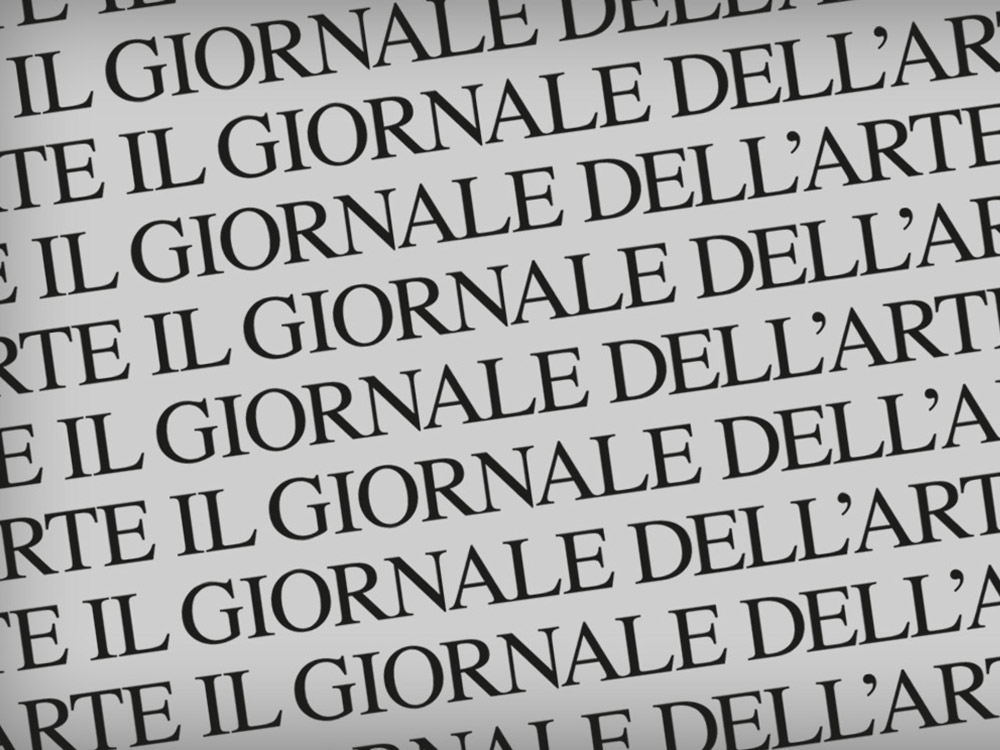Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Redazione
Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI
Si è spenta il 16 agosto a Milano, la città in cui era nata il 15 gennaio 1936, l’artista e designer Amalia Del Ponte. Allieva di Marino Marini all’Accademia di Belle Arti di Brera tra il 1956 e il 1961, Del Ponte aveva iniziato il suo percorso esplorando la materia scultorea più tradizionale, gesso, terracotta, marmo, bronzo, per poi rivolgersi alla trasparenza del plexiglas («volevo ottenere sculture “cangianti”, che cioè perdessero di immobilità e avessero spazi e volumi diversi dai diversi punti di vista», dichiarò) nei celebri «Tropi», così li definì Vittorio Fagone, e alla creazione di ambienti, come «Area percettiva», con cui vinse il Primo Premio della Scultura alla Biennale di San Paolo del 1973, a cui era stata invitata da Bruno Munari e Umbro Apollonio. «Per l’ambiente di San Paolo, dichiarò, sono partita dalla premessa che fosse un’opera fatta per accogliere al suo interno e non per essere guardata. Per entrarci si passava da una stretta fessura e ci si trovava avvolti da una luce intensa, diffusa e senza ombre, che annullava lo spazio per sorprendere il pensiero, per far riaffiorare l’ineffabile».
Sin dall’inizio degli anni Sessanta, il suo lavoro ha esplorato lo spazio e la luce, fondendo poesia e rigore scientifico in una ricerca pionieristica per il suo tempo. La sua grande curiosità l’ha portata a evolvere il suo linguaggio e la sua ricerca fino alle sperimentazioni sul suono, con i «Litofoni» in pietra, e ad affrontare i temi dell’esistenza tramite installazioni, performance, libri, disegni e video, in un lavoro che resta sempre profondamente legato alla forma scultorea, dalle arti visive al design. Ha progettato infatti gioielli, ma anche interni di negozi (a Milano Gulp! e il primo punto vendita Fiorucci) spazi concepiti come scenari, colmi di riflessi e sorprese visive. «Ho rifiutato la strada delle gallerie e lo rifarei, con il rovescio della medaglia. Al contratto con la galleria ho preferito lavorare come designer», ricordava in un’intervista a «Domus» nel 2018, spiegando anche il suo rifiuto a legarsi a un gruppo (a Milano nel 1959 nasceva il Gruppo T Gruppo T e a Padova il Gruppo N): «Una specie di ansia di essere libera mi ha fatto fare questa scelta, credo sia un fatto di temperamento».
È il 1977 quando Lea Vergine la chiama, insieme ad altre artiste impegnate sul fronte del femminismo a «Expò Arte. Ipotesi ’80», allestita alla Fiera del Levante di Bari. Del Ponte presenta «Culturae: florum omnium varietas (Nascita)», opera dedicata a sua figlia: una riflessione sulla natura della donna e sul privilegio di poter generare.
Nel 1986 Arturo Schwarz la invitò a partecipare alla Biennale di Venezia intitolata «Arte e Alchimia». Alla domanda del curatore: «Quanto è importante per il suo lavoro quotidiano il rapporto tra alchimia e arte?», Del Ponte rispose: «La ricerca dell’alchimista non credo sia diversa da quella dell’artista, se questa è una proiezione a livello inconscio della psiche. Oppure, l’alchimista è artista quando cerca di scoprire l’essenza della materia e la riproduce intervenendo nei fenomeni chimici in tempi per così dire “umani”. […] La coscienza si rivolge all’interno, il nostro centro più profondo riscopre la propria sostanza. Come l’alchimista purifica il corpus da tutte le superfluitates, esponendolo al fuoco più ardente, lo scultore progressivamente a colpi di subbia, con un paziente lavoro di “togliere”, fa emergere la forma e insieme svela la materia del proprio immaginario. Nell’alchimia si giunge alla purificazione o mundificatio attraverso molteplici distillazioni; per la scultura un continuo sforzo per far affiorare il profondo alla superficie».
Alla Biennale sarebbe tornata nel 1995, su invito di Gillo Dorfles. Nella sala a lei dedicata nel padiglione italiano, Del Ponte crea un «ambiente performativo»: qui, accanto al litofono del 1993 «Acqua nell’acqua», allestisce l’installazione «Musica in gocce», un percorso composto da ventotto dischi marmorei posti a terra e accompagnati da un brano di David Ryder composto per l’occasione campionando il suono di ciascuna goccia.
Nonostante le tante mostre in spazi pubblici e privati (la prima, nel 1965, alla Galleria Adelphi di Padova, dal titolo «Dalla Teoria della Natura di J. W. Von Goethe. Ricerche in plexiglass/Opere moltiplicate»; l'ultima, «Amalia Del Ponte. Appear by Disappearing», a cura di Roberta Tenconi, nel 2024 alla Galerie nächst St. Stephan-Domgasse di Vienna) bisognerà attendere fino al 2017 per la prima panoramica completa del lavoro di Del Ponte, «Onde lunghe e brevissime», a cura di Eleonora Fiorani e Iolanda Ratti e suddivisa tra il Museo del Novecento e lo Studio Museo Francesco Messina.
La notizia della scomparsa è stata diffusa dall’Archivio Amalia Del Ponte, che così la ricorda: «Un’artista che ha saputo permeare la materia di pensiero, trasformando scultura e spazio in esperienze sensoriali, in dialogo continuo tra arte, scienza, suono e luce. Milano e il mondo dell’arte perdono oggi una voce feconda, capace di dar forma all’invisibile, che continuerà a ispirarci».

«Area percettiva», l’ ambiente con cui Amalia Del Ponte nel 1973 vinse il Primo Premio Internazionale della Scultura alla Biennale di San Paolo. Foto courtesy Archivio Amalia Del Ponte
Altri articoli dell'autore
Ai Mercati di Traiano uno spaccato di Roma nel 1350, tra storia, arte, politica e devozione
Per il sesto appuntamento della serie di approfondimenti dedicati alle mostre della 15ma edizione di Cortona on The Move, un focus su «Atlas of the New World»
È un confronto multidisciplinare sull’impatto concreto dell’intelligenza artificiale nei settori chiave dell’economia e della società
Provenienti da una collezione privata subalpina, erano stati sequestrati nel 1991 nel corso di un’indagine su scavi clandestini in Toscana. Gli eredi hanno deciso di riconsegnarli allo Stato