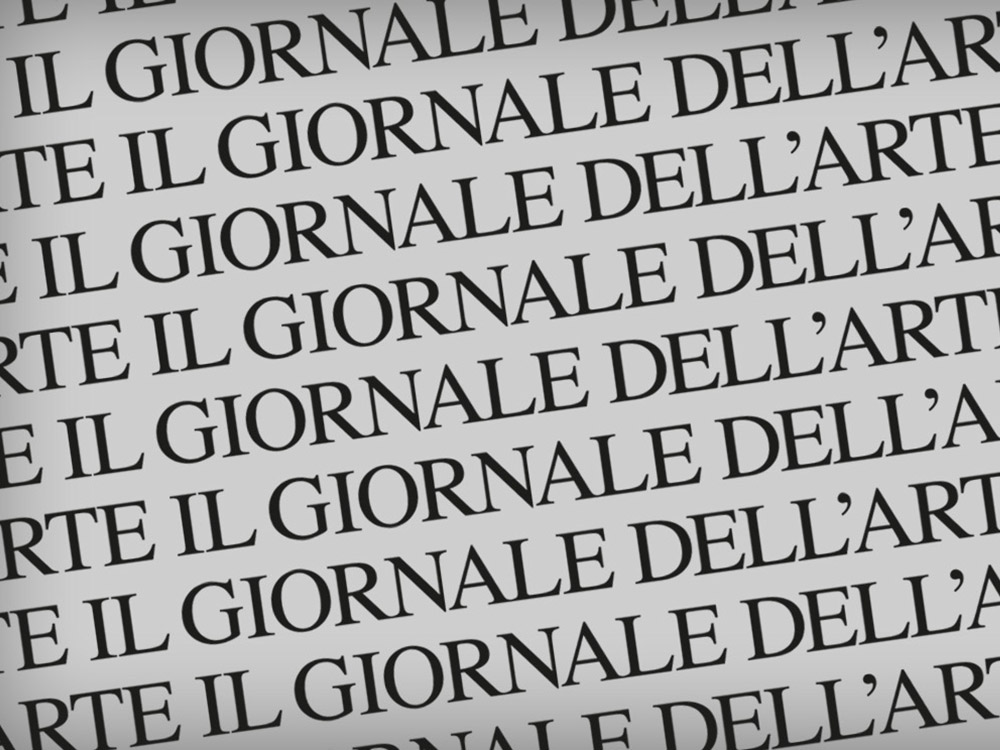Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Arabella Cifani
Leggi i suoi articoliProbabilmente ci sono molte opere del grande pittore lombardo ancora sconosciute (o diversamente attribuite) sepolte nei musei. Dopo decenni di meticolose ricerche, uno studioso propone 79 «casi»: presunte o possibili opere, finora non identificate e tutte da discutere, del periodo giovanile pochissimo conosciuto e indagato. La sfida di Franco Moro
Nell’ottobre di quest’anno ha visto la luce un nuovo volume (Allemandi) dedicato a Caravaggio che alimenterà l’inesausta passione che gli storici dell’arte di tutto il mondo, ma anche i cultori della materia, nutrono per il pittore. Negli ultimi decenni Caravaggio si è ritrovato al centro di infinite trame artistico-letterarie fino a divenire quasi insopportabile: all’annuncio della scoperta dell’ennesimo suo quadro gli esperti e studiosi si armano di spada e corazza e incominciano a menarsi botte da orbi, spesso senza venirne a capo.
Che cosa ci manca ancora su Caravaggio? Per esempio, mancano delle meditazioni attente e approfondite sulla sua giovinezza e sulla sua formazione; non si tratta certo di pochi anni, poiché Caravaggio nacque a Milano il 29 settembre del 1571 e a Roma la sua presenza è documentata per la prima volta solo fra la fine del 1595 e l’inizio del 1596: a ventiquattro anni si era allora uomini e artisti fatti e la formazione di base era compiuta; c’è quindi da riempire tutta la prima giovinezza, sapere quali botteghe avesse frequentato, oltre quella di Simone Peterzano ricordata dalle fonti, che cosa abbia visto, quali i suoi rapporti culturali e religiosi, i viaggi. A Roma arriva un artista formato, colto, che sa disegnare, conosce la prospettiva, l’anatomia: tutto questo dove, quando e come è successo? Insomma, Caravaggio chi è veramente?
Franco Moro, storico dell’arte indipendente i cui studi hanno sempre rivolto una particolare attenzione nell’integrare l’attività pittorica e grafica degli artisti presi in esame, propone alcune risposte a questi interrogativi. Da esse emerge l’ipotesi di nuove attribuzioni a Caravaggio per oltre trenta disegni e altrettante tele, soprattutto ritratti, che vagano orfane e derelitte all’interno di musei di tutto il mondo (spesso parcheggiate nei depositi) o in collezioni private. È chiaro che un libro di questo genere richiede un grande coraggio essendo destinato a produrre sconquasso: Franco Moro non la passerà liscia. Lo studioso ci deve essere abituato e infatti non si è mai fatto mancare nulla nel settore delle ricerche di storia dell’arte: indipendente, si è occupato in prevalenza di argomenti inesplorati, focalizzando le sue attenzioni su maestri della rinascenza padana ma anche su pittori sei-settecenteschi romani, napoletani, veneti e liguri. Lo abbiamo dunque intervistato, per sapere direttamente da lui che cosa ha voluto comunicarci con questo impegnativo lavoro.
Franco Moro, perché proprio Caravaggio? Da quanto tempo lo studia e come ha incominciato?
Non ho mai studiato Caravaggio in modo ufficiale, mai frequentato convegni, non mi sono mai posto obiettivi; in realtà ho sempre vissuto con Caravaggio nella testa. Questa ricerca in particolare è nata quasi per caso, grazie a una intuizione, dopo aver visto e lungamente meditato le fotografie di quattro ritratti anonimi ma fra loro collegati da una qualità per me stupefacente. Una volta raggruppati, i quattro ritratti (uno di essi è la copertina del libro) hanno cominciato a parlarmi, a svelare il loro codice segreto e a definire una personalità artistica importantissima, con spiccate caratteristiche proprie che nella mia mente progressivamente si è disegnata come quella di Caravaggio giovane, proprio di quel Caravaggio ricordato da tutte le fonti come autore per parecchi anni in terra lombarda di ritratti perduti o non riconosciuti. La ricerca mi ha occupato in modo totalizzante per almeno sei anni di studi, svolti in assoluto silenzio e riservatezza. Non ho voluto divulgare alcuna notizia su quanto stavo facendo fino alla fine del lavoro. Il libro culturalmente è stato chiuso nel 2013, ma in seguito ho trovato altri elementi di studio e novità per le mie ipotesi. Tutto questo lavoro si regge pertanto come una sorta di carpenteria che traccia la figura di un singolare pittore anonimo della fine del Cinquecento il quale ha tangenze precise solo con il Michelangelo Merisi giovane e che pertanto ho ritenuto del tutto ragionevole identificare in lui.
Qual è il suo metodo di lavoro, come è giunto alle sue ipotesi di attribuzione?
Il libro non è il prodotto delle ricerche di un mero conoscitore e attribuzionista, ma vuole portare alla luce una serie di aspetti poco conosciuti del Caravaggio. Mi sono stati certo di guida Giovanni Morelli, Bernard Berenson, Adolfo Venturi, Roberto Longhi e Federico Zeri, con i loro metodi di lettura delle opere d’arte, ma i quadri anonimi sono stati da me attribuiti dietro ragionamenti precisi e personali: i quattro ritratti iniziali sono divenuti otto e poi sono cresciuti di numero, legandosi l’uno all’altro stilisticamente in modo inestricabile. Dai quattro ritratti anonimi ho intrapreso una minuziosa perlustrazione di cataloghi di musei, ho studiato fotografie ad alta definizione, ho fatto verifiche dirette nelle collezioni private e nei musei, soprattutto nei depositi, dove si trovavano molte opere considerate. Il principale filo conduttore è stata l’indagine psicologica particolarissima che il pittore realizza nei propri ritratti. Caravaggio è infatti un lettore eccezionale non solo degli elementi fisiognomici esterni ma soprattutto degli stati d’animo che delinea sulla tela in modo inconfondibile. Anche altri pittori sono stati in grado di cogliere questo aspetto, ma solo Caravaggio sa tirare fuori l’anima dei suoi soggetti con un lavoro unico sull’intensità degli sguardi, con uno scandagliamento dell’interiorità della persona ritratta che appartiene solo a lui. La caratteristica principale in tutti i quadri considerati è stato lo sguardo. L’artista percepisce gli sguardi sempre allo stesso modo; il poeta Giovanni Battista Marino affermava che Caravaggio lo aveva ritratto così profondamente al punto che la tela rappresentava «un altro me stesso».
Per raggiungere questi risultati il giovane pittore doveva essersi guardato attorno in modo molto acuto e al naturale talento aveva accoppiato lo studio della pittura fiamminga con la sua attenzione per i dettagli. Segnatamente, a mio parere, aveva meditato le opere di Anthonis Mor e Hendrick Goltzius, pittori che costituiscono suoi precisi riferimenti, conosciuti forse anche dal vero, ma di certo tramite le incisioni che a fine Cinquecento circolavano assai facilmente a Milano, città in grande fermento economico, culturale e religioso sotto la dominazione spagnola, con molti collezionisti e intellettuali. Arcimboldo, Vincenzo Campi, ma anche le botteghe artigiane di intagliatori di cristalli, i maestri cesellatori di metalli, i celebri armorari: tutto dev’essere stato oggetto di sua indagine e osservazione. Ritengo che abbia avuto rapporti stretti con Ambrogio Figino che ho guardato con particolare attenzione come «radice culturale» di Caravaggio. A differenza di altri studiosi penso che, nonostante il contratto del 6 aprile 1584 con il quale il dodicenne Michelangelo Merisi entrava in bottega da Peterzano per quattro anni, l’apprendistato sia durato di meno, e che dopo due anni, al massimo due mezzo, il Caravaggio sia passato ad altra bottega, dal Figino forse, o addirittura spostandosi a Bergamo presso Gian Paolo Lolmo, non mancando di studiare anche i ritratti di Giovanni Paolo Cavagna. Naturalmente, come usava al tempo, i lavori eseguiti in bottega dagli allievi venivano venduti come opera del maestro, ragione per cui anche i suoi ritratti sono restati confusi nella gran massa della ritrattistica lombarda coeva.
Come ha usato le fonti storiche e archivistiche, che cosa ne ha ricavato?
Le fonti storiche e archivistiche attendibili sono state da me accuratamente perlustrate e hanno costituito la base ferma del mio lavoro. Da esse si evince in modo inequivocabile che Caravaggio fin dalla giovinezza milanese dipinse ritratti. I suoi biografi parlano di ritratti eseguiti anche nel periodo romano e Bellori segnala opere, oltre quelle di tale genere nella collezione Giustiniani.
I ritratti segnalati nelle grandi collezioni sono in realtà rari poiché Caravaggio dopo i noti fatti di Malta venne condannato dall’assemblea dei Cavalieri dell’1 dicembre 1608 all’espulsione dall’ordine (dove era stato ammesso solo nell’agosto del 1608) come membro «putrido e fetido». Fu una damnatio memoriae che ebbe conseguenze fatali e immediate, fra cui la fuga e la morte precoce dell’artista, ma anche destinate a durare nel tempo: le grandi famiglie che possedevano sue opere vollero dimenticarne l’attribuzione condannandolo all’oblio.
Le fonti storiche mi hanno suggerito anche altri spunti di ricerca, come quello dei viaggi: la dibattuta sua presenza a Venezia è, a mio parere, una certezza. Ma il pittore fu anche probabilmente a Padova e questi soggiorni in terra veneta si collocano fra 1588 e 1592, ultimo anno di permanenza documentata a Milano.
L’Università di Padova era un eccezionale polo di attrazione culturale: nel 1592 vi arriva Galileo (i due si conobbero?), vi operavano molti scienziati, medici illustri, intellettuali come Paolo Sarpi. A Padova lavorava anche il raro pittore Francesco Apollodoro detto il Porcia, ritrattista legato agli ambienti universitari; Caravaggio fu forse per un certo tempo suo allievo e collaboratore o comunque lo conobbe (l’ipotesi sarà da suffragare con documenti d’archivio). Il Porcia era un discreto ritrattista, rude e sanguigno, che tentava di ripercorrere la tradizione veneziana dei grandi maestri, dallo stile del quale Merisi si distingue per sensibilità e intensità. Fra i possibili influssi padovani è da aggiungere anche la meditazione delle opere di Giovanni Busi detto il Cariani e di Lambert Sustris. È a Padova, con tutta probabilità, che Caravaggio elabora culturalmente e religiosamente il linguaggio delle audaci e modernissime pale dall’altare che tanto scandalizzeranno Roma.
Nel libro vi è una precisa indagine sui disegni di Caravaggio.
Consultando libri su Caravaggio mi è capitato un disegno del Castello Sforzesco, attribuito a Peterzano ma a mio parere facente invece parte di tutto quel filone di ritrattistica su cui avevo puntato la mia attenzione. Dopo questo preciso caso ho incominciato a guardare con attenzione i disegni notando che quelli che ritenevo suoi avevano una qualità molto più morbida. Ho trovato altri fogli all’Ambrosiana: tutti caratterizzati da uno stile vigoroso e morbido e da una grafia estremamente emozionale. Un foglio del Castello Sforzesco si è rivelato lo studio per un ritratto di gentiluomo dell’Accademia Carrara di Bergamo che ritengo di Caravaggio. Sono poi seguiti i recuperi di disegni anonimi fra i quali ho identificato fogli preparatori per la «Conversione di san Paolo» Odescalchi, per uno dei musici del Metropolitan Museum di New York e per molte altre opere importanti pubblicate nel volume. Particolare significato ha per me lo studio per la testa di Marzio Colonna dell’Ambrosiana che corrisponde a un ritratto anonimo del Rijksmuseum di Amsterdam che attribuisco a Caravaggio. Vorrei sottolineare che le fonti ricordano che Marzio Colonna era amico di Caravaggio e che lo ospitò nei feudi di Palliano e Palestrina dopo l’omicidio del 1606: un legame provato.
Non mi sono invece occupato del cosiddetto Fondo Peterzano del Castello Sforzesco (che conosco assai bene), perché ritengo che non vi sia nessun disegno di Caravaggio.
Si rende conto di quanto i suoi studi siano «pericolosi»? Chi tocca Caravaggio senza le dovute autorizzazioni accademiche muore.
Sì, mi rendo conto, ma il problema riguarda in generale tutti i grandi pittori: chiunque proponga su di essi novità senza appartenere alle ristrette cerchie dei pochi che si considerano depositari della sapienza su questo o quell’artista rischia di essere messo alla berlina. Ritengo di aver trovato un bandolo dell’intricata matassa di questi ritratti giovanili, al di fuori di quanto era stato detto e pensato fino ad ora. Non potevo esimermi dal portare avanti queste ricerche che mi sono cresciute fra le mani, quasi indipendentemente da me stesso: è stata una ricerca per me straordinaria e irripetibile. Se mi criticheranno, pazienza.
Nel mondo accademico spesso non ci si ricorda che i grandi artisti sono stati giovani sconosciuti: erano ragazzi come gli altri, solo con molto più talento. Caravaggio trascorre la sua vita con altri apprendisti pittori, immerso nella vita delle botteghe milanesi in un continuo viavai di dipinti. È un nostro dovere essere capaci di distinguere le sue opere prime e farle emergere.
La qualità dei dipinti (anche quelli di Caravaggio da me attribuiti) è data, in generale, da un insieme di tante cose, di emozione, esperienza e conoscenza e se uno storico dell’arte non riesce a distinguere questa qualità i suoi studi e l’arte stessa diventano un indomabile mare in tempesta e i dipinti diventano barriere impenetrabili. Il potere fa il resto, soprattutto in Italia quando uno studioso pensa di avere conquistato un argomento lo vuole possedere solo per sé. Bisognerebbe insegnare nelle scuole e nelle università a distinguere fra pittori modesti e maestri, fra quadri minori e capolavori: in Italia tutto viene trattato allo stesso modo. Insegnare a capire la diversa qualità delle opere d’arte è uno degli scopi, a mio parere, degli studi di storia dell’arte, ma purtroppo gli ultimi trent’anni in questo settore hanno visto soprattutto fallimenti e regressioni. Voglio precisare, infine, che tutti i quadri che ho pubblicato sono opere di pittori della fine del Cinquecento che conosco profondamente, fin da giovanissimo: sono artisti che ormai ho profondamente dentro di me, che ho studiato, visto, considerato in ogni dettaglio. Dietro a questo volume ci sono anni e anni di studio. Potranno dirmene di tutti i colori, ma so di avere studiato e ponderato bene ogni parola e sono convinto di quanto ho scritto.
Questo libro è nato dunque dallo studio diretto delle opere e degli aspetti meno evidenti e nascosti di Caravaggio e del suo ambiente giovanile, da un confronto preciso, ogni volta che fosse possibile, fra disegni e quadri ed è un lavoro faticoso condotto con onestà in un territorio finora poco frequentato perché impervio e difficile: eppure la comprensione e il riconoscimento dello stile e delle prime opere giovanili di Merisi, precedenti l’arrivo a Roma costituiscono una parte fondamentale e imprescindibile dell’arte del sommo pittore. Ipotesi spinosissime che sicuramente stimoleranno discussioni accese e inedite. L’autore ha dimostrato un notevole coraggio per essere entrato in una gabbia di storici dell’arte pronti a sbranarlo. Caravaggio infatti viene considerato da alcuni studiosi un territorio privato e invalicabile.
Torna qui utile ricordare l’insegnamento di Karl Popper: «L’inconfutabilità di una teoria non è (come spesso si crede) un pregio, bensì un difetto. Ogni controllo genuino di una teoria è un tentativo di falsificarla, o di confutarla. La controllabilità coincide con la falsificabilità; alcune teorie sono controllabili, o esposte alla confutazione, più di altre; esse per così dire, corrono rischi maggiori» (in: Filosofia e pedagogia dalle origini a oggi, vol. 3, p. 615, Brescia 1986).
Altri articoli dell'autore
Con l’avvento del Cristianesimo, tra il Tardo Medioevo e il Rinascimento le opere ritraevano le vittime preferite dalla «Nera Signora», giovani e belle, come i quaranta ragazzi la cui vita è stata prematuramente stroncata in un momento di festa
Da Pompei al Medioevo, da Masaccio a Caravaggio e Correggio, da Rothko a Kiefer, dai giardini all’architettura fascista in Africa, e poi Piero Manzoni, la porcellana, Shirin Neshat...
Il capolavoro del Museo di Capodimonte altro non è che il racconto semplice della nascita di Cristo
Un’inchiesta fra scrittori, esperti, studiosi e conservatori di musei nazionali e internazionali rivela che la storia dell’arte è un gioco troppo bello per essere lasciato solo agli storici d’arte