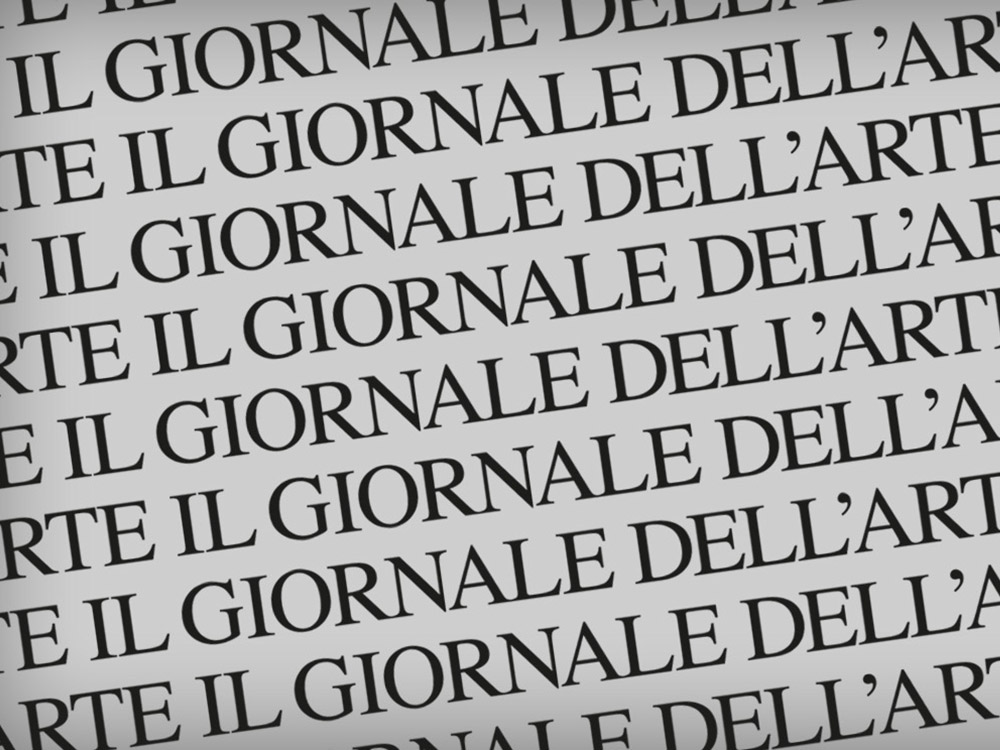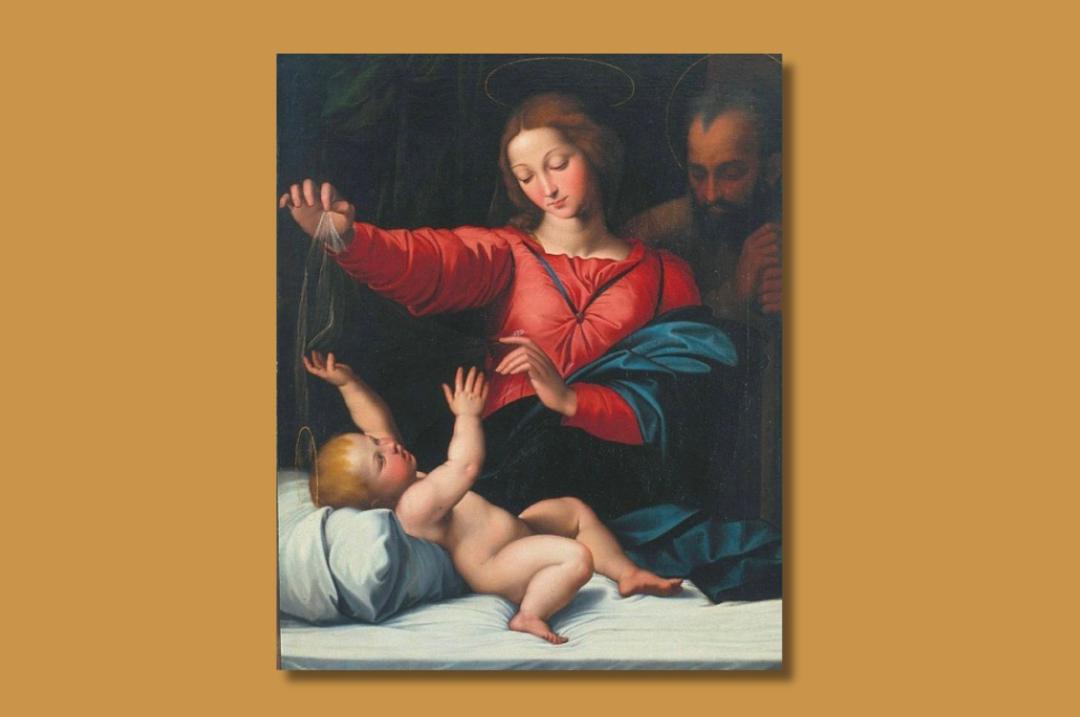Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia «Leonardo da Vinci», uno dei fiori all’occhiello della cultura milanese per la qualità delle sue raccolte e della sua offerta culturale (500mila i visitatori nel 2015), sta completando un processo di ampliamento e riorganizzazione dei suoi spazi, che trova il punto focale nel recupero delle Cavallerizze, presentate il 14 marzo alla città.
Già monastero Olivetano del XVI secolo, soppresso nel 1805 per decreto napoleonico e convertito in ospedale militare, poi subito in caserma, tra il 1844 e il 1855, sotto gli Austriaci, furono eretti otto nuovi edifici con la funzione di Cavallerizze, che nel 1943 subirono danni devastanti, come pure il complesso monumentale. Questo fu immediatamente risarcito, tanto che nel 1953 vi si poté inaugurare il museo, fondato dall’imprenditore Guido Ucelli di Nemi, mentre le Cavallerizze rimasero in uno stato di totale abbandono e solo ora sono state radicalmente riqualificate, grazie al Segretariato regionale del Mibact (già Direzione regionale), che ha diretto l’intervento insieme al museo, e lo ha finanziato con 4,2 milioni, cui si sono aggiunti gli 1,8 milioni reperiti dal museo stesso. Sono 1.800 i metri quadri (un volume unico, articolato in ambienti tra loro collegati) regalati al museo dalle Cavallerizze «risanate», destinati a nuove aree espositive e servizi museali e per ora, in attesa dello spostamento dell’ingresso del museo da via San Vittore a via Olona, a mostre, installazioni e grandi eventi, come l’ospitalità ad alcuni dei Paesi presenti alla XXI Triennale (2 aprile-12 settembre), con cui le Cavallerizze hanno debuttato.
Il progetto architettonico, affidato nel 2006 ad AR.CH.IT Luca Cipelletti, studio specializzato in interventi museali, ha creato un percorso lineare lungo 80 metri e alto 9, che s’innesta sulla crociera dei due chiostri olivetani, congiungendosi con essi. Condotto con filologica attenzione, il recupero ha salvaguardato, là dove si erano conservati, gli elementi salienti dell’architettura originaria, ha integrato ciò che era gravemente danneggiato, rispettando materiali e proporzioni originali, e ha edificato un nuovo spazio al centro, dove le bombe avevano sbriciolato due dei corpi originari. Grandi serramenti rivestiti di legno di bambù, con tagli vetrati, chiudono le facciate nuove, e se il resto degli esterni ha una dominante color antracite, gli interni sono giocati sul bianco delle strutture metalliche e sul grigio chiaro del cemento della lunga parete di fondo e del pavimento, accesi solo da dettagli in laterizio. L’illuminazione è stata curata con Alberto Pasetti e tutti gli impianti sono stati alloggiati in un unico elemento aereo longitudinale.
Altri articoli dell'autore
L’artista attiva nella scena contemporanea del Sudafrica torna da Monica De Cardenas con tutte opere inedite: immagini di interni popolate dalla sua amata natura, ritratta con colori densi e vivi
Frutto dell’accordo siglato nel 2024 con la Pinacoteca di Brera, «L’Arte che cura» porta opere delle collezioni del museo in un luogo di sofferenza per offrire conforto ai pazienti e a tutto il personale sanitario. La rivisitazione seicentesca della «Madonna del velo» apre le danze
Il 28 giugno prenderà avvio la sesta edizione del progetto lanciato dalla Fondazione Elpis nel 2020: a conclusione delle proprie residenze artistiche, venti artisti italiani e internazionali mostreranno le proprie produzioni site specific elaborate a stretto contatto con gli abitanti locali
È stato presentato il progetto di massima del restauro architettonico e della rifunzionalizzazione dell’edificio di Brixia, che sarà valorizzato da Chipperfield in quanto «sito archeologico, manufatto e luogo nato con l’originaria funzione di ospitare l’attività teatrale»