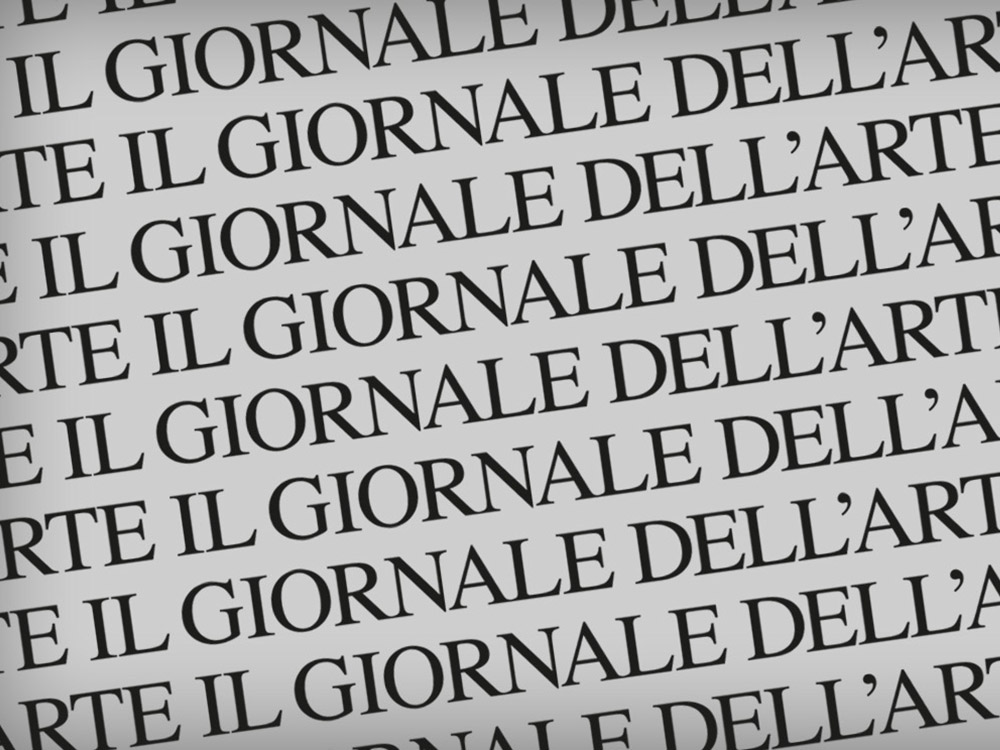Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Laura Lombardi
Leggi i suoi articoli<!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; line-height: 11.0px; font: 8.5px 'Swift Neue LT Pro'} span.s1 {font: 8.5px 'Franklin Gothic Std Condensed'; color: #414141} span.s2 {font-kerning: none} span.s3 {font: 8.5px Helvetica; font-kerning: none} span.s4 {font: 8.5px 'Franklin Gothic Std Condensed'; font-kerning: none} -->
Dall’antico a Picasso, lo scultore e i suoi modelli
Pistoia capitale della cultura 2017 offre l’occasione per fare il punto su un protagonista dell’arte del Novecento, alla luce degli studi critici degli ultimi decenni. «Marino Marini. Passioni visive» a Palazzo Fabroni (fino al 7 gennaio) a cura di Barbara Cinelli e Flavio Fergonzi, evidenzia i legami tra le invenzioni plastiche di Marini (Pistoia, 1901 - Viareggio, 1980) e i grandi modelli della scultura del Novecento, ma anche dei secoli passati, dall’antichità egizia all’Ottocento, cui l’artista toscano, come altri della sua generazione, si riferì, pur sovvertendo i canoni estetici della tradizione.
Si parte dai busti degli esordi, affiancati a canopi etruschi e a busti rinascimentali, per proseguire, alla metà degli anni Trenta, con la stilizzazione dei corpi che risente del linguaggio medievale: in mostra è un «Crocifisso» trecentesco appartenuto a Marini accanto a un «Icaro» e a due «Giocolieri». Vengono poi i ritratti con la riscoperta della volumetria pura dell’arte egizia, e i «Cavalieri», arcaici, impassibili. Per le «Pomone» Marini si volge al classicismo postrodiniano; verso il 1940 medita sul corpo femminile come forma astratta, e qui sono proposti confronti con nudi di Ernesto De Fiori e di Aristide Maillol.
Altro accostamento è con Germaine Richier, quando Marini, nel suo esilio in Svizzera durante la seconda guerra mondiale, guarda al realismo esasperato di Donatello (in mostra è il «Niccolò da Uzzano», in prestito dal Bargello). Nelle sale dedicate al secondo dopoguerra i «Cavalieri» si richiamano ai modelli delle civiltà del Mediterraneo e dell’antica Cina, e nei ritratti gli echi della scomposizione cubista e della deformazione espressionista giungono a esiti di grande potenza e originalità. Infine le opere in cui il soggetto quasi irriconoscibile è mero pretesto per una ricerca spaziale, come nel cavaliere disarcionato e nei «Miracoli».
Negli anni Cinquanta e Sessanta il ricordo delle sperimentazioni di Picasso e di Moore convive con memorie di Giovanni Pisano. La mostra, realizzata in collaborazione con la Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e con la Camera di Commercio di Pistoia, si avvale di un comitato scientifico composto da Philip Rylands, Salvatore Settis, Carlo Sisi e dal direttore della Fondazione Marino Marini, Maria Teresa Tosi, che ha proposto la rassegna, organizzata in collaborazione con la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, dove si trasferirà dal 27 gennaio al primo maggio 2018.
Altri articoli dell'autore
Un’intera sala è dedicata al massimo scultore in cera attivo nel capoluogo toscano a fine Seicento: Gaetano Giulio Zumbo
La mostra a Pisa curata da Francesca Dini ripercorre lo sfavillante periodo, a fine Ottocento, in cui Parigi era il centro culturale del mondo. E tra i protagonisti di quel nuovo clima, gli artisti italiani che scelsero la capitale francese come patria d’adozione, tra cui Boldini, De Nittis e Corcos
Nel bicentenario della nascita, i suoi dipinti sono messi a confronto con quelli di altri protagonisti della pittura del Risorgimento, da Giovanni Fattori a Silvestro Lega e Telemaco Signorini
È stata inaugurata la mostra «Icone di potere e bellezza» con le tre teste in bronzo dorato del Museo di Santa Giulia a Brescia, secondo capitolo dello scambio di manufatti tra le due istituzioni gestito da Fondazione Brescia Musei