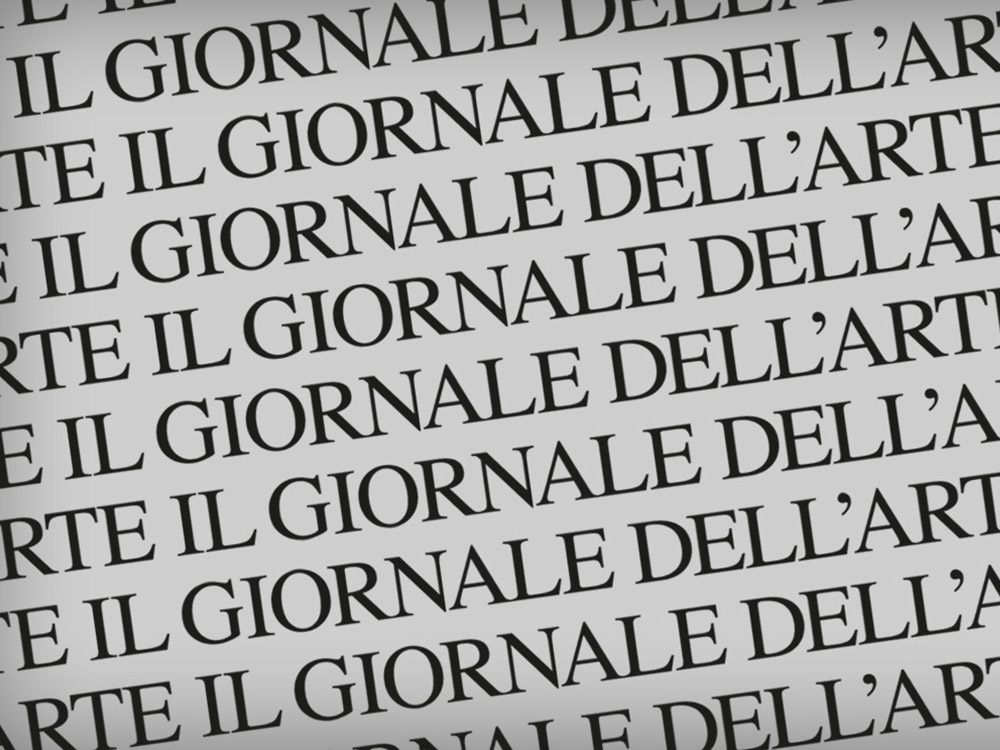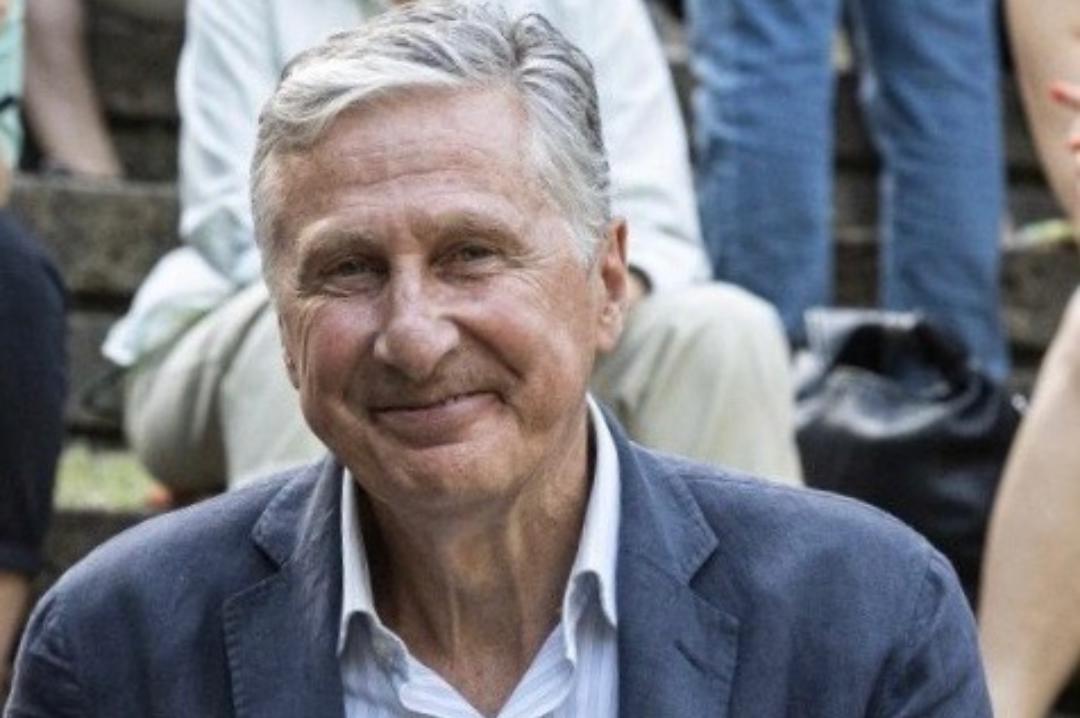Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Laura Lombardi
Leggi i suoi articoliTorna temporaneamente a casa la «Madonna con Bambino» di Andrea di Nerio (documentato ad Arezzo dal 1331-ante 1387), prestata dall’attuale proprietario, l’antiquario Giovanni Sarti residente a Parigi, per essere esposta fino al 31 gennaio al Museo Casa Ivan Bruschi, nel ciclo «Ritorni» promosso dalla Fondazione Bruschi, con la consulenza scientifica di Carlo Sisi e curata da Isabella Droandi.
Datata al quarto quinto decennio del XIV secolo, la tavola mostra la sensibilità raffinata ma al tempo stesso «intimistica e solenne», nota la Droandi, di un artista che seppe cogliere spunti dalla lezione giottesca, ma fu attento anche a quanto avveniva tra Firenze e Siena, con Pietro Lorenzetti, Bernardo Daddi, Maso di Banco, «fino al giottesco “irregolare” Buffalmacco»: un clima culturale che diede vita a una scuola di pittori locali di buon livello tra cui il giovane Spinello, che si ricorderà di Andrea e della sua tradizione nella «Madonna in trono con Bambino» del Museo di Città del Messico dipinta a Lucca all’inizio degli anni Ottanta. Passata da Colnaghi (Londra) nel 1954-55 alla collezione Jeremy Harris (Oxnead Hall, nel Norfolk), l’opera di Andrea di Nerio fu presentata agli studi per la prima volta da Luciano Bellosi (1965) riferendola all’attività giovanile di Spinello Aretino degli anni Settanta e confrontata con due tavolette, «Storie di san Giovanni Battista» conservate nel Kunstmuseum di Berna.
E se già nel 1969 Ferdinando Bologna suggeriva di leggervi invece un «antefatto di più antica cultura», precedente quindi a Spinello, la scoperta di Anna Maria Maetzke nel 1974 della firma nascosta «Andrea f (ecit)» sulla tavola dell’«Annunciazione» del Museo Diocesano di Arezzo (durante il restauro) consentì di ascrivere l’intero gruppo di opere ad Andrea di Nerio, dando il via a più approfonditi studi sulla pittura aretina prespinelliana.
Nella «Madonna» si colgono riferimenti alla tavola di Pietro Lorenzetti conservata nella Pieve di Santa Maria (1320-24), dove tuttavia, specie nel gesto della mano della Vergine che sorregge il Bambino, si nota la differenza tra il piglio più drammatico impresso dal senese alla quieta fermezza scelta da Andrea, e si perde anche il serrato colloquio di sguardi tra madre e figlio, caro ai Lorenzetti e, in scultura, a Giovanni Pisano.
Pur nei riferimenti all’attività aretina di Buffalmacco, Andrea svela una sua peculiare qualità espressiva nel tradurre al tempo stesso la sacralità e la naturalità dell’evento, con lo sguardo malinconico della Vergine che lascia intuire la consapevolezza del destino del suo bambino. Il ritorno della «Madonna» diviene poi il punto di partenza per un itinerario tra altre sedi della città, il Museo Diocesano dove si trova l’«Annunciazione» e gli affreschi conservati nella Pieve di Santa Maria, in Duomo e al Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna di Arezzo.
Altri articoli dell'autore
A Barberino Tavarnelle la seconda edizione del progetto biennale «Arte nel Paesaggio 2025»
Chi era Fabio, morto a poco più di un anno di distanza dal padre Giuliano che aveva fondato la Fattoria di Celle
Direttrice per circa quarant’anni della Galleria dell’Oca a Roma, fu una figura carismatica della vita culturale della Capitale
Circa 150 opere provenienti perlopiù dai depositi illustrano la reale identità del museo italiano più visitato: una vocazione universale che spazia su tutta l’arte europea