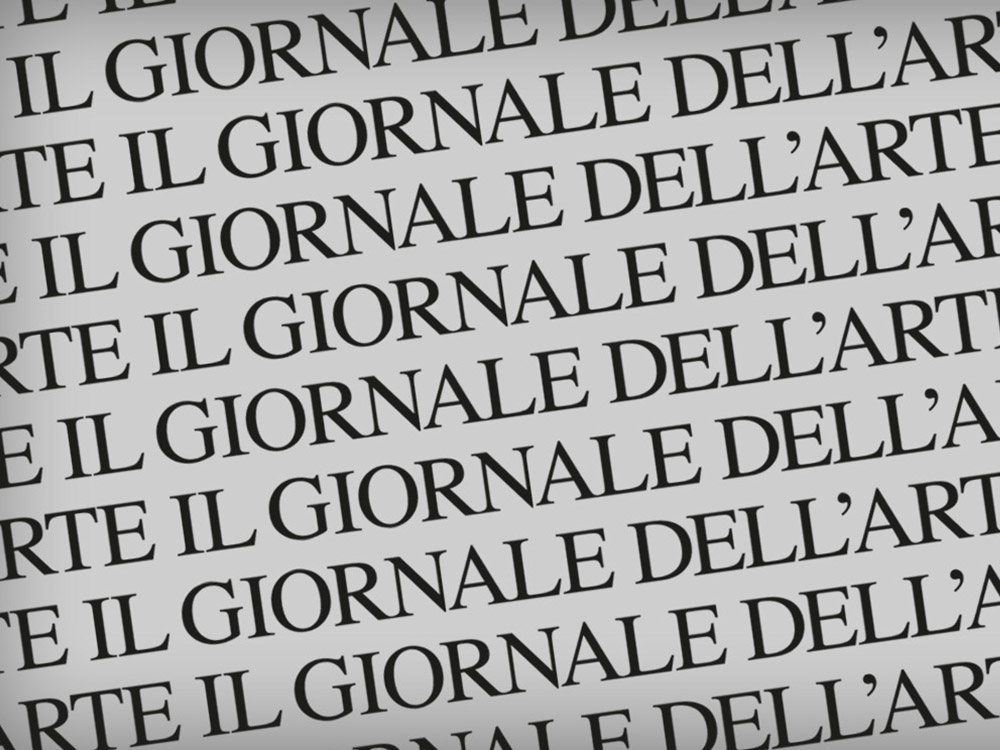Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Laura Lombardi
Leggi i suoi articoliLa carriera ricca e complessa di Ambrogio Lorenzetti è stata in parte oscurata dalla fama dell’affresco del Buongoverno nel Palazzo Pubblico di Siena, vera icona della pittura del Trecento; ma l’artista (documentato tra il 1319 e il 1348), figura cardine della pittura italiana, attende ancora un vero riconoscimento e l’occasione sarà la mostra nel prossimo autunno a cura di Alessandro Bagnoli, Roberto Bartalini e Max Seidel. In attesa di questa sono in corso numerosi restauri al fine di ricostruire la personalità e le diverse fasi della sua vicenda artistica. Già a buon punto è l’intervento che riguarda il ciclo di Montesiepi (cfr. n. 360, gen. ’16, p. 41), che sarà riportato nella chiese omonima, nei pressi di San Galgano dopo la mostra, ma che ora è visibile in una sala del Complesso monumentale di Santa Maria della Scala.
«Siamo giunti qui alla fase conclusiva, quella della integrazione pittorica, spiega Massimo Gavazzi della ditta A.r.c. di Pistoia che è incaricata dei restauri. Procediamo con le ricuciture estetiche delle lacune, ricromatizzando matericamente, e scegliendo soluzioni più compatibili anche al gusto odierno». E Alessandro Bagnoli annuncia «importanti novità, che saranno comunicate a tempo debito». Resta dunque la suspense, ma nel frattempo ci spostiamo a San Francesco (visite guidate al cantiere fino a marzo inoltrato, grazie al progetto «Dentro il restauro» del Comune di Siena, ticket@comune.siena.it), la chiesa dove, nelle Cappelle Bandini Piccolomini e Piccolomini di Castiglia sono grandi frammenti di pittura murale di Ambrogio e del fratello Pietro.
«Per queste pitture la datazione è molto più precoce di quanto si pensasse, siamo all’inizio degli anni Venti, quando Ambrogio doveva essere poco più che ventenne, spiega Gavazzi. Gli affreschi erano all’origine nella Sala capitolare del convento, scialbati al tempo delle soppressioni napoleoniche, poi descialbati; tuttavia, quando i francescani cedettero la sala al seminario, furono staccati col massello e traslati in chiesa tra il 1852 e il 1857: la decisione fu presa da una deputazione delle Belle arti e le pitture murali resistettero abbastanza bene allo stress grazie alla maestria di Ambrogio nella tecnica del buon fresco. Si notano dettagli di grande finezza, lamine metalliche, punzonature, un insieme molto articolato».
I restauri riguardano qui anche Pietro Lorenzetti, del quale si riconoscono scene della passione di Cristo, soprattutto una Crocifissione e una Resurrezione. «Proprio questa vicinanza tra i due fratelli conferma la datazione precoce, poco dopo Assisi, e nella Crocifissione vediamo come Pietro dimostri di essere innamorato delle soluzioni drammatiche di Giotto nella Basilica inferiore, nota Alessandro Bagnoli; Ambrogio muove invece dall’esperienza di Simone Martini, come appare da una visione ravvicinata degli affreschi che trattano di storie francescane in questo grande convento dell’Ordine. Tra le storie si riconosce quella di Bonifacio VIII che dà la carica di vescovo a san Ludovico di Tolosa, già entrato a far parte dell’Ordine francescano: alla scena assiste Carlo II d’Angiò, il padre, con un’espressione stupita e quasi irata per la scelta del figlio. Stiamo invece ancora studiando la scena in cui si vede un martirio di frate francescano avvenuto in Asia, e non in Marocco come si credeva, forse tra i Tartari ».
Gli affreschi di Sant’Agostino si datano invece intorno al 1336-38, quindi dopo Montesiepi: la lunetta con la Madonna e santi nella Cappella Piccolomini fu scoperta solo nel 1943 dietro la tavola del Sodoma, quando quest’ultima fu tolta per proteggerla dai bombardamenti. Così nel 1947 l’altare (con la tavola di Sodoma) fu rimontato sulla parete di fronte in modo da liberare la lunetta di Ambrogio, unica superstite di un ciclo di affreschi nella sala capitolare ricordati da Vasari, come lo sono anche quelli di San Francesco. I restauri saranno conclusi entro giugno.
Altri articoli dell'autore
Un’intera sala è dedicata al massimo scultore in cera attivo nel capoluogo toscano a fine Seicento: Gaetano Giulio Zumbo
La mostra a Pisa curata da Francesca Dini ripercorre lo sfavillante periodo, a fine Ottocento, in cui Parigi era il centro culturale del mondo. E tra i protagonisti di quel nuovo clima, gli artisti italiani che scelsero la capitale francese come patria d’adozione, tra cui Boldini, De Nittis e Corcos
Nel bicentenario della nascita, i suoi dipinti sono messi a confronto con quelli di altri protagonisti della pittura del Risorgimento, da Giovanni Fattori a Silvestro Lega e Telemaco Signorini
È stata inaugurata la mostra «Icone di potere e bellezza» con le tre teste in bronzo dorato del Museo di Santa Giulia a Brescia, secondo capitolo dello scambio di manufatti tra le due istituzioni gestito da Fondazione Brescia Musei