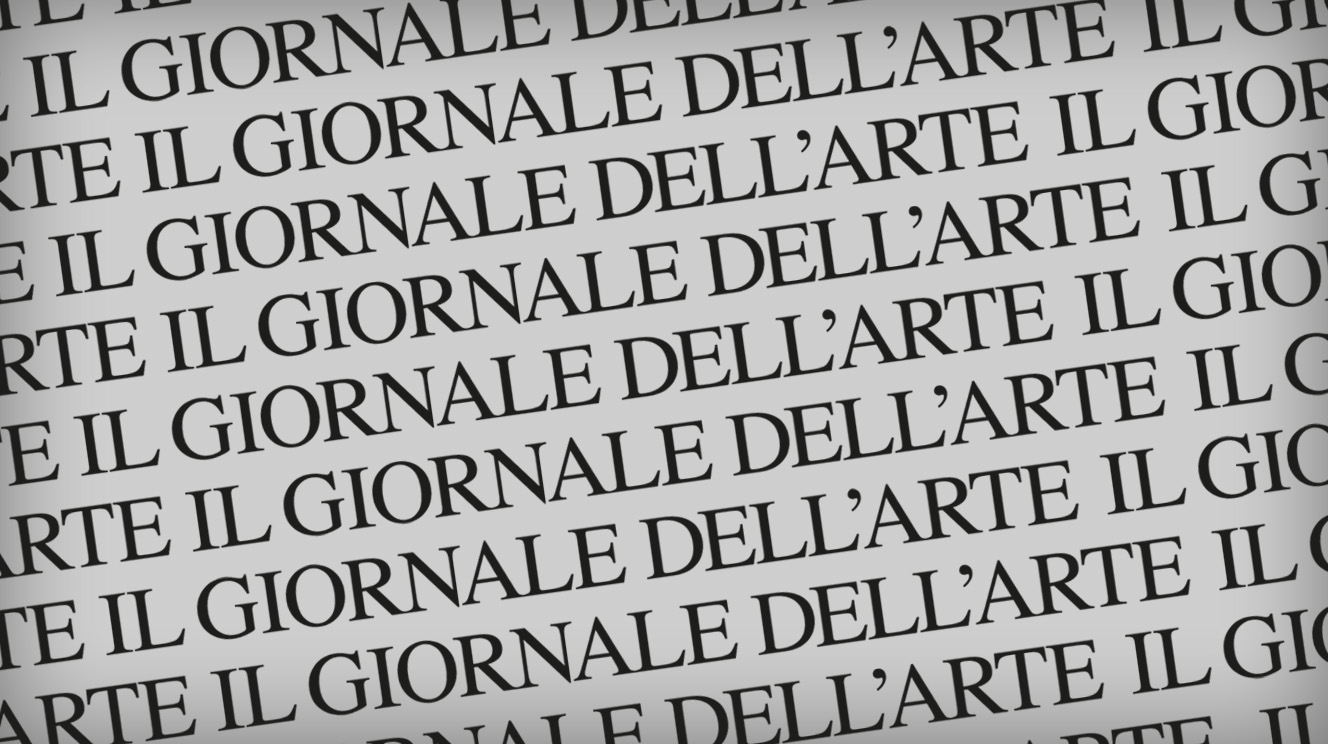Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Bergamo. Giorgio Vasari, si sa, non era uomo prodigo di elogi per gli artisti che non fossero fiorentini. Una delle rare eccezioni la riservò a Palma il Vecchio (Jacopo Negretti, Serina, Bergamo, 1480 ca-Venezia, 1528) del quale nel 1568 scrisse che meritava «grandissima lode e di essere annoverato tra quegli che posseggono l’arte». A suscitare il suo entusiasmo fu la «tanta osservanza nel disegno, nell’invenzione e nel colorito, che pare che tremi la tavola, come [se] tutto quello che vi è dipinto fusse vero» dell’immensa «Tempesta infernale» vista nella Scuola Grande di San Marco a Venezia: quell’opera, che per il prestigio della committenza (non meno che per le dimensioni) certifica il successo raggiunto da Palma a Venezia, benché concessa in prestito, non potrà essere esposta nella retrospettiva che Giovanni Carlo Federico Villa ha curato per l’Accademia Carrara, perché la sede della mostra (la GAMeC, in attesa che il 23 aprile si inauguri la sede della Carrara, rinnovata e ampliata) non è in grado di accogliere un’opera di tali dimensioni. Ma grazie anche all’impegno di Fondazione Credito Bergamasco, con il segretario generale Angelo Piazzoli (che ha promosso anche i restauri del Polittico di Serina e dell’«Adorazione dei pastori» di Zogno) e di ComunicaMente Servizi per la Cultura, la mostra «Palma il Vecchio, lo sguardo della bellezza» (dal 13 marzo al 21 giugno, catalogo Skira) può esibire 40 opere dell’ottantina oggi assegnate al maestro, giunte qui dai maggiori musei del mondo. Ne parliamo con il curatore.
Palma il Vecchio conobbe a Venezia una fama senza uguali, superando per un periodo lo stesso Tiziano. Perché il suo nome si è poi appannato?
Per dieci anni, dal 1518 quando Tiziano, consegnata l’«Assunta», si rivolse alle grandi corti, fino al 1528, anno della sua morte, Palma fu l’artista principe di Venezia, il prediletto della migliore committenza locale, che seppe conquistare con lo splendore della sua tavolozza, con la tecnica sopraffina delle velature e con quel suo modello di bellezza femminile che rispondeva ai gusti degli esponenti della grande classe mercantile veneziana. Per loro Palma dipinse meravigliosi e ambitissimi ritratti femminili, «Sacre conversazioni» nel paesaggio e ninfe immerse in una natura arcadica, alla Sannazaro. Palma è un artista capace di parlare attraverso i secoli, ma paradossalmente la grande fortuna critica di cui godette nel secondo Ottocento, che indusse i maggiori musei del mondo ad acquistare le sue opere, ha finito per nuocergli: è difficilissimo riunire in una mostra i suoi dipinti, sparsi nel mondo e per di più molto delicati perché quasi sempre su tavola. Tanto che questa rassegna è la prima monografica dedicata all’artista.
Ha riunito una quarantina di opere delle 80 circa che oggi fanno parte del suo catalogo. Con quali criteri le ha scelte?
Con il solo criterio della qualità, seguendo il filo già adottato nelle mostre che realizzai alle Scuderie del Quirinale. Volevo solo i capi d’opera di ogni stagione. Ci siamo riusciti: abbiamo la «Dama in blu» di Vienna, la «Bella» della collezione Thyssen-Bornemisza di Madrid, l’«Incontro di Giacobbe e Rachele» di Dresda e altri prestiti straordinari dalla National Gallery di Londra, dal Louvre, dai musei di San Pietroburgo, Berlino, Belgrado, Mosca e Madrid, dalle collezioni reali inglesi, dagli Uffizi e dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia. Da Venezia (ma da Santa Maria Formosa) giunge anche il «Polittico dei Bombardieri», l’opera con cui Palma «rispose» all’«Assunta» di Tiziano, che per gli apostoli aveva preso a modello i pescatori chioggiotti. Palma ribatté con questa santa Barbara alta due metri che è la classica «matrona» veneziana del tempo. I due artisti si guardavano l’un l’altro e sono certo che si rispettassero.
Avrete in mostra anche i polittici che Palma realizzò per la bergamasca?
Ho sempre pensato che queste operazioni debbano essere composte al 20% dalla mostra e all’80% dal territorio. Quindi, non solo le pale dell’area bergamasca rimarranno nelle loro chiese (a Serina il Polittico restaurato e un altro, ora correttamente ricomposti, torneranno dalla sacrestia agli altari della chiesa per cui furono realizzati), ma l’intera città di Bergamo sarà coinvolta in questo evento, che deve diventare uno strumento di valorizzazione delle eccellenze del territorio partendo dalla sua tradizione più alta. Le pareti della mostra saranno rivestite di seta veneziana e i pannelli su cui poggiano le opere saranno foderati di «pannilana» bergamaschi. Abbiamo inoltre coinvolto oltre 150 realtà della città: giovani stiliste già note che creeranno outfit «alla Palma»; gioiellieri; uno chef stellato che realizzerà cene rinascimentali in un antico convento in città e altri che creeranno menu a prezzo contenuto ma sempre su documenti d’epoca; un fruttivendolo presenterà panieri di frutti coltivati nel Cinquecento e un produttore di formaggi come allora «tingerà» un formaggio locale (il «bagòss») con lo zafferano: una spezia che arrivava da Venezia.
Articoli correlati:
Finalmente la Carrara
Altri articoli dell'autore
Grazie al motto «preservare per valorizzare», il segretario generale del più antico museo di Milano ha ottenuto lo scorso anno un incremento di visitatori del 20 per cento: «Occuparsi di cultura significa trasmettere conoscenza a chi ignora: il mio modello è inclusivo, non elitario e soprattutto non autoreferenziale»
Alle Gallerie d’Italia di Milano 30 scatti e due video di Jess T. Dugan, artista statunitense, donna alla nascita, campione della comunità Lgbtq+
Da Arte Invernizzi, a Milano, sono esposte opere in plexiglas dell’artista veneziano che trasforma luce e colore in paesaggi mentali immersivi
Acquistati e restaurati da Banca Ifis sono esposti per un anno nella Pinacoteca di Brera in dialogo con altri capolavori del maestro neoclassico conservati nel museo