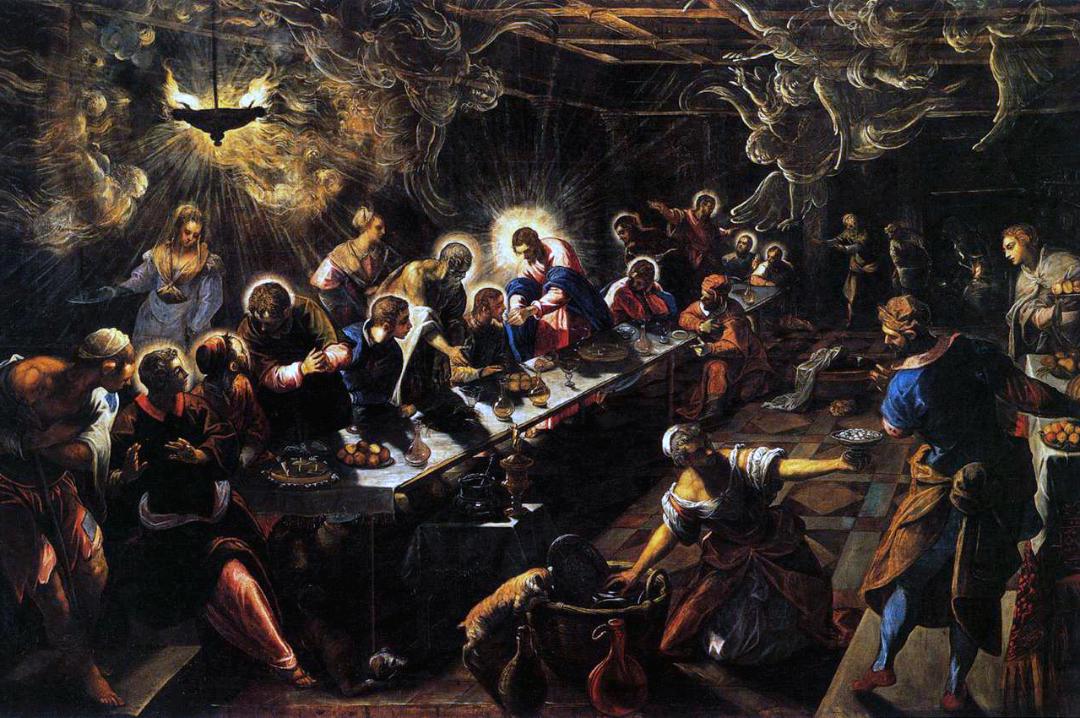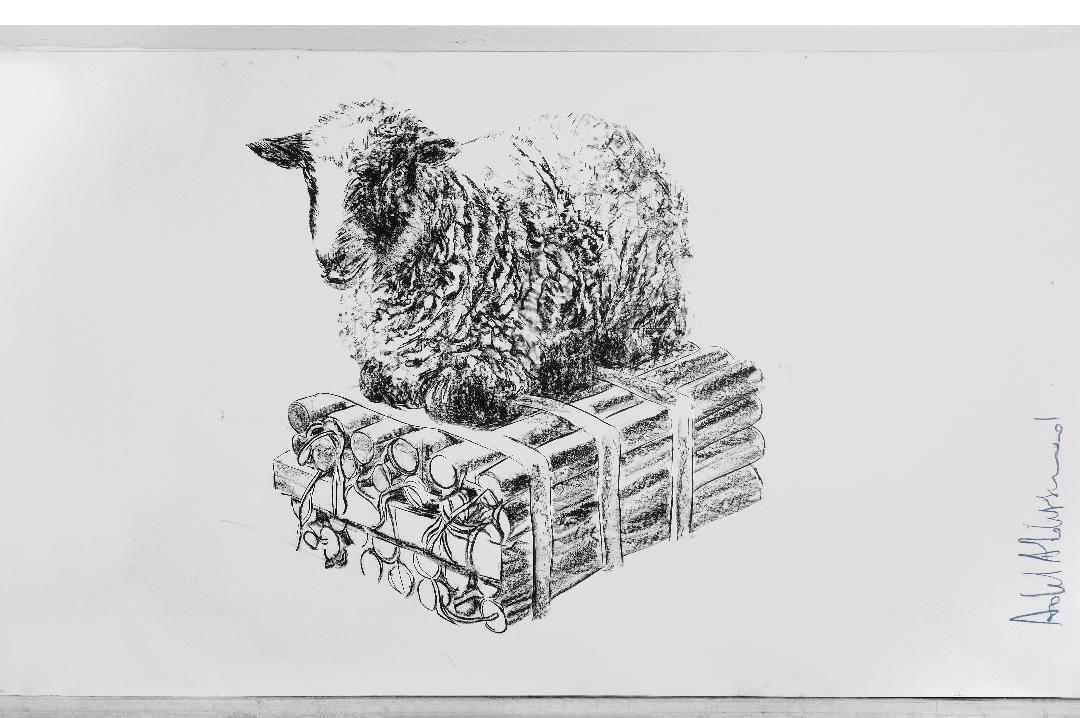Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Arianna Antoniutti
Leggi i suoi articoliPanneggi spigolosi, sfumature metalliche, corpi, più che dipinti, scolpiti. Sono queste le peculiarità stilistiche dell’inedita «Pietà», ritrovata nei depositi dei Musei Vaticani da Fabrizio Biferali, curatore del Reparto per l’Arte dei secoli XV-XVI dei Musei del papa, peculiarità che lo hanno indotto a ritenere che l’autore dell’olio su tavola potesse essere uno scultore. In particolare, le Pietà del fiorentino Baccio Bandinelli, realizzate a metà del Cinquecento a Firenze, si sono presentate alla mente dello storico dell’arte. Puntuali confronti con sculture dell’artista, reperimento di documenti d’archivio altrettanto inediti e, infine, il restauro della tavola, hanno confermato l’intuizione: l’opera è il secondo dipinto documentato a noi giunto, insieme con la «Leda e il cigno» del 1512 conservato alla Chancellerie des Universités de Paris, sicuramente ascrivibile alla mano di Bandinelli.
Allo scultore, attivo alla corte medicea di Cosimo I, è dedicata la mostra «Baccio Bandinelli pittore», visibile fino al 25 febbraio 2024 presso gli Uffizi di Firenze, curata dallo stesso Biferali e dal direttore uscente Eike Schmidt. In mostra, accanto alla Pietà ritrovata, una delle prove definitive dell’attribuzione: il disegno preparatorio, dalle collezioni degli Uffizi, con la mano dell’angelo che tiene la corona di spine e i chiodi. Un altro disegno preparatorio, conservato al British Museum, raffigura il corpo reclinato del Cristo.
Entrambi i disegni testimoniano l’alta maestria raggiunta dal Bandinelli nell’arte grafica, «disegnatore miracoloso», come lo definirà Anton Francesco Doni nel suo dialogo «Disegno». Sempre su disegno dello scultore-pittore sono le due opere, pure in mostra, «Creazione di Eva» e «Cacciata dal Paradiso», eseguite dal fiorentino Andrea del Minga. I due dipinti, donati a Eleonora di Toledo, sono parte della collezione della Galleria Palatina di Palazzo Pitti.
La Pietà del Bandinelli, in precario stato conservativo, è stata sottoposta a un delicato e lungo intervento di recupero effettuato presso il Laboratorio di Restauro Dipinti e Materiali lignei dei Musei Vaticani dai restauratori Angela Cerreta (per la superficie pittorica) e Massimo Alesi e Marco De Pillis (per il supporto ligneo), sotto la supervisione di Francesca Persegati, responsabile del Laboratorio, e di Fabrizio Biferali.
Biferali ci illustra la scoperta e la ricchezza, ancora in gran parte da indagare, dei depositi dei Musei Vaticani: «Mi sono imbattuto nell’opera, nell’estate del 2020, nel corso di ricerche nel Magazzino quadri. Ne parlai subito con il mio predecessore, il compianto Guido Cornini. La qualità delle figure, che quasi premono sulla superficie della tavola come in un bassorilievo donatelliano, mi ha fatto pensare all’opera di uno scultore. Determinanti, poi, sono stati i raffronti con opere di Bandinelli, in particolare la Pietà di Santa Croce e la Pietà dell’Annunziata, sepoltura dell’artista, in cui l’autore si rappresenta, come Nicodemo, mentre sostiene il corpo di Cristo. Vasari ricorda come l’artista “ne’ suo’ primi anni attese al disegno” e, sempre allo storiografo, si deve la descrizione della Pietà dei Musei Vaticani, sino ad ora considerata perduta: “Cristo deposto di croce tenuto in braccio da Niccodemo, e la Madre sua in piedi che lo piangeva, et un Angelo che teneva in mano i chiodi e la corona delle spine”.
Sempre dalle Vite, sappiamo che Bandinelli dipinse la tavola non dietro committenza, ma “per intenderne l’opinione degli uomini” e, con questo scopo, la espose al Mercato Nuovo di Firenze. Qui la vide Michelangelo che, pur riconoscendo le grandi doti dello scultore e disegnatore, la definì “cruda e senza grazia”. Si tratta sicuramente di un’opera “citazionista“, ma che possiede un proprio fascino, non solo grafico. In essa è evidente, oltre all’influenza dei prototipi di ascendenza michelangiolesca (penso, ad esempio, a Rosso Fiorentino che, assieme a Bandinelli, frequentò la bottega di Andrea del Sarto), anche lo studio dell’antico.»
Quali sorprese possono ancora riservare i depositi dei Musei Vaticani?
I depositi costituiscono un vero e proprio museo nel museo. Il Magazzino quadri, ad esempio, racchiude centinaia di opere, fra dipinti e sculture, che spaziano dal Medioevo all’arte contemporanea. Dal 2019 sto portando avanti studi e ricerche fra le opere in esso conservate, anche al fine di apportare modifiche all’attuale allestimento della Pinacoteca.
La Pietà di Bandinelli, dopo la mostra agli Uffizi, sarà presentata, in giugno, qui ai Musei Vaticani per trovare definitiva collocazione nella Pinacoteca. Analogamente ci sono altre opere, attualmente nei depositi, che attendono opportuna valorizzazione: lavori pittorici di qualità che, restaurati e studiati, potranno finalmente uscire dall’oblio. Sono dipinti spesso catalogati come «Scuola di», «copia», «opera di bottega» ma che, grazie all’occhio del conoscitore e sottoposti a indagini scientifiche e interventi di restauro, possono rivelarsi di mano di grandi maestri. Negli ultimi anni sono emerse novità interessanti su questo fronte ed è la direzione in cui continueremo a guardare.


Altri articoli dell'autore
«Il restauro, condotto da restauratori specializzati sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza Speciale, spiega il presidente dell’Associazione Mecenati Roman Heritage Onlus Ugo Pierucci, è frutto di una virtuosa collaborazione fra pubblico e privato»
Dagli affreschi trecenteschi alle torri campanarie, dalle vetrate istoriate alla Casa Manzoni, una tradizione esemplare di interventi su beni inamovibili
In questo complesso percorso di salvaguardia, restauratori, studiosi, storici dell’arte, sono solo una parte della platea cui si rivolge il programma, il cui principale obiettivo, da sempre perseguito, è il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità e dei territori
La prima personale dell’artista francese alla Galleria Continua: disegni che trasformano tensioni, fede e natura in un racconto visivo potente