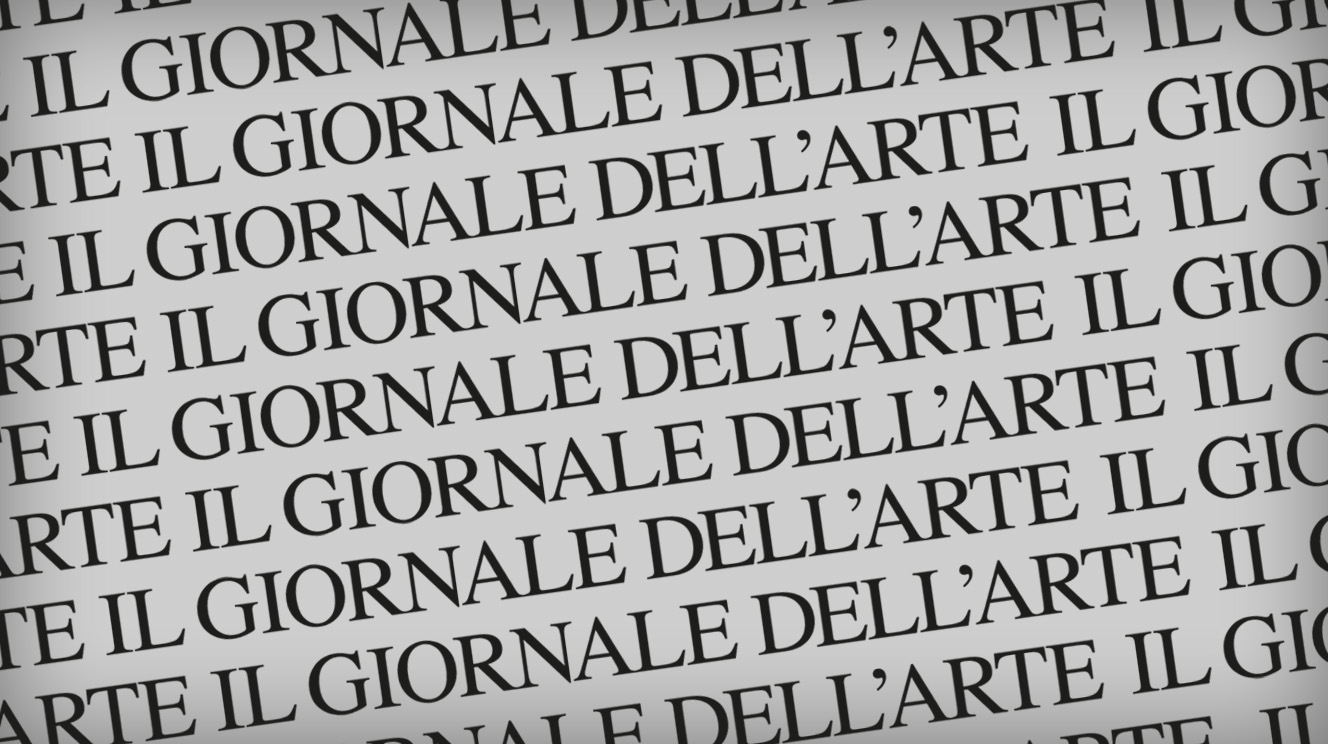Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
A 16 anni dal Concorso internazionale bandito nel 1999 dal Comune di Milano (assessore alla Cultura e Musei Salvatore Carrubba, direttore centrale Alessandra Mottola Molfino) per la progettazione del primo lotto della futura Città delle Culture nell’area dell’ex Ansaldo, vinto nel 2000 dall’architetto britannico David A. Chipperfield, e a 26 dall’acquisizione da parte del Comune stesso dell’immenso complesso di archeologia industriale che per quasi un secolo aveva ospitato una delle più importanti realtà produttive nazionali, il 27 marzo l’atteso Museo delle Culture aprirà finalmente i suoi (bellissimi) spazi «d’autore».
Sarà però un’inaugurazione singolare, perché il museo si offrirà al pubblico non con le sue collezioni ma con due mostre, una, intitolata «Mondi a Milano» che, in omaggio a Expo 2015, rievocherà le grandi esposizioni del passato, spesso occasioni per la città di acquisire collezioni per le raccolte extra-europee, l’altra dedicata all’«Africa» (cfr. box a fianco). Bisognerà invece attendere l’autunno per vedere il museo con le sue collezioni, ordinate secondo il progetto museologico di Marina Pugliese, direttore del Polo arte moderna e contemporanea, a cui l’istituzione fa capo.
In tanti anni, e con tante amministrazioni e assessori alla Cultura che si sono avvicendati a Milano, il museo e l’area dell’ex Ansaldo (70mila mq complessivi, in cui trovano posto i laboratori di scenografia e sartoria e la sala prove del Teatro alla Scala e, all’inizio, alcuni spazi dell’Accademia di Belle Arti di Brera, poi ritiratasi, oltre alla prevista Città delle Culture) hanno, ovviamente, cambiato più volte di pelle. Vale perciò la pena ripercorrere le tappe di questa odissea urbana e delle raccolte etnografiche conservate nel museo, il cui nucleo organico risale alla metà dell’Ottocento (erano allora nel Museo di Storia Naturale, poi, nel 1900, passarono al Castello Sforzesco, restaurato da Luca Beltrami e da lui trasformato in una vera «cittadella dei musei» milanesi). La guerra avrebbe distrutto molti pezzi delle Raccolte etnografiche (non furono messe al riparo come i tesori d’arte del Castello, non essendo allora considerate prioritarie), in parte poi reintegrate da donazioni e acquisti. Fu solo sotto la direzione di Claudio Salsi (allora direttore delle Raccolte d’Arte Applicata e oggi direttore della Soprintendenza Castello, Musei Archeologici e Musei Storici di Milano) che furono ufficialmente istituite le Raccolte extraeuropee, che grazie a lui si arricchirono di importanti donazioni e depositi (Balzarotti, Fesce, Lo Curto, Passarè) e di acquisti come la raccolta Bassani di arte africana.
Intanto, seppure lentamente, l’edificio progettato da Chipperfield all’interno dell’area ex Ansaldo e destinato a quello che allora si chiamava Museo delle Culture extraeuropee cresceva, mentre la lunga «stecca» (12mila mq) che corre lungo via Tortona, vedeva cambiare molte volte le sue destinazioni: prima pensata per ospitare le sezioni egizia e greca del Museo Archeologico, accanto al Casva-Centro alti studi per le arti visive («votato alla cultura e allo studio dell’immagine»), alla Biblioteca d’arte del Castello Sforzesco, al Civico archivio fotografico, anch’esso del Castello, nel 2008 (Vittorio Sgarbi assessore e Massimo Accarisi direttore centrale) videro aggiungersi, in prospettiva, il Centro internazionale della fotografia gestito dalla Triennale.
Con l’arrivo di Stefano Boeri all’Assessorato alla Cultura, nel giugno 2011, parte della stecca di via Tortona fu destinata alle «Officine Creatività Ansaldo» (acronimo deliberatamente giocoso: Oca), mentre nasceva e cresceva il «Forum della Città Mondo», che oggi raccoglie oltre 600 associazioni cittadine, espressione delle 184 etnie diverse (246mila persone) presenti in città, 80 delle quali, ora riunite nell’«Associazione Città Mondo», anche in rappresentanza delle altre dialogano per progetti senza fini di lucro con il Museo delle Culture, che mette a loro disposizione uno spazio operativo e uno spazio polivalente, sulla base di una convenzione in via di definizione. Sempre al tempo di Boeri risale la collaborazione, avviata ma poi subito decaduta, con Francesco Bonami e Okwui Enwezor (attuale direttore della Biennale di Venezia), tesa a realizzare mostre «sul contemporaneo con caratteri interculturali».
Decadute tali collaborazioni, resta invece più che mai viva (e ribadita nella delibera del 30 dicembre scorso) la vocazione del museo alla «ricerca multidisciplinare sulle culture del mondo», per mettere in relazione le collezioni etnografiche e le comunità del territorio milanese e per costruire «un dialogo con la contemporaneità sui temi delle arti visive, performative, sonore, del design e del costume». Tema che sta molto a cuore all’assessore alla Cultura Filippo Del Corno, poiché «costituisce un valore aggiunto sul piano culturale e civile» del nascente Museo delle Culture.
Inedita la formula di collaborazione pubblico-privato, stipulata (dopo una gara pubblica) con 24Ore Cultura, società guidata da Natalina Costa, che dal 2014 sarà per 12 anni il partner dedicato alla realizzazione di progetti espositivi di livello internazionale, mentre al Comune resta il compito della tutela e valorizzazione delle collezioni permanenti.
Mondi in mostra a Milano
Delle due mostre inaugurali, «Mondi a Milano» (dal 27 marzo al 19 luglio) ripercorre le molte, importanti esposizioni di arti industriali che nel secondo Ottocento si tennero in città, sul modello delle grandi Esposizioni universali straniere, e la loro successiva riformulazione come Biennali prima (a Monza) e Triennali poi (a Milano). Le esposizioni ottocentesche furono occasioni straordinarie per la conoscenza di quei «mondi» lontani, allora ben difficilmente accessibili, che giungevano a Milano e la mostra (curata da un pool di studiosi formato da Fulvio Irace, Anna Mazzanti, Mariagrazia Messina, Antonello Negri, Carolina Orsini, Marina Pugliese, Ornella Selvafolta), ricostruisce progetti architettonici e ambienti presentati allora, con oggetti, manufatti, dipinti, stampe popolari e fotografie, evidenziando la ricezione in Italia di quelle lontane culture e l’ideologia sottesa a quegli eventi.
Altri articoli dell'autore
Le curatrici Elena Tettamanti e Antonella Soldaini illustrano com’è nata la «mostra diffusa» in tre luoghi simbolici di Milano: Palazzo Reale, il Museo del Novecento e la Chiesa di San Gottardo in Corte
«Il mio progetto non è per un museo dedicato a Burri ma alle trasformazioni nella Valle del Belice»
Il presidente della Fondazione Burri dichiara che l’istituzione erede del maestro non è mai stata interpellata e che in tre anni le sue lettere non hanno ricevuto risposta. Non solo: smentisce che il soprintendente gli abbia dato appuntamento per settembre
A settembre al Palazzo Reale di Milano, dov’è ricostruito il fregio dei «Fasti di Napoleone» distrutto nell’ultima guerra mondiale, un centinaio di opere dell’artista (anche inedite). A complemento, un itinerario nei «suoi» luoghi