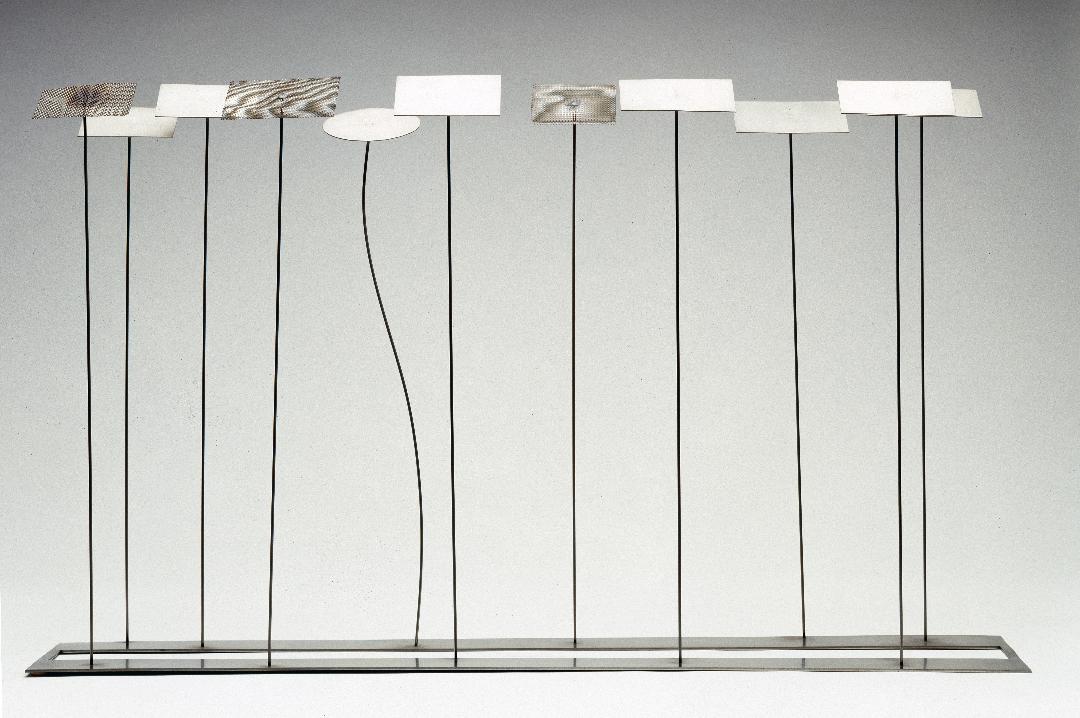Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Franco Fanelli
Leggi i suoi articoliSono davvero tramontati i tempi del «se ti fa schifo è bello»? Ne scrisse Armando Testa in uno dei suoi più esilaranti articoli per la rubrica «Dalla parte di chi guarda», a lungo pubblicata su questo giornale. Siamo sicuri che oggi, trent’anni dopo quell’articolo, il pubblico, quello solo guardante e quello invece pure comprante, sia ormai generalmente e sufficientemente acculturato sugli enigmi dell’arte contemporanea per non limitarsi, dichiarando il suo apprezzamento per un’opera, al suo puro apparire, alla sua forma? Forma, vogliamo dire, che, nella produzione postduchampiana, sovente ha flirtato con canoni estetici che spaziano dall’antigrazioso al repellente e che proprio in quanto tali, per non fare figuracce, individuati quali stigmate del valore e del prezzo conferiti da ciò che è «contemporaneo»?
Si ha un bel dire, in effetti, che oggi, per l’ormai sterminata popolazione dei contemporaneofili, il termine «bellezza» è una qualifica quanto mai convenzionale e di sicuro non limitata alla forma, bensì dettata dalla capacità di far riflettere, di metterci in crisi o di evidenziare problemi o, perché no, di «svelare» la stessa bellezza, nascosta in ciò che convenzionalmente bello non sarebbe: questa, in sintesi estrema, l’opinione degli addetti ai lavori interpellati sul tema, le cui risposte sono pubblicate in queste pagine.
Ma, di nuovo, siamo certi che quelle peculiarità non limitate alla pura visibilità non siano appartenute anche alla grande arte del passato? Se non fosse così, Giotto, Masaccio, Piero della Francesca, Tiziano, Velázquez, Ingres & C. altro non sarebbero che talentuosi, sebbene rivoluzionari, creatori di forme. Il fatto è che alla loro epoca la forma, anche laddove il messaggio fosse altrettanto impervio, poteva ancora suscitare turbamento e rifiuto. Oggi avviene l’opposto, visto l’unanime plauso ottenuto da ciò che appare in linea con il linguaggio contemporaneo. È proprio questo universale successo ad aver creato l’altrettanto diffuso abbaglio per cui ciò che sarebbe stato trasgressivo è diventato inerte come un’arte di corte praticata da pittori esangui e ossequienti, e l’accademismo viene, appunto, confuso con il linguaggio.
Armando Testa, nell’articolo citato, metteva in guardia sulla transitorietà e sulle metamorfosi dell’apprezzamento basato sul «se ti fa schifo è bello». Ma c’è di più. Da brutta che era, oggi l’arte contemporanea, escludendo i pompier alla Kapoor o alla Carsten Höller o i nuovi vati alla Philippe Parreno, ormai «storicizzato» l’horror trash di Cattelan, si è fatta meno chiassosa, più intima e «carina». Il «troppo» è considerano «cafonal», l’imponenza è ammessa solo nelle occasioni che giustifichino una temporanea iscrizione al predetto club pompieristico (e allora accade che a biennali e documente varie l’artista «svacchi», come chi sbaglia vestito a un matrimonio).
Più della forma, se non più del pensiero, conta la confezione. I giovani maestri sono infatti attentissimi a non trasgredire alcune regole del galateo: se sino agli anni Novanta il video doveva essere sfocato e mosso, oggi il fuori fuoco «invecchia». Il disegno deve sì continuare a essere, intenzionalmente o meno, stentato, ma va incorniciato a modo, meglio se in forma di lacerto sospeso in teca, ma va pur detto che non è ancora risolta l’ormai annosa questione se non sia meglio affiggerlo con spilli alla nuda parete. Molto amate, alle fiere, le scritte che in luogo del cartellino, sulla predetta parete, a grafite, riportano in stentata grafia solo il nome dell’autore. Contano moltissimo il lessico critico e i suoi mantra, e attendiamo da un momento all’altro quello che prenderà il posto del sin troppo duraturo «resilienza».
Ma altrettanto fondamentale ruolo svolgono anche gli oggetti protagonisti dell’opera. Anche in questo caso si va per mode: se negli anni Settanta non si poteva fare a meno del neon e di qualche televisore, la pianta in vaso, negli ultimi cinque anni quasi inevitabile in una installazione, oggi sta cedendo terreno al brano di tappezzeria. Il che è sintomatico, perché la tappezzeria (come la pianta) è uno di quegli elementi che ribadisce quanto un elemento che nella vita reale è contorno, nell’«arte» sia consustanziale al contenuto. Nel grande pacco multistrato del contemporaneo, ad esempio, ha assunto un’importanza fondamentale la comunicazione visiva delle fiere che sempre più indulgono all’allegoria: alle immagini legate alle gioie dell’apicultura ideate da Mousse per Miart, ArteFiera, che ha assolutamente bisogno di riguadagnare terreno anche in termini di moda, si è affidata ad Andrea Lancellotti che, forse in omaggio al biocentrismo oggi diventato il chiodo fisso di certi curatori, ha prodotto una serie di spot legati al mondo naturale, con texture create dai tentacoli di calamari o da simpatici anfibi intesi come rane.
Quanto ai temi, occhio a non attardarsi: le opere basate su argomenti archivistici hanno dominato per anni, sino a trionfare nella Biennale di Massimiliano Gioni; oggi sembra prevalere un filone meno severo e più ammiccante, abbinato magari a una presentazione attraverso la quale l’artista in combutta con il suo gallerista tramuta lo stand monografico di una fiera in un ambiente domestico, quasi a suggerire al compratore quanto e come «arredino» certe opere (l’Ikea vince sull’idea) e non a caso è sotto gli occhi di tutti la relazione tra giovane arte e il design più fichetto (ma attenzione: sino a quanto resisterà lo shabby chic o l’assemblaggio vintage che hanno fatto la fortuna di qualche giovane neoconcettuale infatuato dell’amarcord come Fabio Fazio?).
Insomma, constatiamo che il vecchio caro brutto, sporco e cattivo, il «materiale marron dentro a un giornale strappato» (ancora Testa) «baciato e toccato a lungo» dai suoi concupiscenti adoratori perché opera di Beuys, ci ha da tempo lasciato e con quello la certezza che il brutto e il repellente fornivano nel riconoscimento di ciò che poteva essere definito senza dubbio arte contemporanea.
Sono, questi, i tempi della più stucchevole carineria, chiave del successo e a ben vedere spiegazione della crescita del collezionismo a tutti i livelli. La carineria dandy kitsch è il nuovo marchio di garanzia di un contemporaneo a portata di mano di quasi tutti, quasi come lo fu la scultura «moderna» con la profusione di ceramiche Lenci; trionfa tanto in un video dedicato ai profughi siriani quanto nel quadri del venticinquenne che inneggia al valore civile della pura decorazione. La carineria non turba; è priva di eccessi, limitandosi a essere di moda. Frizzantina e smorfiosetta, lascia poco spazio alla bruttezza, ma anche alla bellezza.
Altri articoli dell'autore
100 opere in una retrospettiva al Museo di arti decorative Accorsi-Ometto: dagli acquerelli autobiografici degli anni ’30 alle ultime carte, 70 anni di trasgressioni e di «gesti erotici» di un’artista insofferente a ogni etichetta estetica e stilistica
Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale
53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere
Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi