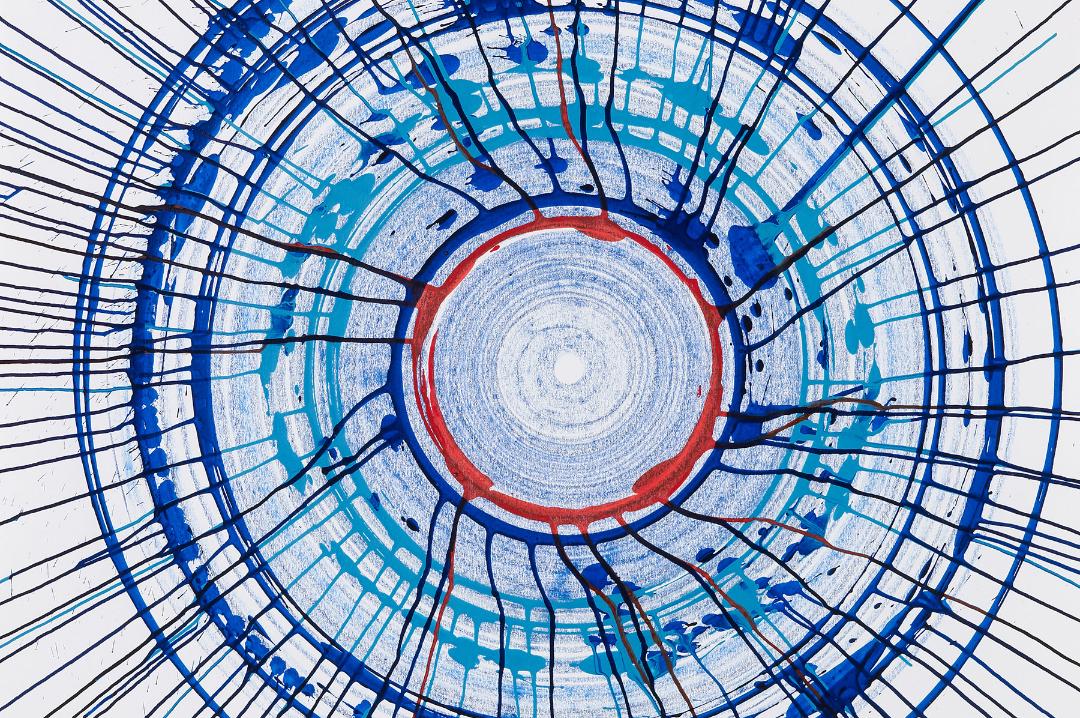Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Flavia Foradini
Leggi i suoi articoliLa sua è una delle direzioni di museo più longeve in Austria. Grazie a un mix di competenza, piglio volitivo e un’incrollabile convinzione delle proprie capacità, l’oggi 66enne Klaus Albrecht Schröder è arrivato alla guida dell’Albertina nel 1999, nel pieno di un radicale restauro della sede, al quale lo storico dell’arte aggiunse da subito un’altrettanto radicale rivoluzione nella politica museale. Da superlativa, ma di fatto reclusa, collezione di grafica ospitata in tetri locali, la prestigiosa istituzione fondata dall’arciduca Alberto di Sassonia-Teschen nel 1776 venne così risvegliata a nuova vita, con un turbinio di mostre a tutto campo: non solo grafica, ma anche pittura, scultura, fotografia. Non solo maestri antichi ma anche Biedermeier, Modernismo e arte contemporanea. Un nuovo corso premiato da una vertiginosa crescita di visitatori e da una forte presenza e interconnessione internazionale.
Klaus Albrecht Schröder, da studente di storia dell’arte immaginava che un giorno sarebbe stato alla guida di un museo di questa levatura? O aveva progetti diversi?
In realtà volevo diventare artista e iscrivermi all’Accademia di Belle Arti. Invece ho poi deciso per storia dell’arte. Glielo dico senza infingimenti: mi considero un ottimo storico dell’arte e uno dei direttori di livello mondiale, che ha cambiato un museo come quasi mai è stato cambiato: una situazione in cui si possono mettere a frutto i propri talenti, riposizionando un’istituzione in modo radicale, facendola uscire da una crisi profonda. Ma per far questo c’è bisogno del caso, della fortuna, del supporto e dell’aiuto di altri. Non vi si riesce per il solo fatto che lo si vuole o perché lo si merita, o perché si è così talentuosi e così eccezionali: in certi momenti della vita serve qualcuno che ti scopre, ti aiuta e ti sostiene e questa fortuna io l’ho avuta. Un’esperienza determinante, che mi ha spinto a cercare, come direttore, di individuare e aiutare dei talenti di spicco e dare loro delle opportunità, la qual cosa credo sia uno dei doveri più importanti della mia posizione.
Torniamo alla sua certezza di essere uno dei migliori direttori di museo al mondo.
Mi considero uno che ha raccolto la sfida che in quel momento si presentava e l’ha vinta. Ritengo che a questo profilo corrispondano anche Tom Krens del Guggenheim e Nicholas Serota della Tate. I nostri sono stati tre compiti paragonabili, anche se sicuramente le premesse peggiori erano all’Albertina: una collezione grafica, in realtà una sala studio con una collezione collegata, dalla quale si facevano mostre di 30 metri lineari, e quello era. Alla Tate c’erano pochi visitatori. Il Guggenheim negli anni Novanta aveva 200mila visitatori. Siamo tre direttori che hanno cambiato i loro musei e non perché lo volessimo bensì perché quelle istituzioni dovevano essere cambiate. Io ho riscattato la grafica da una sorta di quarantena perché sono convinto che non si possa separare dipinti, disegni, fotografie, video e installazioni. Qui abbiamo una delle tre collezioni più importanti di grafica al mondo: ci sono Londra, Berlino, Vienna, e poi molto dopo il Louvre, che però è organizzato diversamente. Qui siamo passati da 2.500 a 25mila metri quadrati espositivi, i visitatori da 7mila a un milione, abbiamo collezioni esemplari di fotografia, Modernismo e arte del nostro tempo.
La pandemia le ha insegnato qualcosa o è semplicemente un evento drammatico con cui dover scendere a patti?
Per la prima volta in vita mia mi sono trovato a confrontarmi con una forza maggiore che dura da un anno e mezzo e travolge qualsiasi tattica, qualsiasi strategia a breve e a lungo termine. Per fortuna ho agito in modo oculato nei precedenti vent’anni e siamo riusciti a sopravvivere e a non licenziare nessun dipendente, perché anche se siamo il museo meno sovvenzionato, siccome copriamo i nostri costi al 70%, abbiamo messo da parte le maggiori riserve finanziarie nel panorama museale nazionale. Dallo Stato abbiamo ricevuto un prezioso supporto, ma occorre chiarirne le dimensioni: nel 2020 abbiamo avuto 2,9 milioni di euro, però ne abbiamo incassati 13 di meno. Tuttavia ho riscontrato una eccezionale solidarietà e comprensione di tutti i grandi musei fra di loro: tutti hanno subito rinvii nei programmi espositivi ma ci siamo aiutati a vicenda. E ho sperimentato la stessa cosa dentro al nostro museo. È stata una bella esperienza vedere che una crisi fa scattare la solidarietà: se nel mondo ce ne fosse di più avremmo superato più facilmente altre crisi.
La pandemia ha prodotto pericoli anche per la cultura?
La pandemia è stata un’orribile tentazione alla crescita del nazionalismo e del provincialismo. Improvvisamente in coloro che passavano il confine si è visto un pericolo («oddio ci portano il virus»), e all’improvviso la cultura è diventata un’istanza nazionale. Ma l’arte appartiene al mondo, viviamo tutti di questa globalità e non parlo solo come cinghia di trasmissione economica, bensì essa ha un’ampiezza che ci fa leggere Balzac e Strindberg e Ibsen e Shakespeare e nessuno dice: «oddio non sono austriaci». Io espongo sia arte internazionale sia arte austriaca e la mostro al maggior numero possibile di persone, che vorrei entusiasmare per l’arte di non importa quale nazionalità. Questo è stato il pericolo più grande della pandemia: la politica ha reagito in primo luogo con confini chiusi anche all’interno della Ue, ma in un secondo momento anche il mondo della cultura ha cominciato a invocare chiusure, con affermazioni come: «Non ci siamo concentrati abbastanza su Ottakring (quartiere viennese popoloso e popolare, Ndr); se lo avessimo fatto ora non dovremmo lamentarci che manchino i forestieri». L’attacco radicale del pensiero provinciale è un delitto nei confronti dell’arte, della cultura e della loro universalità.
Questo è un momento ideale perché i musei ripensino, modifichino, amplino le loro missioni?
I musei devono cambiare continuamente perché la società continua a cambiare. Ci sono state alcune pietre miliari nel mutamento dei musei in quanto istituzioni, ma il maggior cambiamento ha avuto luogo negli ultimi dieci anni, e durante la pandemia si è aggiunto un ulteriore aspetto: la digitalizzazione ha avuto un’accelerazione. Abbiamo imparato molto, ma ciò che pensa il mondo del teatro non è sufficiente, e cioè fare delle riprese video di ciò che avviene in scena e poi trasmetterle al mondo. Io che sono cresciuto con la musica classica non sopporto di guardare un’opera in televisione, il palcoscenico è un’esperienza diversa, c’è bisogno di uno spazio di risonanza diverso da un apparecchio televisivo. Tuttavia dovremmo migliorare per far sì che i musei siano in grado di raggiungere un pubblico che non è in loco, non può sperimentare dal vivo un’opera d’arte. Per il resto il maggiore cambiamento e la maggiore sfida sono derivati dalla globalizzazione: chi contempla l’arte ora non fa più parte degli acculturati bianchi con un’educazione borghese. I visitatori arrivano con un’idea del mondo, con sfondi religiosi o laici disparati e non sanno che farsene dell’arte della Controriforma. L’accelerazione degli ultimi dieci anni ha indotto una rapidissima perdita di rilevanza degli antichi maestri, un fenomeno iniziato già da qualche tempo. Quando oltre due decenni fa sono diventato direttore dell’Albertina ho voluto esporre arte austriaca dell’Ottocento. Si trattava di mostre con 150-180mila visitatori, ma già cinque anni dopo analoghe mostre avevano 130-150mila visitatori. E cinque anni dopo ancora i visitatori erano 100-120mila. Ci è morto il pubblico di riferimento. I giovani non sono interessati al mondo del XIX secolo con quel suo lato idilliaco e nemmeno all’arte del XVI, XVII, XVIII secolo. C’è naturalmente qualche eccezione, come Leonardo, Michelangelo, Dürer, ma la nostra ultima mostra su Dürer ha avuto oltre 430mila visitatori, però la prima nel 2003, 15 anni prima, ne ebbe 530mila. Sono grandi numeri, ma se fossimo in un settore produttivo e avessimo il 25% in meno di visitatori, sarebbe un problema. Vent’anni fa a una mostra di Keith Haring venivano 15mila visitatori, oggi ne vengono quasi 300mila. Le felici eccezioni: Uffizi, Prado, Louvre, perché sono così grandi e hanno un tale effetto magnetico da essere un must-see, per cui non importa che cosa fai o non fai, eserciti comunque un’attrazione. Tutto ciò ha potentemente cambiato il paesaggio museale e mi obbliga nuovamente a reinventare l’Albertina, pensando: dove ha un futuro? Dove potrà essere fra 10-30 anni? Da qui lo sviluppo del settore dell’arte contemporanea: è questo il futuro e significa cercare nuove alleanze con prestatori, con grandi collezionisti, con grandi fondazioni, per poter fare crescere queste collezioni là dove vi è il maggior potenziale di crescita.
L’Albertina modern inaugurata l’anno scorso pare uno di questi nuovi sbocchi. Nel 2015 l’imprenditore e collezionista Hans Peter Haselsteiner ha acquisito il 74% del Künstlerhaus dove ha sede il museo, poi ha speso 57 milioni di euro per il restauro dell’edificio, ora paga i costi di gestione. Ha inoltre comprato il 60% della collezione Essl e poi l’ha data in comodato all’Albertina, oltre 3mila opere, che si aggiungono alle ulteriori 1.300 opere donate all’Albertina da Essl dalla stessa collezione. Non è carità pelosa?
Haselsteiner è un grande imprenditore ed è una persona che fino all’ultimo respiro vorrebbe creare qualcosa, che si pone sempre nuovi obiettivi e non si accontenta di ciò che ha raggiunto. Non abbia timori (ride): nessun quadro lo renderà più ricco. Ma questo vale per quasi tutti i grandi collezionisti. Comunque non ha alcun influsso sulla nostra politica espositiva, sulla presentazione della collezione, sulla ricerca, sulle pubblicazioni. Ciò che espongo o non espongo è una decisione mia e dei miei curatori. Abbiamo 1,1 milioni di opere d’arte, da quella antica a quella contemporanea, abbiamo la collezione Essl, Jablonka, Batliner, e ogni settimana ricevo donazioni che valgono tra 500mila e 2-3 milioni. Non dipendiamo da una collezione.
Quella con Haselsteiner è dunque una magnifica situazione win-win?
Sì, assolutamente, dobbiamo costruire alleanze con i grandi collezionisti. Noi non possiamo comprare quei quadri, nessun museo del mondo può crescere senza fondazioni, donazioni, comodati, prestiti: sono assolutamente centrali e dobbiamo creare queste situazioni win-win. Però ci tengo a relativizzare un po’ questa visione. Noi vinciamo. I grandi collezionisti che cosa vincono? Quei quadri non li possono vendere, visto che sono in fondazioni, per cui non aumentano i loro capitali. Non perdono niente anche se le quotazioni fluttuano, ma non guadagnano neppure.

Klaus Albrecht Schröder © vienna art week. foto christian wind
Altri articoli dell'autore
Il Belvedere Superiore di Vienna approfondisce la genesi del dipinto incompiuto con schizzi e disegni che rivelano lo sviluppo della complessa allegoria
Nell’istituzione viennese la prima presentazione museale delle opere su carta dell’artista inglese per uno sguardo dietro le quinte dei suoi lavori: «Ho sempre con me taccuini o carta, matita o biro»
Dal 21 marzo, i 1.000 metri quadrati del padiglione 19 nel complesso dell’Arsenale saranno dedicati alla produzione fotografica contemporanea locale e internazionale. Obiettivo: dieci mostre all’anno
La Österreichische Nationalbibliotek mette online la preziosa biblioteca del celebre condottiero e collezionista Eugenio di Savoia, una delle più pregevoli raccolte di manoscritti e libri di epoca barocca