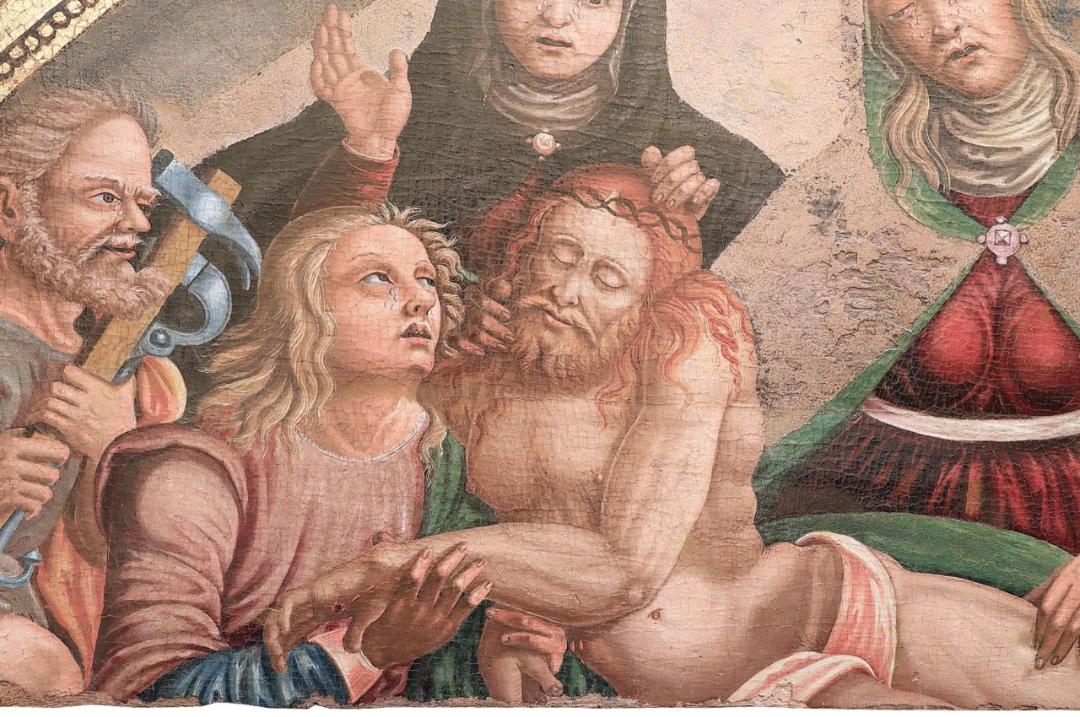Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Stefano Miliani
Leggi i suoi articoliIl 26 giugno 1946 vicino a una casa colonica nella località Santa Lucia di Calamello nel Comune di Pergola (Pu) due mezzadri, scavando un fosso, trovarono i cosiddetti «bronzi di Cartoceto»: oltre 300 frammenti di due cavalieri a cavallo e due matrone che formano il gruppo conservato dal 1988 nel museo locale. Tra le tante domande in sospeso sorge spontaneo chiedersi il perché quei bronzi dorati del I secolo a.C. si trovassero nella campagna marchigiana e da quanto tempo fossero lì. Oscar Mei, professore di Archeologica classica all’Università di Urbino, indagando forse ha trovato una traccia, sorprendente, che ha presentato oggi 24 marzo al Salone di Archeologia e Turismo Culturale di Firenze «TourismA» e in un volume in via di pubblicazione con gli atti di un convegno del 2021.
L’archeologo ricapitola così i fatti: «In un diario un signore, Osvaldo Ciampiconi di Fossombrone, vicino a Pergola, ricorda che quando era bambino nel 1910 un amico di suo padre, Domenico Vitali, a pranzo a casa loro raccontò di un vecchio che gli aveva confessato di aver portato durante le guerre due cavalli in bronzo su un carro e di averli nascosti a Monte Fattore, dove i frammenti furono ritrovati, per timore che li prendessero gli austriaci. Si tratterebbe delle guerre del settembre 1860 e in quel periodo un piccolo contingente di austriaci si trovava nella zona di Pergola». Ma chi era il vecchio? «Probabilmente l’ex bandito Biagio Binotti, capo di una banda. Arrestato nel 1872, rilasciato a inizio ’900, era solito raccontare le sue gesta e a chi andava a caccia, diceva di fare attenzione perché c’era un tesoro nascosto. Binotti era lo zio della moglie di Vitali».
Quella pagina di diario, ricorda Mei, negli anni ’70 fu pubblicata in un libro, passato inosservato, di ricette in dialetto fossombronese. «I bronzi erano a una trentina di centimetri sotto terra, a meno di cinque metri da una casa colonica già presente nel catasto napoleonico del 1815. L’occultamento negli anni ’60 spiegherebbe la mancanza di una stratigrafia archeologica. Inoltre nel catasto pontificio tra la casa e la buca risultava una vigna: la impiantarono senza trovare nulla? Ciò rende ancor meno plausibile che i bronzi siano rimasti lì per 1.500-2mila anni». Perché Binotti li avrebbe nascosti vicino alla casa? «I banditi avevano protettori nelle campagne e probabilmente chi l’abitava aveva legami con lui. Ho trovato la sua fedina penale nell’Archivio di Stato di Pesaro-Urbino: faceva anche il vetturino, aveva un cavallo e un carro e non tutti in campagna potevano permetterseli».
Ma chi occultò il bottino non lo recuperò? «Secondo una leggenda c’era un tesoro nascosto, chiunque lo toccasse sarebbe morto, risponde l’archeologo. La mia idea è che i banditi abbiano nascosto i bronzi negli anni ’60, abbiano minacciato di morte chiunque li avesse toccati e abbiano provato a venderli inutilmente. Nel 1872 vennero arrestati, decenni dopo rimaneva solo la leggenda. Per il trafugamento in epoca antica sono stati chiamati in causa i Goti, i Longobardi e altri, la mia ricostruzione riaprirebbe così l’interrogativo».

I bronzi dorati di Cartoceto nel Museo di Pergola (Pu). Foto: Oscar Mei
Altri articoli dell'autore
A nove anni dal terremoto, in una struttura polifunzionale del Rotary inaugura uno spazio museale permanente con 14 opere dal territorio: un atto concreto contro un graduale invecchiamento e spopolamento
Una consistente acquisizione dell’Istituto centrale per la grafica dall’archivio di Arturo Zavattini compone il nucleo della mostra allestita a Palazzo Poli, che racconta la collaborazione tra il fotografo statunitense e lo sceneggiatore italiano
Maria Rita Acetoso, Senior Program Manager dell’Unesco, rivela come è stato possibile ricostruire tre siti dei tanti distrutti dall’Isis e dalla guerra: la moschea di Al Nouri, la chiesa siro-cattolica di Al Tahera e il convento domenicano di Al Saa’a
Dopo uno stop di dieci anni, sono riprese nel 2023 (fino al 2028) le ricerche condotte dall’Università di Macerata in sinergia col Libyan Department of Antiquities (e il contributo del Maeci) nei due siti costieri di Leptis Magna e Sabratha