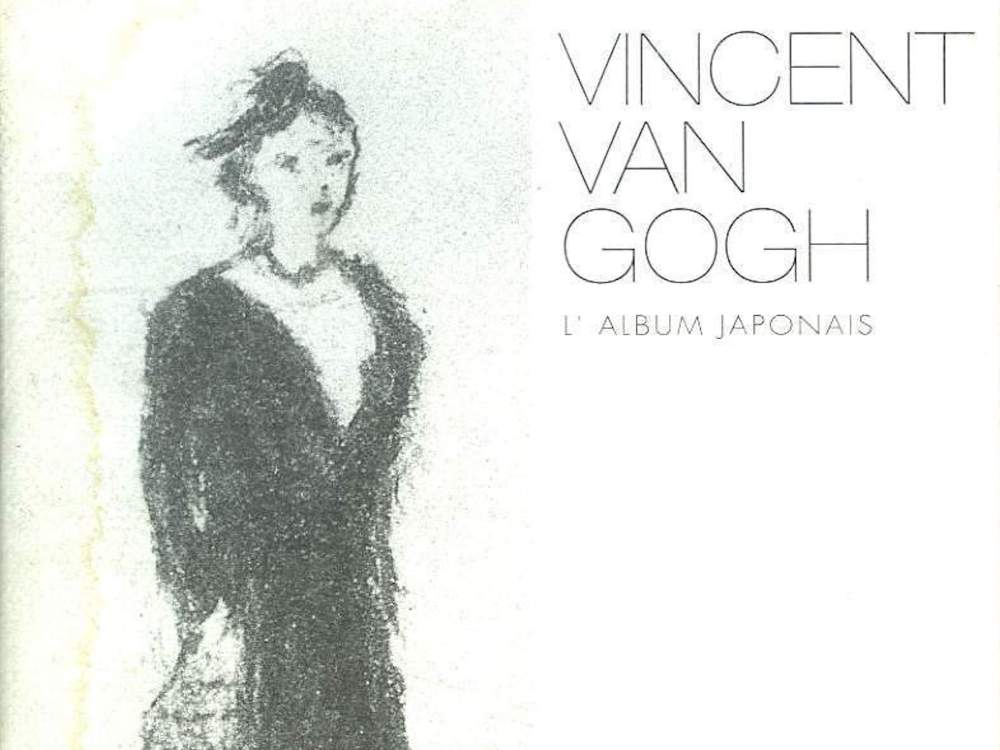Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Gloria Gatti
Leggi i suoi articoliNel 1897 Lev Tolstoj scriveva che l’arte nasce per «soddisfare la gente ricca che richiede svaghi ed è disposta a remunerarli profumatamente» ma, da quando alla passione che ha alimentato e alimenta ancora il collezionismo si è accompagnata una logica di mercato, gli oggetti d’arte si sono convertiti in un prodotto che incorpora un valore, e sono divenuti appetibili per ogni economia, compresa quella del crimine e un dipinto ha smesso di soddisfare solo un bisogno estetico, diventando parte di un processo economico al pari di qualunque altro asset. Le opere d’arte, così, hanno assunto un valore nei bilanci delle società, degli istituti di credito e anche dello Stato.
Un valore irreale
Benché arte sia oggi sinonimo di valore, parlare di «strumento mobiliare» è improprio nell’accezione intesa dalla finanza, perché il mercato dell’arte non è né regolamentato né vigilato. L’assenza di regolamentazione nel mercato, la renitenza a riconoscere rilevanza all’utilizzo degli strumenti scientifici nell’autenticazione e l’assenza di standard per accertare il valore, che è legato più all’autorevolezza di chi esprime un’opinione di attribuzione, o al brand della galleria che lo commercializza, piuttosto che a un valore reale, preclude questo mercato agli operatori istituzionali della finanza (banche e fondi d’investimento) che necessitano di reali «asset class» soggiacendo a una serie di obblighi di informativa e garanzia per la tutela del risparmio che sono oggi incompatibili con il principio della connoisseurship che governa ancora anacronisticamente il sistema.
L’archeologia sponsor del terrorismo
Quello illecito, però, è un mercato sommerso e stabilirne le dimensioni è statisticamente impossibile poiché non vi è trasparenza sulle transazioni. «Quel che è certo», però, dichiara Corrado Catesi, coordinatore della Work of Art Unit dell’Interpol, è che «il crimine organizzato è sicuramente coinvolto nel traffico illecito dei beni culturali e, come affermato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, questo traffico illecito genera guadagni anche per alcune organizzazioni terroristiche come l’Isis. Da un’analisi fatta dall’Interpol sui crimini commessi nel 2018 è emerso che, stando ai dati riportati dai 73 Paesi che hanno risposto, sono stati riportati alle forze di polizia 91mila oggetti d’arte e nello stesso periodo 220mila sono stati sequestrati. In molti Stati, tuttavia, non esistono unità investigative specializzate e in altri anche ove esistenti l’organico è sottodimensionato. Si sconta inoltre in molti Paesi la mancanza o l’inadeguatezza delle legislazioni nazionali e l’assenza di uniformità a livello europeo».
Antiriciclaggio in azione
Sotto questo profilo in Italia, benché ai sensi dell’art. 103 della Legge su Diritto d’Autore (Lda) sia stato istituito e tenuto un registro delle opere protette presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che addirittura stabilisce una presunzione di paternità dell’opera, lo stesso è di scarsissima utilizzazione, con la conseguenza che non esiste un censimento attendibile delle opere d’arte presenti sul territorio, salvo per quelle dichiarate di importante interesse storico-artistico che sono testimonianza di civiltà e beni culturali.
La normativa antiriciclaggio, nel più ampio profilo di contrasto «ad ogni attività criminosa» dal 2007, con il dlgs 231 è applicabile anche a: «a) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche in virtù della dichiarazione preventiva prevista dall’articolo 126 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, Ndr); b) i soggetti che esercitano l’attività di case d’astao galleria d’arte ai sensi dell’articolo 115 Tulps», che soggiacciono a tre obblighi fondamentali: identificazione del cliente e «adeguata verifica della sua operatività», registrazione delle operazioni (oltre la soglia) e segnalazioni di operazioni sospette.
Ciò sulla base della Terza Direttiva 2005/60/Ce, valida per tutti i Paesi europei. Col dlgs 125/19 di recepimento della Quinta direttiva europea, dallo scorso novembre gli obblighi vengono estesi anche ai soggetti che conservano o commerciano opere d’arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività sia effettuata all’interno di porti franchi e il valore dell’operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10mila euro. Una norma di chiusura quindi che, oltre ai porti franchi, include qualsiasi intermediario sia nel commercio sia nella conservazione.
Un colpevole silenzio
Dal sito dell’agenzia antiriciclaggio italiana Uif-Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia, tuttavia, emerge che tutta la categoria degli «altri operatori non finanziari» (dove confluiscono anche gli agenti immobiliari, i prestatori di servizi relativi a società e trust, quelli che si occupano di recupero stragiudiziale crediti, gli operatori in valute virtuali e gli antiquari) ha inviato 41 segnalazioni nel 2018 e 81 nel 2019, su un totale di oltre 100mila operazioni sospette per anno.
Nell’assenza o quasi delle segnalazioni dei mercanti d’arte, il mondo bancario si confronta con difficoltà nell’adeguata verifica dei conti interessati dalle relative transazioni, specie per la mancanza di archivi di riferimento con valori attendibili e uniformi.
Se la registrazione dei trasferimenti delle opere vendute in Italia (art. 103 Lda) fosse resa obbligatoria, la sola consultazione di questo registro consentirebbe alla Banca d’Italia di avere immediato accesso a tutte le informazioni sulle transazioni e di incrociare i dati con i movimenti bancari prescindendo dagli indicatori di sospetto, che per il mondo dell’arte non paiono essere così calzanti, posto che la peculiarità delle opere d’arte è che sono sottoposte a un sistema di valore esterno che prescinde da quello intrinseco e di cui una delle componenti fondamentali è il desiderio di possederle, che può portare anche a sostenere un esborso che non è sorretto da razionalità economica, inoltre enfatizzato dal meccanismo della competitività delle aste.
Digitalizzare aiuta
Non si può fare a meno di evidenziare che sebbene arte coincida con cultura, la digitalizzazione del sapere non ha ancora trovato la giusta diffusione, laddove, mascherate da una sorta di «gelosia del sapere», sono pressocché irreperibili online le immagini delle opere autentiche, contenute ad esempio nei cataloghi generali dei vari autori fuori produzione e ciò benché la Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale del 17 maggio 2019 abbia previsto all’art 8 misure volte a consentire a Istituti di tutela del Patrimonio Culturale di mettere a disposizione del pubblico opere librarie fuori commercio.
In proposito, l’avvocato Carlo Mezzetti, chiamato a far parte del panel internazionale di esperti per il diritto d’autore, segnala l’iniziativa di Consorzio Pharos (pharosartresearch.org) e riferisce che verranno digitalizzate e messe online a disposizione del pubblico oltre 25 milioni di immagini con metadati provenienti dagli archivi fotografici di 14 delle più prestigiose istituzioni accademiche di storia dell’arte tra cui Max Planck, Yale, Harvard e Fondazione Zeri.
Collezionare non è un crimine
La crescita del mercato dell’arte secondo Raul Caruso, docente di Economia della criminalità all’Università Cattolica di Milano, «non può essere attribuibile solo al riciclaggio da parte delle mafie ma deve essere ricondotta soprattutto all’aumento del reddito globale, in particolare delle fasce più alte della popolazione». Soprattutto negli Usa i più ricchi hanno visto aumentare di molto la loro ricchezza, con relativa crescita della domanda di opere d’arte, e Caruso sottolinea che «attribuire la crescita del valore di mercato al solo crimine» sarebbe addirittura ingiusto.
Prosegue rimarcando il fatto che «il 50% del mercato è in mano a un ristretto 5% di operatori, tuttavia è indice di un non appropriato meccanismo concorrenziale, poiché, in genere, una maggiore competizione tende a mantenere più moderati i rendimenti e questo potrebbe succedere pure in questo campo anche se più per quanto riguarda le gallerie che non le case d’asta». A suo avviso, inoltre, «la qualificazione di un oggetto come opera d’arte è cruciale. Se li consideriamo solo come beni privati allora può valere il modello classico di impresa, ma se attribuiamo ad essi anche un valore culturale allora l’idea che le imprese del mercato dell’arte possano appartenere a un novus genus di imprese, come ad esempio le benefit corporation (società benefit in Italia) potrebbe essere auspicabile».
Associare alla finalità for profit quella sociale e creare un beneficio comune porterebbe a un mercato più responsabile, trasparente ed etico, ed è concreta la possibilità che l’impresa possa avere rendimenti addirittura più elevati, come dimostra l’esperienza delle quotate che sviluppano e applicano Esg (Environmental, Social, and Governance, misura della sostenibilità e dell’impatto sociale di un investimento).
LA MALA ARTE | Il mercato non è un romanzo criminale
LA MALA ARTE | Il crimine non paga
LA MALA ARTE | La cultura è il miglior detective
LA MALA ARTE | La direttiva antiriciclaggio europea
Altri articoli dell'autore
Nella trasmissione «Report» il caso di un’opera scomparsa in provincia di Torino: ma è veramente la stessa della Collezione Cavallini Sgarbi, attribuita a Rutilio Manetti?
Venduta al Führer nel 1938 dal principe Lancellotti, riportata in Italia da Rodolfo Siviero nel dopoguerra, la statua romana in marmo è di nuovo al centro di una querelle tra Italia e Germania. E nessuno chiarisce il mistero che ha permesso di trasformare un bene privato in un bene pubblico
Una sentenza del Consiglio di Stato dà lo spunto per un parallelo tra il nostro ordinamento e la normativa in materia di beni culturali al di là delle Alpi
Se in mostra c’è un falso, vero o presunto, la colpa è loro. In un caso, poi, le opere esposte erano addirittura fotocopie