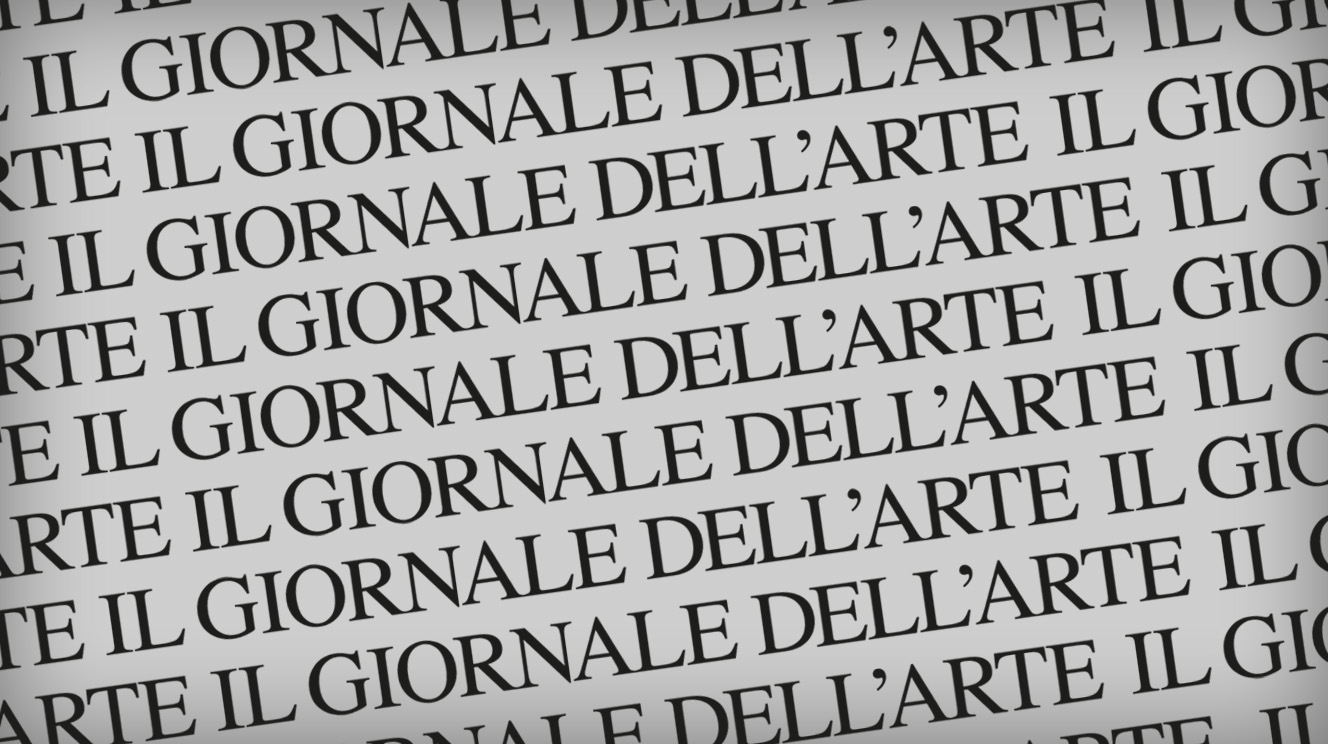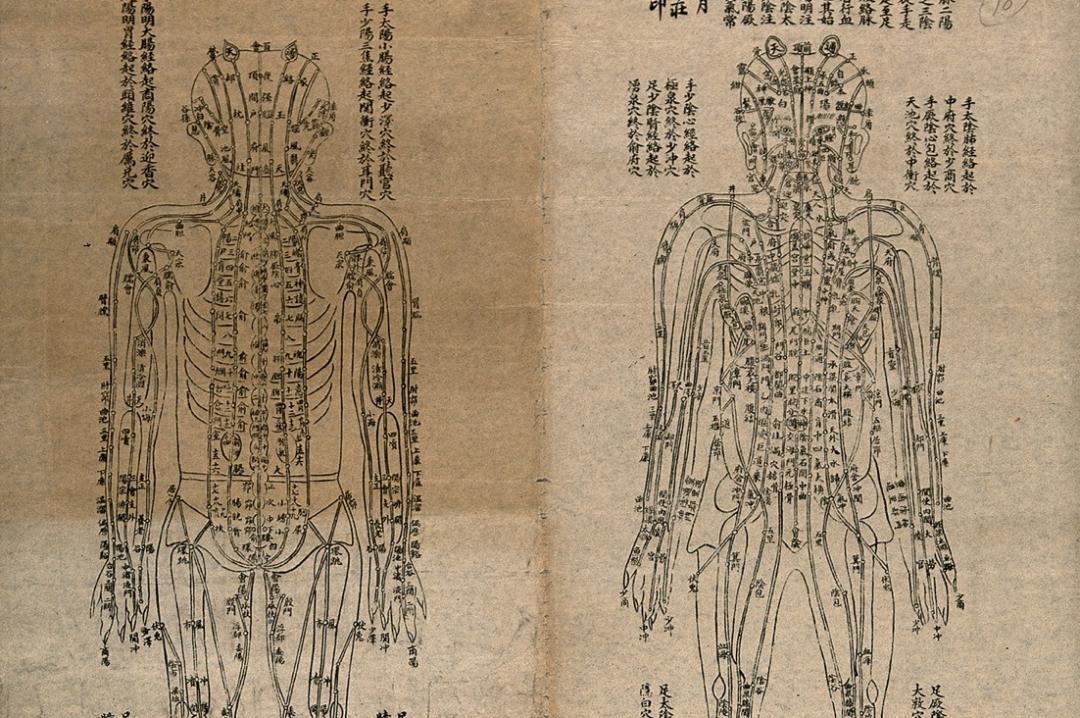Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Veronica Rodenigo
Leggi i suoi articoliProsegue a Palazzo Sarcinelli la triennale programmazione affidata a Civita Tre Venezie. Dopo «Un Cinquecento inquieto», il periodo rinascimentale torna protagonista con «Carpaccio. Vittore e Benedetto da Venezia all’Istria. L’autunno magico di un maestro» a cura di Giandomenico Romanelli. Dal 7 marzo al 28 giugno la mostra indaga gli ultimi dieci anni (1515-25) di attività del maestro veneziano, aggiungendovi le opere del meno noto figlio Benedetto, attivo tra gli anni Trenta e Quaranta del XVI secolo. In tutto una cinquantina di lavori: venti tra tavole e tele (di cui 14 autografe di Vittore, 6 di Benedetto) corredate dai celebri appunti di Giovan Battista Cavalcaselle in prestito dalla Biblioteca Marciana, da alcuni studi carpacceschi provenienti dal Gabinetto di disegni e stampe degli Uffizi, da incisioni con vedute di Pola e Capodistria, carte corografiche dell’Italia, acquerelli raffiguranti il territorio istriano (dal Museo Correr): contesti geografici a cui è strettamente legata la biografia dell’ultimo Carpaccio. A Conegliano giunge un Vittore altro, lontano dai grandi e celeberrimi teleri dei decenni precedenti, quelli del ciclo per le veneziane Scuole di Sant’Orsola e di San Giovanni Evangelista (oggi alle Gallerie dell’Accademia), una parte della sua produzione meno nota (non realizzata solo a Venezia e per Venezia). Alla pala con «I diecimila crocifissi del Monte Ararat» (1515, Gallerie dell’Accademia), «affollatissima e complicatissima», come afferma Augusto Gentili nel saggio in catalogo, e ritraente «il leggendario episodio dei Romani, convertiti al Cristianesimo per diretto intervento angelico e mandati al martirio dal loro stesso imperatore», si aggiungono il polittico per la chiesa veneziana di Santa Fosca (1514 ca), del quale in mostra vengono riaccostate le tre tavole oggi superstiti: «San Pietro Martire» (dal Museo Correr), «San Sebastiano» (dalla Galleria Strossmayer di Zagabria) e «San Rocco con l’offerente Pietro Lippomano» (dall’ Accademia Carrara di Bergamo); il «San Giorgio e il drago» dalla Chiesa di San Giorgio Maggiore a Venezia (1516); il leone marciano di Palazzo Ducale (1516), ma anche la «Presentazione di Gesù al Tempio» e la «Strage degli Innocenti», portelle dell’organo della Cattedrale di Capodistria (1523). «Gli ultimi 10-12 anni della vita di Carpaccio sono stati oscurati da una scarsa attenzione al suo travaglio culturale e pittorico, spiega Romanelli. La mostra riconsidera questa fase in cui Vittore sottopone il suo linguaggio a un’attenta e spietata revisione critica, prendendo le distanze dalla linea vincente di Giorgione e Tiziano. Il cambiamento stilistico riflette l’attenzione nei confronti della svolta storica che si sta consumando in quegli anni (post Lega di Cambrai, Ndr), lontano dalla Venezia splendente, sicura di sé e utopica come nella sua precedente opera. Ad esempio, nella grande pala con la crocifissione dei diecimila martiri s’intravede la drammatica percezione di minaccia; nei cavalieri vi sono insegne turche e imperiali. È una specie di esorcizzazione di un timore incombente. Un cambio linguistico è evidente anche nel “San Paolo Apostolo” nella chiesa di San Domenico di Chioggia, opera sinora sottovalutata e non compresa». Riguardo invece alla figura artistica del figlio Benedetto, Romanelli afferma che si tratta di «una sorta di fantasma della pittura veneziana del Cinquecento. Lavora solo in Istria, sposta la bottega da Venezia a Capodistria e chiede la cittadinanza istriana. Di lui sono conosciute soltanto sei opere firmate e datate. Vi è un intervallo dalla morte del padre (avvenuta tra il 1525 e il 1526) di circa undici anni di cui non si sa nulla. La prima opera è del 1537. Benedetto adotta un linguaggio completamente diverso, molto popolare e molto emotivo: è più naïf. È una produzione che sarà una sorpresa per molti. Si tratta di un altro piano qualitativo, ma sarà interessante vedere quale sia stata l’evoluzione in rapporto all’insegnamento del padre».
Altri articoli dell'autore
A Venezia, tra le sedi di Palazzo Bembo, Palazzo Mora e Giardini della Marinaressa, 207 partecipanti da 52 Paesi danno vita alla settima edizione della mostra «Time Space Existence»
Il nuovo corso delle Procuratie Vecchie prende il nome di San Marco Art Centre, con un programma che abbraccerà le arti visive, l’architettura, la moda, la tecnologia e il cinema
L’energia caotica della città è sempre positiva, ma servono una maggior collaborazione tra istituzioni pubbliche e private e più attenzioni ai trasporti, alle soluzioni abitative anche per i semiresidenti, alle fragilità strutturali e all’equilibrio fra tutela e accessibilità. Ne parlano la direttrice della Peggy Guggenheim Collection e l’ex direttrice delle Gallerie dell’Accademia
Lo studio Amo/Oma, ospite della Fondazione Prada a Venezia, promuove il dialogo e la riflessione speculativa sul rapporto tra l’intelligenza umana, i fenomeni scientifici e culturali, la creazione e la diffusione della conoscenza