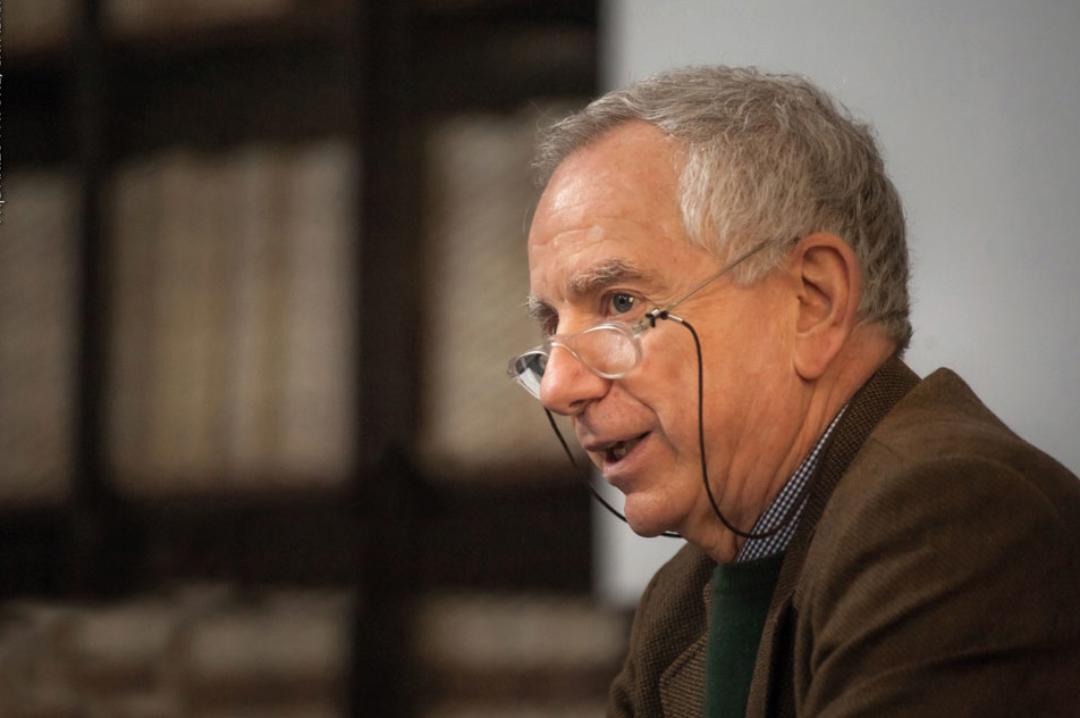Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
.jpeg)
Quando avevo poco più di vent’anni e il Ministero dei Beni culturali era appena nato, mi trovai catapultato in un «Comitato paritetico Stato-Regione per il patrimonio culturale» e lì appresi dalla voce del direttore della Biblioteca Nazionale di Roma che c’era poco da discutere sugli orari di apertura, perché il suo compito istituzionale era quello di conservare i libri, non di farli leggere! Formalmente, forse, aveva pure ragione lui; ma col senno di poi misuriamo ogni giorno quanto quella mentalità sia dura a morire e si sia riprodotta «per li rami» incurante del fatto che il mondo in cui viviamo conserva ben poco di quello nel quale fummo istruiti.
Questo piccolo ricordo biografico penso che metta a nudo uno dei gap principali del rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadini, che riguarda la mentalità ancora troppo diffusa ai diversi livelli dirigenziali della struttura. Una questione di mentalità affiora certo in ogni ganglio dell’Amministrazione statale, ma la natura dell’oggetto amministrato (il patrimonio culturale) e dei soggetti coinvolti (le persone singole o associate desiderose di cultura) carica le decisioni e i comportamenti assunti in questo campo di effetti rilevanti sul «sistema Paese» nel suo complesso.
È una questione di mentalità, se lo Stato si presenta con le sue (pur necessarie) funzioni impeditive (vincoli, autorizzazioni, divieti), piuttosto che con la sua fondamentale funzione di servizio (trasparenza, sportelli per gli utenti, libera circolazione dei dati). Una mentalità che trasforma in macigni insormontabili una serie di «questioni pratiche», non impossibili da risolvere se solo ci fosse maggiore capacità di collaborazione e una minore tendenza a erigere steccati intorno al proprio territorio o al proprio museo, figli di una concezione proprietaria del patrimonio che è all’origine di tante distorsioni. Molte questioni aperte possono essere risolte infatti con soluzioni tecniche o tecnologiche, ma solo se non si eludono i problemi strutturali di fondo e le visioni culturali che li hanno generati.
Bene quindi se si trovano nuove risorse e si accelera l’immissione di nuovo personale, come il ministro ha promesso, per garantire quella fondamentale trasmissione di esperienze e di conoscenze tecnico-professionali qualificate, da una generazione all’altra, che rischia di venir meno in assenza di nuovi interlocutori. Questa trasmissione, tuttavia, sarebbe bene coincidesse anche con una forte soluzione di continuità: in fatto di mentalità, cioè di concezione proprietaria del patrimonio e di mancanza del concetto di servizio pubblico applicato alla sua tutela, c’è ben poco da trasmettere e molto da modificare.
Questa mentalità fa danni a destra e a manca, all’esterno e all’interno stesso dell’Amministrazione. Gli archeologi italiani ricordano bene che, nel mezzo delle recenti riforme, l’allora ancora esistente Direzione generale Archeologia toccò il vertice di una sprezzante visione dell’interesse generale emanando alcune circolari «della vergogna», relative alle procedure di concessioni di scavo archeologico, che calpestavano con un solo foglio la libertà della ricerca garantita dall’art. 33 della Costituzione, il dovere della funzione formativa delle Università e la loro libertà di iniziativa economica. Davvero un bel risultato per un direttore giurista!
All’interno dell’Amministrazione uno dei nodi più sgradevoli venuti al pettine con la riforma dei musei riguarda i rapporti talora difficilissimi tra le Soprintendenze territoriali, da un lato, e i Poli museali e i musei autonomi dall’altro, per quanto riguarda la valorizzazione dei materiali provenienti dalle attività di scavo condotte dalle prime, oggetto di valorizzazione, in linea di principio, da parte dei secondi.
Ovviamente, nulla osta a che i diversi istituti, in uno spirito di normale e leale collaborazione (tanto più basilare in organi periferici pertinenti a un medesimo Ministero), operino congiuntamente al fine di tramutare in «diffusione di conoscenza» ciò che è stato prodotto in «attività di salvaguardia» del patrimonio. In altri Paesi questa è prassi consolidata, che non genera alcun contenzioso. Presso le nostre strutture ministeriali tale paradossale conflitto è invece emerso in numerosi casi, mettendo in luce non soltanto sgradevoli personalismi, ma anche una inveterata abitudine a perdere di vista la funzione sociale allargata delle attività di quegli istituti, mortificata da una fatica alla collaborazione che denuncia innanzitutto, ancora una volta, una questione di mentalità.
Certo, le mentalità si cambiano innanzitutto con l’educazione, quindi con la formazione, ma anche con la messa in campo di sistemi di comportamenti alternativi, e non per questo meno efficienti ed efficaci. E quindi da un lato con i processi di reclutamento e dall’altro con le procedure di valutazione del personale e la scelta dei relativi parametri.
Ma si cambiano anche con piccoli gesti: ad esempio chiedendo urgentemente al Parlamento di ratificare finalmente la Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale, figlia legittima della Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo del 1948. Quel testo, fondato sul concetto del diritto dei cittadini al patrimonio culturale, è una ventata di aria nuova, che da sola non basta, ma certo apre le finestre del Ministero e dà ossigeno a chi vi lavora dentro e a chi ne sta fuori.
Questa richiesta reca il n. 20 tra 127 suggerimenti che «Il Giornale dell’Arte» ha avuto il senso civico di sottoporre alla attenzione del ministro Bonisoli. È del tutto normale che a un nuovo ministro ciascuno cerchi di tirare la giacchetta e a lui spetterà di apprezzare la concretezza e i contenuti del servizio reso da questo giornale con la sensibilità e la responsabilità delle risposte che vorrà o saprà dare. Il mio consiglio non richiesto? Cominci dal più difficile: metta al centro il cambio di mentalità: se no, che cambiamento è?

Daniele Manacorda
Altri articoli dell'autore
L’ultimo libro di Giuliano De Felice per Laterza secondo Daniele Manacorda opera una «“scelta di campo” rischiosa»
L’archeologo Daniele Manacorda traccia una road map per il neonominato al dicastero del Collegio Romano
Il vero problema sembra essere la nuova (vecchia) organizzazione per Dipartimenti, già varata ai tempi del ministro Buttiglione e presto abbandonata non per motivi politici, ma perché ritenuta non adeguata a un Dicastero come quello della Cultura, capillarmente distribuito sul territorio
Considerazioni sul decreto ministeriale sui canoni di concessione d’uso della immagini del patrimonio culturale pubblico