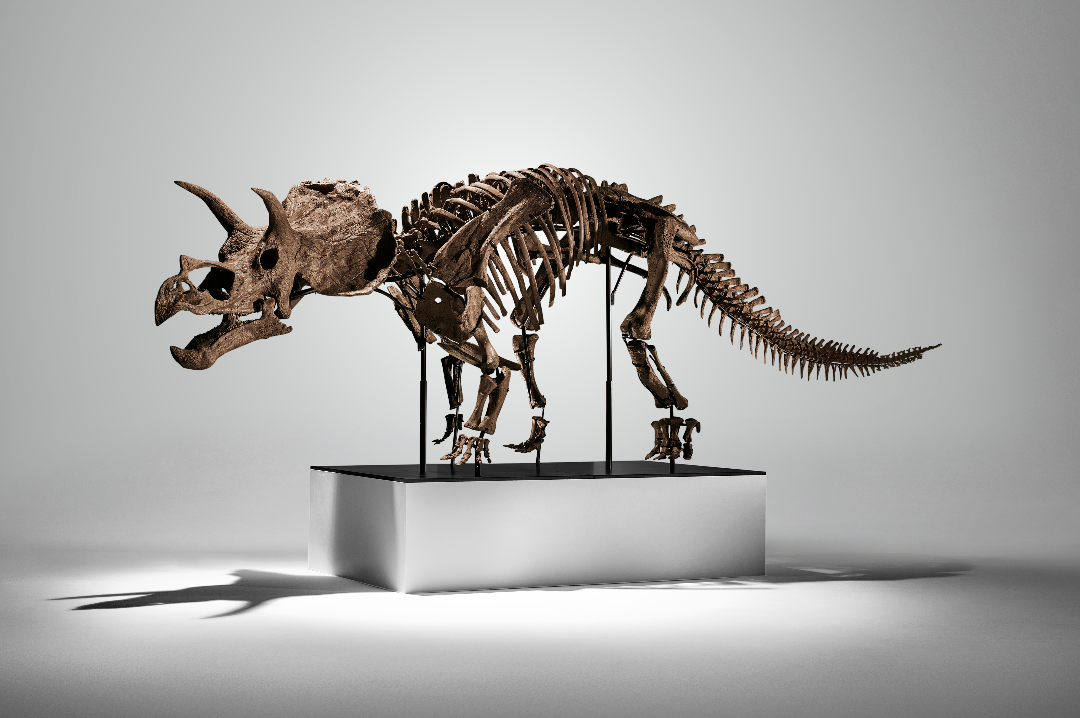Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Redazione
Leggi i suoi articoliIl critico Germano Celant firma in questi giorni due mostre di particolare rilievo: la grande antologica di Vedova a Venezia e «Coerenza/In Coerenza» alla Mole Antonelliana di Torino. Di entrambe «Il Giornale dell’Arte» ha dato notizia nel numero scorso. Tra i critici italiani d’arte contemporanea, il 44enne Celant occupa un luogo volutamente appartato: egli trascorre buona parte dell’anno negli Stati Uniti per incarichi universitari, è condirettore della rivista «Artforum» di New York. Il suo nome è intimamente legato a quello degli artisti dell’Arte Povera. Voce indubbiamente «diversa», in un paesaggio turbolento qual è quello dell’arte italiana, Celant ha stabilito una rete di personali collegamenti internazionali che gli consentono una visione abbastanza distaccata dei fatti locali. Deliberatamente incline ad una forte specializzazione e ad una rigida selezione dei suoi interessi (due aspetti che emergono in questa intervista), è tutto sommato una figura abbastanza «misteriosa» tra i nostri operatori culturali, intanto per la sua reticenza ad aprirsi a nuovi contatti ma anche per l’immagine pubblica che ha costruito di sé stesso (per anni si è vestito sempre totalmente di nero, pantaloni e camicia, e portato i capelli annodati con un codino sulla nuca). La sua scarsa propensione a uscire dal «privato» lo ha reso refrattario a concedere interviste: questa è non solo la più lunga, ma anche l’unica in cui ha consentito a parlare di sé stesso.
Professor Celant, vogliamo iniziare da un fatto di attualità? Nella situazione dell’arte contemporanea in Italia c’è in questi giorni un fatto nuovo che può significare un giro di boa. Per la prima volta non solo uno straniero viene incaricato di progettare una istituzione culturale italiana (ci riferiamo alla nomina di Rudi Fuchs al Castello di Rivoli, di cui «Il Giornale dell’Arte» ha dato notizia in anteprima nel numero scorso), ma una istituzione pubblica cerca di darsi una struttura privatistica o comunque autonoma per consentirsi una maggiore mobilità fuori dagli impacci burocratici e per sfuggire alle lottizzazioni dei partiti, politici e non, e una città come Torino tenta un vistoso recupero della leadership nell’arte contemporanea che aveva avuto negli anni ’60 e in parte ’70 non solo in Italia. Lei è genovese, ma conosce assai bene Torino, patria dell’Arte Povera di cui lei è stato l’esegeta. In base anche alle sue esperienze all’estero, che possibilità ha Torino di farcela? Crede che sia una «svolta» in Italia?
In questo momento in Italia non c’è una città totalmente aperta all’arte contemporanea. Ci sono città che potrebbero assumere una forza culturale notevole perché hanno un pubblico naturale (quella massa di viandanti internazionali che assicurano un’alta frequenza di pubblico) e sono Venezia e Firenze, tuttavia vivono ancora «in trazione storica». Manca una città vettore per l’arte moderna e contemporanea, se Venezia e Firenze lo capissero, avrebbero un potenziale energetico enorme. Nessuno rifiuterebbe un invito culturale da Firenze o da Venezia. Rispetto all’Italia, Milano e Roma, che sono le capitali industriale e politica, trovano invece difficoltà a coagulare le loro forze. Sono città senza quiete con una bagarre che dissangua le migliori energie intellettuali. Rimane quindi Torino che per la sua segretezza e per quel suo leggendario modo di fare, può diventare leader e riavere una funzione esplosiva, la stessa che aveva già avuto negli anni ’50/60. Un’istituzione a Torino nella sua riservatezza può avere una risonanza incredibile. A Milano rischia invece di disperdersi all’interno di una selva di macro e micro eventi concorrenziali e a Roma di diventare un’operazione politica complicatissima. Torino è invece una città manageriale e può rappresentare l’Italia a livello europeo come, in Germania, Düsseldorf e Colonia, rispetto a Bonn e Berlino.
Lei ritiene insomma che Torino potrebbe avere un ruolo internazionale nell’arte contemporanea equivalente a quello che la Fiat ha nel campo industriale?
L’analogia è pertinente, perché la leadership artistica oggi coincide con i grandi centri economici e manageriali, non con quelli simbolici o politici, penso a New York, rispetto a Washington. Certamente una presenza attiva del mondo industriale torinese nel campo della cultura accelererebbe questo processo. I contenitori e gli intellettuali non mancano, forse fanno difetto il desiderio ed il piacere di una partecipazione culturale che può essere svolta tra pubblico e privato, tra municipalità e industria, in maniera eccezionale ed unica. Ma conoscendo Torino (la frequento dal 1962) sento che sta arrivando (sempre cautamente ma tenacemente) ad una configurazione internazionale.
Non è allora una città assopita?
Personalmente l’ho percepita sempre come un centro in continuo fermento, mai appariscente, ma oggi con la dimensione internazionale e massmediale della cultura bisogna che esca all’aperto e se lo farà sono certo che ciò avverrà in modo professionale, un operare che è mancato in Italia. D’altronde è la sola ad aver capito che l’unica possibilità oggi per un centro d’arte come per una Biennale, è che il direttore sia uno storico dell’arte ed un manager, sul tipo di Pontus Hulten o di Harald Szeemann.
È infatti l’unica ad aver concepito una conduzione privatistica per un’iniziativa pubblica come il Castello di Rivoli.
Questo rapporto privato-pubblico mi sembra rientrare nella tradizione illuminata di Torino, penso al dialogo Galleria Civica ed Amici del Museo e dell’Arte, alla collaborazione Municipalità e Assicurazioni Toro per Calder, una sintonia operativa che potrebbe trasformare sia Rivoli quanto i musei torinesi in un network artistico mondiale. Il Castello di Rivoli potrebbe diventare un «parcheggio» per l’arte contemporanea, ha però già perso la collezione Panza con il suo enorme valore storico, per cui dovrà perdere nuovamente energia nel recupero dell’ultimo passato. Certo se si riuscisse a trovare un modo di integrare la collezione Panza con una grande raccolta di arte italiana ed europea degli stessi anni, tra Rivoli e Torino, l’avvenimento susciterebbe uno scalpore notevole. Personalmente lascerei la collezione Panza a Rivoli per cercare in città un altro contenitore simile al Castello dove raccogliere l’arte europea tentando, nell’arco del tempo, un’integrazione ed una connessione che creino anche un contesto socio-culturale.
Attingendo a collezioni private?
In Italia si può solo attingere alle collezioni private e ai prestiti permanenti degli artisti.
Come Torino ha iniziato con la collezione Panza di Biumo, sempre che la donazione venga confermata. La griffe Panza di Biumo è molto rassicurante.
Non credo si tratti di griffe, ma di qualità delle opere degli artisti americani a cui farei corrispondere quella dei nostri artisti come di quelli europei. Riuscendo a raccogliere in un unico centro urbano ambienti di Flavin, Judd, Andre, Nauman, LeWitt, Ryman, Nord-man, Irwin, Turrell, Serra, Morris, insieme a spazi di Merz, Kou-nellis, Beuys, Long, Fabro, Kiefer, Darboven, Horn, Paolini, Broodthaers, Penone, Cragg, Baselitz, Lavier, Buren, Pistoletto, Nitsch, Penck, etc. che sono i corrispettivi storici degli artisti nella collezione Panza, più un settore dedicato agli anni Ottanta, con questa ricchezza si potrebbe realizzare un complesso museale capace di competere con il Museum of Modem Art di New York o di Los Angeles. Se la parte americana è coperta perché rinunciarvi? Meglio allargare e coprire la parte europea, i tagli (e la ferita Panza non è facilmente rimarginabile) sono controproducenti, meglio avere una città che si connota con raccolte dal 1960 ad oggi, che un centro di transiti espositivi. Lancerei quindi le forze di Torino sull’arte europea, che è anche un segno di leadership precisa e lascerei a Rivoli, a causa anche del suo isolamento e della sua distanza, la preziosità americana.
Quali sono le più interessanti iniziative oggi sul piano internazionale?
Una situazione interessante è quella di Los Angeles dove non solo si sta costituendo il nuovo Museum of Contemporary Art (quello che ha comprato 80 opere della collezione Panza, per intenderci), ma dove il County Museum sta costruendo un nuovo edificio, per capienza doppio del Whitney, che sarà dedicato all’arte contemporanea. Ma per entrambi il problema sarà quello delle collezioni, il cui gap è quasi incolmabile. Certamente a Los Angeles i mezzi non mancano e stanno già lavorando per chiamare un curatore di livello internazionale. Le voci sono per un europeo.
A lei piacerebbe dirigere un museo?
Data l’esperienza, credo di essere pronto e mi auguro che sia in Italia, anche se le richieste sono americane.
Quali chance ha l’Italia nella nuova cultura internazionale?
L’Italia è dissanguata perché c’è una lotta spossante all’interno e intorno a piccole operazioni: si veda la cattiva qualità delle polemiche. Bisognerebbe invece tentare un lavoro di coagulazione dei valori; invece la situazione italiana è a livello di faide medievali, dove ogni feudatario si contende il piccolo territorio intorno alle mura del suo castello teorico e si batte furiosamente con l’altro feudatario per Vius primae noctis con l’artista. Inoltre le discussioni non sono più scientifiche, tra esperti e tecnici, ma tra uomini di partito e di clientela. Una visione «professionale» del problema riporterebbe il dibattito non sulle offese volgari e sui pettegolezzi, ma sul significato del lavoro. Ma in Italia la cultura è idealista, fondamentalmente crociana, per cui «bello» e produzione vanno ancora separati. Da noi gli storici dell’arte hanno un doppio lavoro: insegnano nelle università e poi in genere hanno l’hobby di scrivere sull’arte contemporanea. Nelle culture anglosassoni, fare cultura contemporanea è una professione riconosciuta, i cui addetti non hanno bisogno di un secondo lavoro.
Tuttavia l’Italia in questo momento è forse il maggior produttore di arte, di editoria e di manifestazioni artistiche.
L’editoria italiana è invidiata in tutto il mondo. Nessuno capisce come possa produrre una così alta quantità di titoli. La ragione è che qui sono sufficienti 3mila copie per la sopravvivenza, mentre gli americani, per esempio, se non fanno 15mila copie non riescono a pareggiare i costi. Possiamo ancora permetterci di essere agili, di non avere strutture rigide e quindi possiamo produrre un’editoria e un’attività di mostre unica al mondo, anche grazie alle amministrazioni civiche e regionali, mentre se mettiamo sulla bilancia le mostre museali, rispetto agli altri paesi, l’Italia non esiste. Gli assessori alla cultura hanno creato un modo di fare politica culturale invidiato nel mondo: l’assessore di New York non può fare le mostre che fa quello di Roma, di Milano e di Torino. Ma questa cultura, definita «dell’effimero», non ha creato strutture scientifiche permanenti, quelle che permettono la continuità e la storicizzazione.
La dispersione e lo spreco sono in effetti impressionanti. Basti pensare a che cosa potrebbero essere i musei se potessero essere loro ad organizzare le mostre con il denaro che invece spendono direttamente gli assessori. Gli assessori, che sono emanazioni dei partiti e non vengono certo nominati in base a requisiti scientifici, non intendono rinunciare a controllare la spesa culturale. Per altro verso, i musei sono in mano a burocrati di carriera, che non hanno nessun motivo di prendersi dei mal di pancia per fare più dello stretto indispensabile, se non in rari casi di abnegazione personale.
Esiste il grosso problema della parcellizzazione partitica, qui non si pone l’incarico a tempo, tipico dell’America o del resto dell’Europa, anche se si comincia a capire che avere all’interno della struttura un burocrate per vent’anni, è negativo. Ma pian piano, l’idea di avere un direttore per chiamata e non più per concorso, si farà strada.
C’è poi il problema delle sovrapposizioni e delle ripetizioni. A Milano aprono Brera 2 e nello stesso tempo il Museo Comunale a Palazzo Reale. A Torino la Galleria Civica è chiusa, ma apre Rivoli, e a Roma, dove c’è già la Galleria Nazionale, vogliono aprire il Museo Comunale.
Che aprano musei e spazi per l’arte è sempre positivo: la stupenda iniziativa di Burri a Brera due lo dimostra. Certamente una programmazione ed una specificità degli spazi sarebbe augurabile. Non si possono aprire musei, tutti con gli stessi e rari nomi di rilievo ed il codazzo degli artisti locali, invitati per rapporto clientelare e partitico. I musei devono oramai specializzarsi: per territorio, per secolo, anche per decenni, per aree di attraversamento. Il museo nominalista è morto cinquant’anni fa. Ma forse applico a questa ipotesi il mio metodo. Nell’arco del mio lavoro, di oltre vent’anni, ho cercato di selezionare a priori. Mi sono occupato soltanto di una cinquantina di artisti, seguendoli nel loro percorso. Molti critici preferiscono invece scrivere su chiunque per selezionare a posteriori, e se si leggono i loro libri, le loro introduzioni in cataloghi e le loro selezioni in mostre collettive si possono vedere tutti i cadaverini abbandonati nel corso del tempo. Personalmente ho teso a selezionare in maniera drastica le mie scehe, cercando di inserirle in un contesto di linguaggi diversi. Ho sempre spaziato nel campo dell’architettura, da Nizzoli a Valle, della musica e del teatro, da Class a Foreman, da Monk alla Zattera di Babele, della danza da Brown a Jonas, operando un intreccio di lingue e di situazioni culturali, come dimostrano il recente lavoro sull’«Identité Italienne» al Beaubourg oppure le contestualizzazioni socio-artistiche su Merz, Kounellis, Pistoletto e Vedova. Sono scelte di metodo che non considerano l’arte una pista di pattinaggio per il critico, ma un iceberg da studiare e da capire nel suo oceano. È con quest’attitudine che arriverò ad occuparmi in maniera profonda e scientifica di artisti come Burri, Rauschenberg ed Oldenburg che non appartengono alla mia generazione, ma sono momenti miliari della storia dell’arte contemporanea. Il museo secondo me dovrebbe essere fatto con la stessa determinazione, rappresentare una cultura nelle sue emergenze massime, non nel piccolo cabotaggio delle apparizioni effimere. Una delle proposte che avevo fatto a Documenta era di presentare le 50 personalità emergenti nel mondo della cultura visiva, comprendendo fotografi, architetti, designers, film-maker e artisti, i migliori del mondo, quasi con questo titolo. Sarebbe risultata una mostra contestatissima, ma anche una dichiarazione storica.
Rischiosissima.
Certo, ma la scelta comporta sempre una presa di posizione e, sbagliando, la «decapitazione». Tuttavia gli esempi confortanti sono dinnanzi a tutti: a Stoccolma la scelta di Pontus Hulten ha permesso la creazione di un museo eccezionale con mezzi irrisori, lo stesso dicasi per la collezione Panza di Biumo. Certo la personalizzazione comporta esclusioni e assenze notevoli, ma oggi il museo deve essere, oltre che oggettivo, anche soggettivo ed eccezionale. L’unico sistema per creare quest'evento è l’ossessione, come quella di Sandberg ad Amsterdam e di Szeemann a Berna. La pazienza della raccolta maniacale d’arte europea ed americana di A. Barr ha fatto il Museum of Modem Art, lo stesso Quintavalle rientra in questa cerchia di assatanati per il documento e la comunicazione. Diciamo che è un virus molto energetico per il museo, certo bisogna alimentarlo con fondi e possibilità di movimento.
Anche le mostre dovrebbero essere fatte con lo stesso sistema?
La mostra non dovrebbe essere un mero elenco di nomi, ma una scoperta di materiale e di interpretazione storico-critica. Sto progettando una mostra inedita, come era stata «l’Ambiente Arte» alla Biennale del ’76. Ho fatto scoperte di materiale mai raccolto ed esposto, come un Frank Kline e un Miró di dieci metri.
Che cos’è questa mostra?
È un’esposizione sugli interventi degli artisti in teatro dal 1900 al 1984, ho trovato costumi, scenari, macchine teatrali, props di happening, modellini, perfettamente conservati e pronti per essere esposti, non solo tutte le azioni anni sessanta con Johns, Gutai, Grooms, Beuys, ma anche de Chirico, Miró, Grosz, ecc., una mostra mai fatta e che spero circolerà in Europa e in Usa.
Una lettrice ci ha scritto chiedendoci come si diventa critico d’arte. Lei come ha fatto?
A 16 anni, a Genova, frequentavo un certo ambiente culturale che gravitava intorno ad Ezra Pound, che viveva a Rapallo. Venivo da una famiglia piccolo borghese e questi personaggi strani mi hanno subito sedotto. Come tutti i ragazzi, credo, mi sono interessato di letteratura e di teatro, da Beckett, con il famoso Teatro dell’Arlecchino, dove c’era Paolo Poli, a lonesco. Alla fine degli anni ’50, quando sono passato all’università, ero molto intriso di questo humus, ma ho seguito la scelta dettata dai genitori, iscrivendomi a Ingegneria. Contemporaneamente frequentavo questi personaggi diversi, sia del mondo della musica, sia della letteratura. Ho organizzato, come ufficio stampa, i primi festival latino-americani e pana-fricani. Frequentai cosi Gato Barbieri e Glauber Rocha, e molti intellettuali arabi. In ingegneria non ero bravo, Togliatti, il fratello di Palmiro, mi dava votacci tremendi. Nel 1961 Eugenio Battisti venne ad insegnare alla Facoltà di Lettere, teneva lezioni molto interessanti, divenni suo allievo. Mi inventai un Centro Universitario Arti visive, dopo essere stato in quello del cinema: invitai Argan ed Eco, Calvesi e Pasolini, Bartolucci e Straub. Le mie amicizie erano sempre più artistiche. Battisti ad un certo punto decise di fondare la rivista «marcatré», mi chiese se ero disposto a lavorarci non pagato. Accettai e frequentai come direttori di sezione Portoghesi, Gelmetti, Eco, Carpitella, Sanguineti ed altri. È stata la prima rivista interdisciplinare in Italia. Un anno dopo nel 1964 insieme a Battisti ed Ezia Gavazza decidemmo di fondare un Museo d’Arte Contemporanea, basato sulle donazioni degli artisti. Le scelte furono in retrospettiva forse facili, ma l’iniziativa era importante, se fosse continuata.
Aveva già deciso cosa fare da grande?
Avevo intuito uno spazio iscrivendomi a Storia dell’arte, ma sopravvivevo facendo il giocatore professionista di biliardo, un sostentamento che mi ha insegnato la strategia sull’avversario. Con Battisti ero sottoposto ad un fuoco di idee, è sempre stato una mitragliatrice. Per «marcatré» ho iniziato a curare la cronaca d’arte e facevo il giro di tutte le città italiane, cosi sono arrivato a conoscere direttamente i galleristi e gli artisti più importanti. In prima persona nei loro spazi e studi, come Schwarz e Fontana, De Martiis e Kounellis. A Torino ho incontrato Gian Enzo Sperone, Paolini e Pistoletto, Carla Lanzi e Pistoi, ed è stato un momento di energia che si è ripercosso su tutti gli anni a venire. Nel 1965, Mendini mi chiama a Milano per la rubrica d'arte di «Casabella», su cui seguendo i miei interessi scrivo di architettura ed arte, cinema e design, continuando quella «confusione» delle lingue che mi ha sempre attratto. Nel ’67 pubblico un libro con Comunità; una monografia su Marcello Nizzoli, il primo designer italiano: un libro molto immaturo, se si vuole, però una sana ricerca su un designer di grande rilievo. Tutto questo mi ha immesso in una circolazione di amicizie e di rapporti, per esempio con Apollonio e con Dorfles, internazionali. Avevo 27 anni; il libro sull’arte Povera è venuto due anni dopo. Se ne sono vendute 20mila copie in quattro lingue è stato un successo mondiale che mi ha procurato le prime richieste di conferenze in Canada (allora parlavo malissimo inglese) e in America.
Come è avvenuto il suo incontro con l’Arte Povera?
Venivo da una situazione abbastanza interdisciplinare, quella dei rapporti tra arte e ambiente, del radicai design e del teatro per strada. Nel 1963 a Genova avevo frequentato il Living Theater, poi le discussioni politiche e culturali con film-maker ed artisti, l’impatto di Eco con la sua valigia piena di fumetti in un’aula universitaria. Nel 1965, influenzato positivamente da Apollonio, mi interessai di arte programmata e dei suoi aspetti utopici, le letture di Norman Brown e l’arrivo dell’erba; una situazione molto intensa che a Torino trova i corrispettivi negli artisti. In questa città potei vedere Kline e gli espressionisti astratti, le opere pop da Sperone, i Bacon da Tazzoli e quadri incredibili di Licini, Balla e Pollock da Pistoi. Carla Lonzi era un polo energetico ineguagliabile, la sua presenza ha mutato la storia, non solo dell’arte, italiana. Dal 1963 passo sempre più tempo con Paolini, Mondino, Pistoletto, Sperone, Pistoi e Gilardi, vedo i lavori di Rauschenberg e Warhol, Lichtenstein e Dine, Schifano e Kounellis, insomma tocco il polso alla situazione internazionale, vivendola in maniera diretta ed osmotica. Nel 1964 la Biennale premia gli americani, ma per me Torino è il punto di riferimento mondiale. La Pop era un movimento storico se non superato, almeno superabile. Pascali viene ad esporre i cannoni, che Roma non voleva, poi Kounellis che con la sua visione diventa subito un protagonista nel nostro viaggio. Nel 1966 dalla Stein incontro Boetti, diventiamo amici, scrivo i testi per il suo catalogo a Genova. Le sere si passano discutendo, completamente «fatti», di arte e di visione, in una stanza in corso Vittorio con tutti gli artisti torinesi. Così quando si arriva a definire, insieme, una visione iconoclasta rispetto alla pittura dell’epoca e, certamente, anche di oggi, l’operazione mi sembra naturale. Nascono rapporti di amicizia e inizia l’avventura dell’Arte Povera, dapprima con le sue verifiche italiane e, in seguito, americane ed europee. A Milano incontro Szeemann che sta curando «When attitudes become form» e ci scambiamo indirizzi e informazioni, nasce così l’Arte Povera pubblicata da Mazzotta, Prager, Studio Vista e Wasmuth. Questa viene recensita sul «New Yorker» da Harold Rosenberg che mi vuole in Usa per una serie di conferenze. Comincia così il rapporto con l’America.
Perché si vestiva sempre di nero?
Mi piaceva molto il non colore, inoltre quando impari a viaggiare, è il colore più funzionale. Nel ’68 in Germania, incontro Beuys, anche lui vestito sempre uguale. Ne parliamo, e capisco che nella cultura contemporanea bisognava disegnare una propria immagine forte e costante. Questo mi piaceva molto, avere un’identità che era quasi atavica e, nella fermezza, diventava antica. Il mio vestire in nero era come il cappello per Beuys, un segno di identità.
Quando è giunto ad essere certo della sua scelta professionale?
Ho capito che la scrittura sull’arte, praticata in maniera molto seria, da storico dell’arte, dava una possibilità di sopravvivenza. Il mio training era di storico dell’arte antica: Battisti mi aveva educato sul barocco e sull’iconologia, mi aveva svelato Panofski. Anche lo studio dell’arte contemporanea andava fatto con lo stesso metodo. Così oggi quando produco un catalogo su un mio contemporaneo, attuo la ricerca come se fosse Tiziano, lo tratto come un Raffaello del mio tempo: che poi la mia scelta sia giusta o sbagliata, lascio il giudizio al tempo, ma la metodologia comunque deve essere la stessa. La ricerca deve essere scientifica e documentata. Non amo la definizione di critico d’arte contemporanea bensì quella di storico dell’arte contemporanea, perché ho questa malformazione positiva di non scrivere su tutto. Perciò non riesco a collaborare con i giornali che sono costretti a suggerire i soggetti di cronaca, gli argomenti voglio scegliermeli anche se fuori dell’attualità. Per questo non riesco a pattinare sull’arte, preferisco lo studio, l’ancoraggio dell’iceberg.
Quali sono state le gratificazioni maggiori che ha ricavato da questa attività?
Il rapporto di fiducia con gli artisti con cui ho diviso la mia passione. Ho avuto sempre un rapporto molto intenso e generoso, come nell’ultimo caso con Vedova. Non c’eravamo mai incontrati, ma siamo riusciti, dopo enormi diffidenze, ad amalgamare un lavoro che mi auguro sia reciprocamente molto importante. Lo stesso è avvenuto con Kounellis, Merz, Beuys, Pistoletto, Paolini e sta avvenendo con Gehry, Oldenburg e Burri. Il rapporto con il pubblico non mi è mai importato molto, anche per una questione di timidezza ed ombrosità. Quando abbiamo stampato ventimila copie dell’Arte Povera non capivo cos’erano migliaia di lettori. Non lo capisco neppure ora, la carica mi è data dall’ossessione di fare un certo lavoro che deve essere confermato da un numero ristretto di compagni e di compagne di strada. Ventimila copie ti danno sicurezza, ma non scambio di idee e di sensibilità. Bisogna stare attenti a non passare da una dimensione energetica ad una dispersione pubblica. Non ho mai presentato pubblicamente un mio libro, le mie interviste si contano sulle punta delle dita: questa è certamente la più lunga di tutta la mia vita. È un modo di restare personale, nel proprio interno per non offrirsi pubblicamente.
Oggi si parla di nomadismo: non vi è dubbio che lei lo sia, ma in realtà non molti sanno che cosa fa mentre va in giro fuori d’Italia.
Con l’uscita del libro Arte Povera ho iniziato a muovermi non solo in Europa ma in America. Dal 1969 tengo regolarmente seminari sull’arte europea ed italiana nelle varie università degli Stati Uniti. È stato un contatto molto stimolante che mi ha permesso di conoscere e far conoscere la cultura americana in Europa quanto di diffondere la cultura europea in America. Dal 1972 ho cominciato a curare mostre e congressi per i musei e le facoltà d’arte, come l’esposizione su Piero Manzoni nei musei di Houston, Chicago e Seattle, le mostre itineranti sul disco e il libro d’artista in sei musei americani e canadesi, a collaborare all’esposizione sul futurismo italiano al Philadelphia Museum, su «Italian landscape» al MoMA di New York, su «Space» a Berkeley Museum fino al «Modo Italiano» a Los Angeles, oppure all’ultimo seminario, sempre in California, sull’«Art as Opera» con Laurie Anderson, David Byrne e PhiI Glass che concerneva la babele delle arti. Dallo stesso anno, abito regolarmente da quattro a sei mesi, tra Los Angeles e New York, tanto che nel 1979 sono stato invitato a codirigere, insieme ad Ingrid Sischy, la rivista «Artforum» che è, a detta di tutti, la rivista d’arte contemporanea più autorevole del mondo. Attraverso le sue pagine è iniziato quel dialogo Europa-America sempre auspicato, ma mai attuato sino agli anni Ottanta. Ora che si è realizzato, stiamo già pensando ad altro.
A che cosa?
Se una nuova cultura dovrà esistere non sarà né europea né americana, ma nascerà dall’unione tra Oriente ed Occidente. Se prima si parlava di arte italiana perché fatta a Torino e a Milano, a Roma e a Napoli, poi si è parlato di cultura europea fatta dall’Italia, dalla Francia, dalla Germania e dall’Inghilterra, adesso il passaggio sarà un’osmosi tra culture internazionali, non solo Europa ed America, che provengono dallo stesso ceppo, ma Giappone ed India, Messico e America Latina. È un’esperienza dell’ibrido che in un paese polirazziale come l’America è evidente.
È un’esperienza che le viene dall’insegnamento?
A parte il mio breve e recente «soggiorno» alla Facoltà di Architettura di Milano, come professore a contratto, ho solo esperienza americana. La mia attitudine all’insegnamento è nomade, mi accampo in un campus per una settimana o due e condivido le mie esperienze per ore ed ore con gli studenti. Così quando sono chiamato ad insegnare a Los Angeles o a New York, a Chicago o a Toronto, passo settimane molto intense con gli studenti che provengono da tutti i ceppi culturali possibili e da tutti i territori immaginabili. A volte il linguaggio non coincide e va reinterpretato, pensi ad un italiano che insegna in americano a studenti che parlano un americano con influenze giapponesi e cinesi, messicane e salvadoregne, è qui che si forma la cultura dell’ibrido, che è però già vitale nelle strade di Los Angeles. Il rapporto con la cultura accademica italiana è più difficile, si procede per punteggi e per scatti burocratici, i tempi sono dilatati e diluiti. Così per la mia presenza a Milano ho cercato di importare l'accumulazione e la concentrazione, nell’arco di pochi mesi con gli studenti abbiamo visitato i musei europei, partecipato a performance e formato un gruppo di lavoro che collabora ora con Oldenburg, Van Bruggen e Gehry alla realizzazione di una produzione spettacolare ed architettonica di carattere internazionale. Sarà il ritorno di Oldenburg al teatro-happening dopo venticinque anni, nonché il primo progetto di Gehry in Italia.
Qual è secondo lei il peggior difetto dei suoi colleghi italiani?
Mi indigna la volgarità ed il pettegolezzo, l’avidità e la presunzione. Nell’arte contemporanea questi mali fioriscono, mentre, con i tedeschi, abbiamo i migliori storici dell’arte antica e moderna. Il territorio del contemporaneo è ancora un circo, perché non è considerato degno di una attitudine scientifica. Solo quando invecchia il moderno diventa soggetto di studio, così è stato con il futurismo e tra poco avverrà con l’Informale e l’Action Painting. Inoltre mi indigna la bassa qualità delle polemiche, l’attacco alla persona: la polemica va fatta sulla produzione, non sull’individuo. Certamente le liti tra critici italiani sono un’altra caratteristica della nostra cultura artistica, non so se significano discussione o massacro.
Perché la cultura italiana del contemporaneo non riesce ad aver credito internazionale?
Prima per un problema di lingua, poi perché ha mantenuto una visione totalizzante, in senso idealista. Per lo storico dell’arte italiano il percorso artistico si dilata nel tempo, ma si restringe nella fascia territoriale, per cui lo specialista copre l’arte dal Medioevo ai giorni nostri, ma solo in Italia, o massimo nella bassa Europa. È quindi di formazione nazionalistica, comparato alla cultura mondiale non ha respiro, questa si è dilatata territorialmente e ristretta temporalmente. Pertanto lo storico che operava su una territorialità ridotta ma su una temporalità dilatata si è trovato incapace di diventare internazionale. Avrebbe dovuto restringere la sua prospettiva storica all’arco di uno o due secoli, al massimo. È diventato invece un generico, che ha cercato di soffocare la dilatazione territoriale. Le vittime illustri di questo cambio di scala sono dinnanzi a tutti con il loro protagonismo nevrotico, che vorrebbe essere internazionale per dominare il nazionale. Per sopravvivere alla loro pressione, sono diventato nomade mio malgrado, fortunatamente il nomadismo mi ha fatto muovere nel territorio internazionale.
Lei ha sottolineato quanto siano stati importanti i rapporti personali con chi ha incontrato. Che cosa ha apprezzato di più in queste persone?
Il rischio di vivere la propria intensità fino in fondo. Un personaggio che ammiro molto è Pontus Hulten, mi ha raccontato che nel 1943-44 vendeva oro a Genova, comprava moneta palestinese rivendendola il giorno dopo, girava in bicicletta l’Italia da Genova a Brindisi, poi si è improvvisamente appassionato al mondo dell’arte, ha fatto la raccolta «d’oro artistico» per il Moderna Museet di Stoccolma, poi è passato al Beaubourg, poi a Los Angeles, ha inventato un metodo storico sul modo di fare mostre che sta cambiando la cultura espositiva, ma è rimasto sempre un personaggio molto sensibile ed aperto, niente dei burocrati italiani, interessati alla forma e alla posizione. Harald Szeemann è un altro ossessionato, felice e leggero, pronto a muoversi in tutte le direzioni, con idee sorprendenti come il Monte Verità e il Gesammtkunstwerk, oppure ci sono i grandi manager come Richard Oldenburg e Dominique Bozo, anche questa è una categoria sconosciuta in Italia. A parte Carlo Bertelli, siamo proprio a zero.
Lei ha espresso la sua ammirazione per Hulten perché ha cambiato il modo di fare mostre. Ma lei stesso è un infaticabile produttore di mostre: con quali criteri decide ed organizza le sue?
Per me non è sufficiente elencare una serie di nomi ed appendere le opere al muro o distenderle a terra, la mostra va costruita e disegnata, come un grande racconto. Non può essere fatta di materiale raccogliticcio (quasi sempre preso dal retrobottega del mercante), ma decisa con gli artisti, discussa e condivisa, esaltata e caricata con le loro idee e i loro progetti. Per questo sempre più sento la necessità di collaborare anche con un architetto, un perno importante per la riuscita visuale e tecnica dell’allestimento. Con Valle sono riuscito a raccontare il rapporto tra arte ed ambiente a Venezia, con Gregotti e Cerri abbiamo sviscerato gli intrecci dell’arte italiana al Beaubourg, sempre con Valle si è riusciti a rendere evidente la coerenza complessità di Vedova, ora l’architettura mi deve aiutare anche a Torino, dove la Mole Antonelliana può diventare una cassa di risonanza visuale fantastica per gli artisti torinesi e italiani. Lo stesso problema si porrà con «l’arte in teatro», dove mi occorrerà quasi un «urbanista», ma il mio rapporto con l’architettura è stato sempre positivo e stimolante per cui non vedo problemi. Trovo inutile occuparmi di un artista, se non è totalmente sconosciuto, per stendere una introduzione di poche cartelle al suo lavoro, questo è un gesto d’affetto più che uno studio. Ritengo invece necessario produrre un’operazione complessa e storica, possibilmente mai attuata sul suo lavoro. Solo in questo senso mi sento soddisfatto, quando si produce una monografia scientifica oltre che una mostra monografica. Anche il metodo di stesura deve essere diverso, implicare inediti e un contesto culturale. È quanto ho tentato di fare al Centre Pompidou nel 1981, con la mostra sull’arte italiana: ho pensato di avvicinare l’arte italiana con lo stesso metodo di Paris-New York e Paris-Moscow. Volevo dimostrare che il piano alto (dove si fanno le grandi mostre storiche) è uguale al piano delle gallerie contemporanee. Pochi hanno capito, anche se tutto era testimoniato da 600 pagine di catalogo e da documenti, solo gli specialisti interni al Centre erano molto tesi, perché avevo applicato lo stesso metodo contestuale e l’operazione li metteva in difficoltà rispetto agli artisti contemporanei che avrebbero esposto in seguilo. Quell’esperienza mi ha poi portato a realizzare i cataloghi e le mostre di Kounellis, Merz, Pistoletto e Vedova. Infine si pone la terza ipotesi di mostra, quella sulla partecipazione passionale per l’emergente. Un gesto d’amore per una situazione: certo non possono essere decine, altrimenti che passione sarebbe.
Altri articoli dell'autore
La maison ha ampliato la propria visione di cosa possa essere una casa d’aste del XXI secolo: intrecciando arte, design e oggetti di lusso e intercettando una nuova generazione di collezionisti orientati al digitale
Le audizioni hanno portato alla luce una serie di audit, alcuni risalenti al 2017 e 2018, che segnalavano vulnerabilità precise nei sistemi di sicurezza del museo, mai affrontate in modo risolutivo
In programma dal 17 gennaio al 12 marzo 2026 negli spazi di Platea | Palazzo Galeano, la personale, curata da Gaspare Luigi Marcone, inaugura la stagione espositiva dell’associazione lodigiana
Lungo le Navate di Pirelli HangarBicocca, l'esposizione ripercorrerà la pratica dell’artista cilena tra memoria indigena, spiritualità ed ecologia