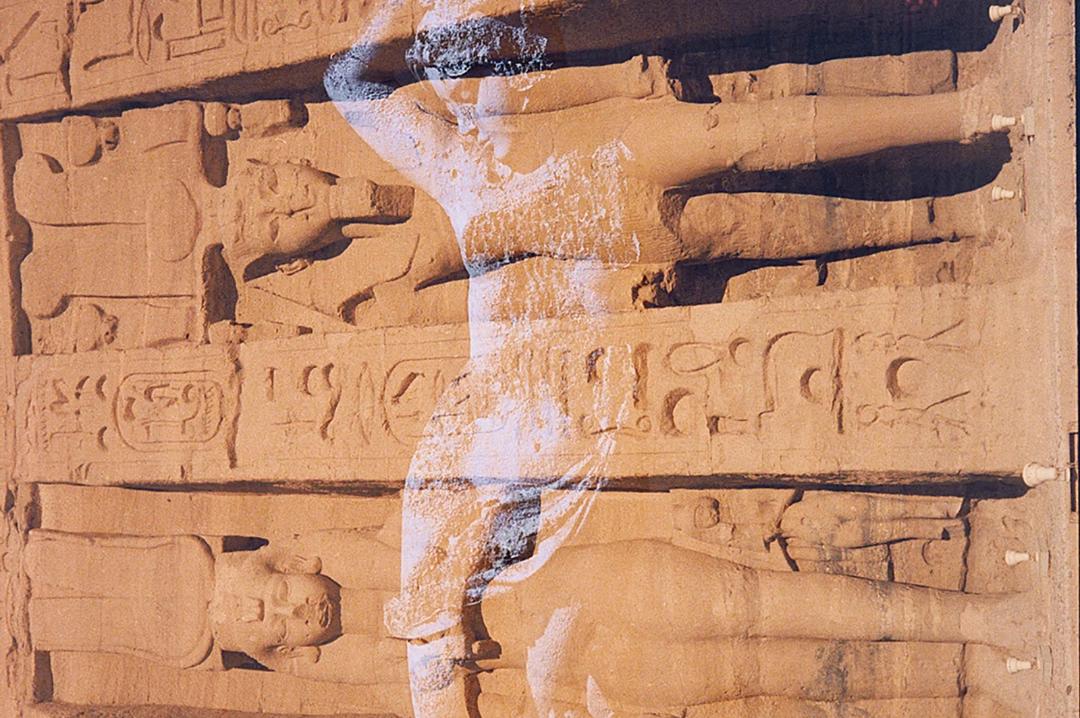Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Flaminio Gualdoni
Leggi i suoi articoliGiuro, quando ho imparato che esiste anche la «fotografia vernacolare», non ci potevo credere. Anche perché adesso hanno inventato il Festival internazionale di fotografia vernacolare, al Castello di Guiglia, piccolo centro dell’Appennino modenese: se era un’idea per destare l’attenzione, ci sono riusciti. Non avevo la minima idea che esistesse Guiglia, e questa è colpa mia, ma anche non avevo idea di cosa fosse la fotografia «vernacolare»: e non è che nel frattempo sia riuscito a farmene un’idea chiara.
Da quello che ho capito, funziona così. Le immagini meccaniche si producono ormai a miliardi, e in ogni casa c’è una scatola, normalmente di latta, che contiene quelle che costituiscono la memoria del titolare della scatola: che non è solo una parata di figure di sostituzione (le rappresentazioni funebri in luogo dei viventi di famiglia) ma anche un foutoir di immagini che ricordano qualcosa, anche se si giunge a non sapere più che cosa. Quando il titolare della scatola muore, poi, si entra nel mare magnum dell’anonimato più assoluto, con tutto quanto ciò comporta. Questo mare magnum, che esiste a prescindere da tutto il resto, è fotografia a un grado nullo di intenzione significativa, una sorta di grado zero che peraltro non ambisce a passare a un grado diverso: è quella che chiamano «vernacolare», ovvero paesana, dialettale, adespota, una cosa così. Lontana le mille miglia dalla fotografia d’autore, l’unica che sinora si era guadagnata con forza l’omologazione come forma d’arte riconosciuta, anche se a sua volta con mille distinguo.
La foto «vernacolare» incarna la stragrande quantità, quasi la totalità, di ciò che il mezzo meccanico (e ora l’elettronico) ha prodotto e produce: la foto inappellabilmente plebea, orfana alla nascita, senza riscatto possibile. Ma c’è un ma: chi decide che è «vernacolare»? Ormai in questo mondo i confini di omologazione sussistono solo come i cartelli di confine dei municipi, o degli Stati di Schengen: si passa, e nessuno ha l’autorità di metterti il timbro o di rigettarti. C’è un mondo indistinto e instabile, e tutto viene chiamato fotografia. Mi ricordo l’aneddoto di una vecchia documenta a Kassel, 1977. La critica sussiegosa dice al pittore: «Ormai la pittura è finita, la fotografia è il nuovo linguaggio. Sai quanti rollini fotografici si scattano in un giorno?». Il pittore alla critica: «E tu sai quanti rotoli di carta igienica si consumano?». In questo magma disciplinare che diciamo fotografia ora però si è insinuata la tabe senile delle ansie universitarie, quelle per cui nominare un fenomeno è più importante che capirlo: e inventarsi la «fotografia vernacolare» è perfetto alla bisogna. Qualche autore (e sottolineo autore) su questi materiali ha già cominciato a lavorare. Qualche volta gli esiti sono stucchevoli, e qualche volta arguti.
Altri articoli dell'autore
Il Criptico d’arte • Al posto della simil-giungla di palme e banani, nella piazza ora sorge un complesso di edifici temporaneo, molto simile a un suq, per vendere il merchandising del tanto atteso evento sportivo
Il Criptico d’arte • Il clamoroso furto dei gioielli della corona francese ha messo a nudo i punti deboli del museo parigino e la disarmante incuria del personale
Il Criptico d’arte • Il complesso nuovo è, vien facile e banale la battuta, faraonico: quasi 500mila metri quadrati complessivi
Il Criptico d’arte • La decisione è stata presa perché la copia bronzea «potrebbe essere percepita come sessista e che potrebbe esserci la necessità di agire in base alla legge federale sulle pari opportunità»