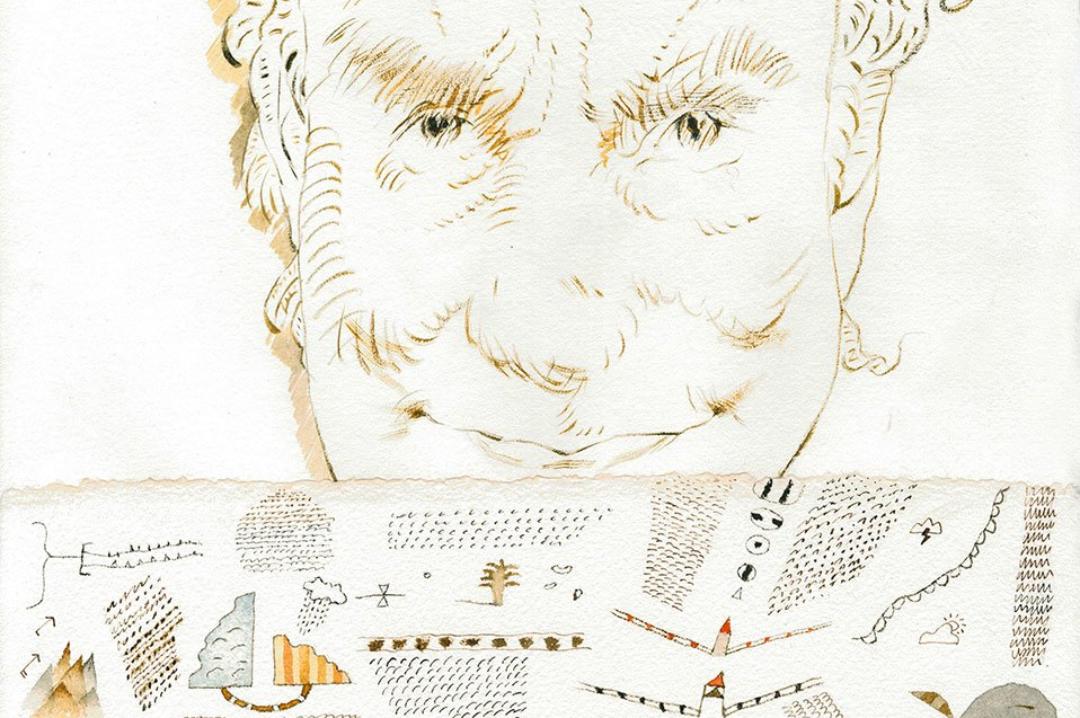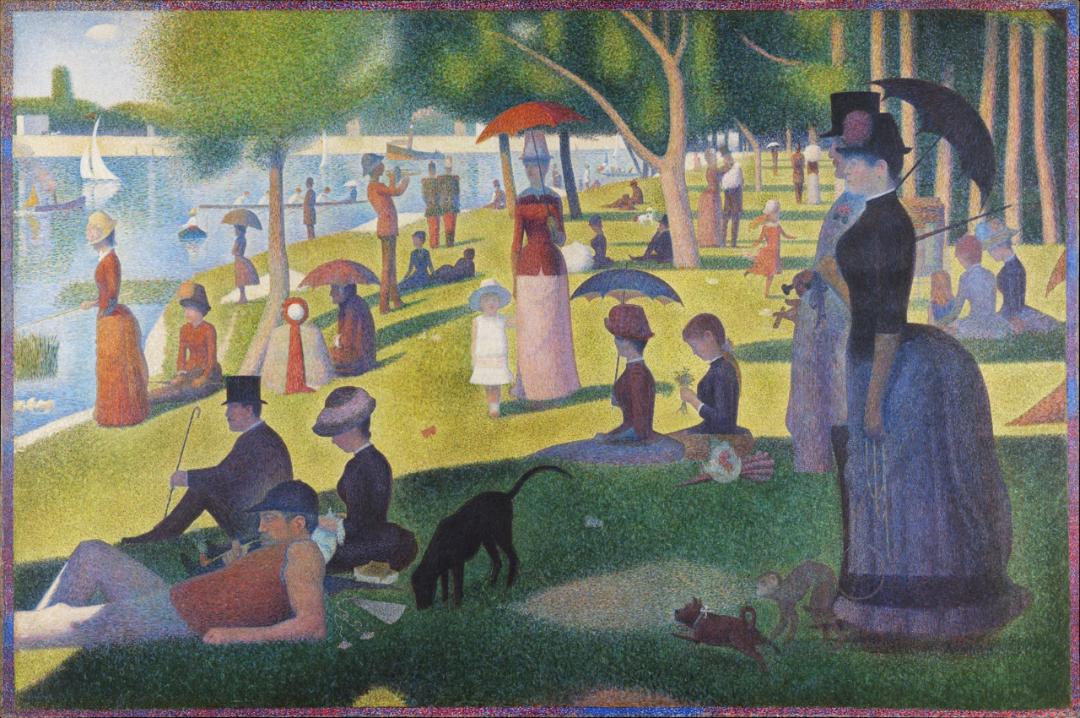Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Stefano Causa
Leggi i suoi articoliC’è sul tubo un flash del 2020 commissionato dal Museo d’Arte Moderna di Bologna dove uno straordinario trovatore di nessi come il sessantenne Marco Antonio Bazzocchi parla del lattimo. Si tratta di un vetro opaco che il piemontese Longhi inquadra per sempre in uno scorcio del Piero della Francesca, la cui ultima edizione risale al 1963; del lattimo riparla un ferrarese, storico d’arte di riflesso come Bassani quando, nel Giardino dei Finzi-Contini, descrive la camera di Micol. E di lattimi sono colmi i ripiani di un incisore e pittore bolognese, amico e coetaneo di Longhi, Morandi.
Come gli oggetti migrano da un talento all’altro, così vive di raccordi inediti questo affondo centrifugo di Bazzocchi. In un libro dal sottotitolo capiente si tengono, oltre a molto altro, Pasolini e Testori, Fellini e Hopper, Rilke e Proust, Zurlini, Anna Banti e la sua Artemisia; oltre allo stesso Balthus. Tutti variamente mossi dalla funzione Longhi che, cito dalla premessa, ha portato le immagini di Piero e del Caravaggio «non solo dentro la scrittura, ma le ha anche disseminate in mezzi diversi, dalla fotografia al cinema».
Ci muoviamo soprattutto nel dopoguerra: la stagione culturale che definiamo neorealistica (ma perché non più giustamente neocaravaggesca?) si apre al Palazzo Reale di Milano con la rassegna del Caravaggio che, come altre mostre capitali del Novecento, gli storici e i letterati contemporanei fingono di ignorare. Non Marco Antonio Bazzocchi però, felicemente privo di quelli che Biagio De Giovanni, filosofo politico e storico dell’arte non mancato, definisce «paraocchi d’acciaio».
Se non il più bel libro su Longhi, questo volume è il più intelligentemente longhiano degli ultimi anni. Dopodiché torna a martellare l’obiezione: possibile che, a oltre mezzo secolo dalla morte, la corsia bibliografica preferenziale per avvicinare Longhi (e i codici dell’officina longhiana) continui a essere quella di scrittori, filologi, comparatisti, storici della letteratura ed editori? Da Mengaldo a Cesare Garboli, da Giuseppe Bertolucci a Contini, a Roberto Calasso, a Ezio Raimondi, l’interrogazione continua di Longhi è un attivatore di accoppiamenti giudiziosi. Fatto sta che, costantemente tenuto sott’occhio dagli storici della letteratura, Longhi è stato rimosso da quelli d’arte.
Questo non dovrebbe sorprenderci stando alla piega coerentemente antilonghiana che ha preso, nel merito e nel metodo, la Storia dell’arte. Il tecnicismo, il verticalismo e la finta chiarezza nella prosa hanno disinnescato le mine idiosincratiche e fisiologicamente antiaccademiche del ragionare longhiano. A un segnale convenuto sono stati neutralizzati i satelliti autonomi e viscerali del maestro (su tutti, Testori e Arcangeli giudicati suoi patetici epigoni). D’altronde, dopo un’ubriacatura che significativamente coincide con gli apici del neorealismo, sono cominciati, Longhi vivo, correzioni e distinguo.
Andava garantita la scoperta di una geografia non più toscanocentrica. Insieme al disseppellimento di umori regionali sconosciuti, o vietati, alle mappe artistiche vasariane. Si difendeva una persistenza del realismo che impronti e dia lustro al racconto figurativo: da Cimabue a Morandi. Ma è caduta definitivamente dall’agenda degli storici d’arte, quasi che si potesse affrontare Longhi traendolo «dalla vagina delle membra sua», l’invadenza di un lessico ricco e magmatico (confrontabile solo, nello scomparto musicale, con Bruno Barilli); una scrittura intraducibile in inglese e aliena anche da un italiano ormai scortecciato.
Oggi l’autore di «Officina Ferrarese» brama lettori (preferibilmente colleghi). Alla meglio letterati e storici d’arte potrebbero dismettere le spade e incrociare le bibliografie, risarcendo le reciproche lacune e cercando ciascuno di rubarsi, sanamente, il mestiere. Longhi: non esiste mastice migliore.
Con gli occhi di Artemisia. Roberto Longhi e la cultura italiana,
di Marco Antonio Bazzocchi, 192 pp., ill., Il Mulino, Bologna 2021, € 17

Marco Antonio Bazzocchi, 60 anni, insegna Letteratura italiana moderna e contemporanea nell’Università di Bologna

Un particolare della Pala di Brera di Piero della Francesca
Altri articoli dell'autore
Il vero spirito del Natale è nella luce dorata di un capolavoro del Sassoferrato conservato nel Museo di Capodimonte
Henry Beyle pubblica in edizione limitata immagini e parole di una conversazione «fuori dai denti» del 1980 dei due grandi compagni di strada. Ogni lettura è un furto con scasso ripetono; ogni quadro pure
Atteso che, col 31 dicembre, si chiuderà il primo quarto del primo secolo del nuovo millennio, ricordiamo La Folie Baudelaire di Roberto Calasso
Nel nuovo libro di Maria Grazia Gargiulo, arte e mercato rivivono dalle pagine dimenticate de «L’Artista moderno», embrione di una rivoluzione editoriale