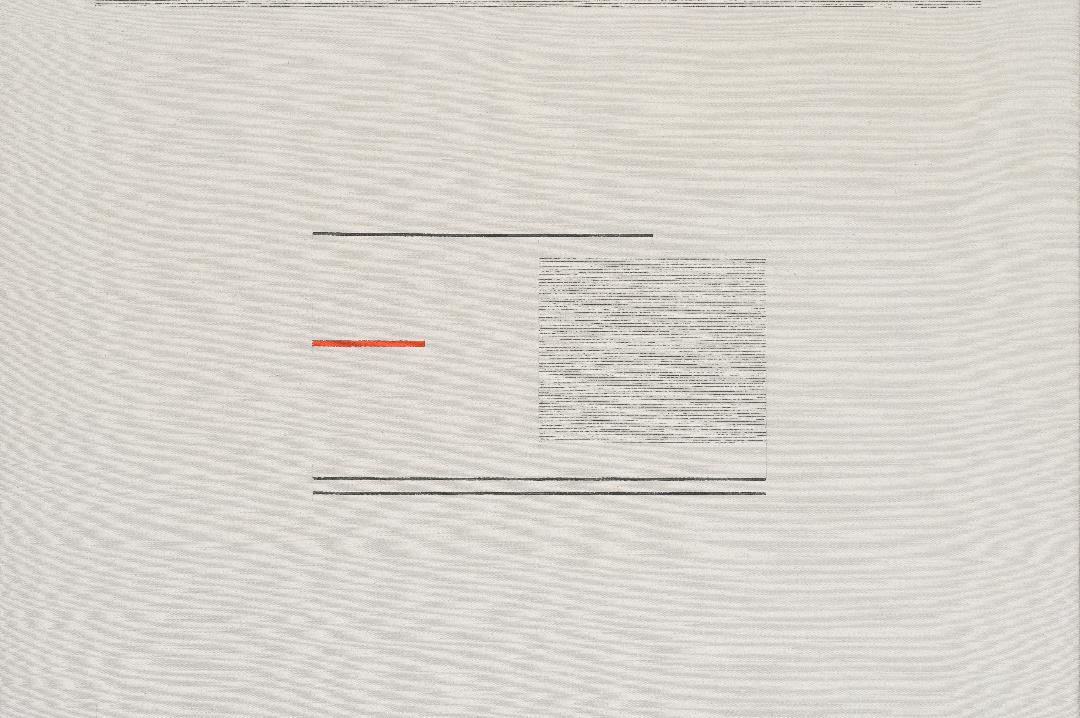Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Guglielmo Gigliotti
Leggi i suoi articoliRoma. È stato appena pubblicato da Skira Borromini. La vita e l’opera, il primo grande studio sull’architetto barocco redatto da Paolo Portoghesi per la prima volta nel 1967, e ora, come specifica l’autore, «ampliato e quasi completamente riscritto». Architetto, storico dell’architettura di grande fama e vasta influenza, docente, capofila del Postmoderno e della Geoarchitettura, Paolo Portoghesi (Roma, 1931) ha trovato nel genio del Barocco una stella polare che ne ha guidato, sin dalla gioventù, concezione architettonica, percezione della storia, ma anche esistenza segreta. Ne parliamo in questa intervista.
Che cosa l’ha indotta a riprendere in mano gli studi su Francesco Borromini?
La ragione per cui ho sentito il bisogno di riscrivere il mio libro del ’67 è stata quella di dar conto dell’enorme lavoro fatto dagli studiosi dopo il terzo centenario della morte di Borromini e, nello stesso tempo, di offrire alle nuove generazioni una immagine, la più completa possibile, dell’opera borrominiana.
Che cosa ha da dire ancora a noi oggi Borromini?
Ha da dire ancora moltissimo. Il terzo millennio vede un’architettura spettacolare, espressione di una società che non ha saputo costruire una città adatta alla complessità dei suoi bisogni e dei suoi desideri. Per lo più l’architettura oggi racconta se stessa, esibisce le sue regole o la sua insofferenza per le regole, ma non riesce a comunicare altro che la sua funzione e la sua novità. L’architettura di Borromini invece è linguaggio spirituale, trasmette pensieri, riflessioni, sentimenti, come la simpatia, la coralità, la trascendenza, l’amore.
Quale progetto o principio architettonico di Borromini ha influenzato più di altri la sua visione della forma e i processi del pensiero?
L’edificio che deve di più all’insegnamento borrominiano è la chiesa Sacra Famiglia di Salerno del 1968. Dovendo interpretare la nuova liturgia del Concilio Vaticano si trattava di iniziare una tipologia alternativa, come Borromini aveva fatto a Sant’Ivo, traducendo solo quanto c’era di geometrico in Borromini in organico.
Il primo capitolo del suo studio, quello di ricostruzione biografica, si intitola «Storia di un’anima». Il corpo perì per sua volontà (Borromini morì suicida nel 1667): l’anima è quella che il ticinese trasferì ai suoi «figli», come chiamava i suoi lavori architettonici?
«Storia di un’anima» è una espressione che Leopardi adopera nello Zibaldone per mettere in rilievo la povertà di eventi esteriori della sua vita. Il caso di Borromini è analogo: una vita trascorsa dalla adolescenza in poi sempre nella stessa città, Roma, con pochi avvenimenti che non siano legati al suo lavoro. Delle sue opere l’architetto era geloso e non voleva mandarle in giro in cerca di gloria; le considerava come dei figli che aveva educato con pazienza ed amore e voleva tutelarne l’integrità.
Nel libro è pubblicato anche gran parte del corpus dei disegni dell’architetto seicentesco: li possiamo considerare opere d’arte a se stanti?
Per Borromini il disegno era pratica quotidiana di ricerca, ma anche il piacere di raggiungere con la sola matita le vette della perfezione e un indubbio valore poetico. L’aver messo a disposizione del lettore più di 300 suoi disegni lo considero il maggior pregio del mio nuovo libro. Lo si può sfogliare per ore senza stancarsi come se si stesse accanto al maestro mentre disegna e progetta. Io che ho la fortuna di possederne due di questi disegni rimango spesso a contemplarli estasiato e ho messo lì vicino un vecchio inginocchiatoio.
Il 1656 è l’«annus horribilis» della pesta a Roma: come reagì Borromini, e come si salvo?
La peste scoppiata a Napoli era arrivata a Roma nel 1656 per colpa di un marinaio napoletano ospitato in una osteria di Trastevere. Nel mese di maggio vennero chiuse le mura della città e a giugno il quartiere di Trastevere divenne, diremmo oggi, «zona rossa» mentre nell’Isola Tiberina venne creato un lazzaretto. La peste non fu a Roma così grave come a Napoli e nel 1659 era già debellata. Con una serie di divieti e di imposizioni si evitò il peggio e vennero persino proibite le processioni. I morti furono 9.500 mentre a Napoli furono più di 100mila. Certamente Borromini di fronte al pericolo si rifugiò nella sua casa di vicolo dell’Agnello nei pressi del Tevere; ma l’anno successivo oltre che dal pericolo della peste fu colpito da una serie di disgrazie: il 1657 è infatti definito dagli studiosi “l’anno nero” della sua vita poiché venne contemporaneamente allontanato dal cantiere della chiesa di S. Agnese e da quello della Casa dei Filippini, mentre il nuovo pontefice Alessandro VII aveva scelto Bernini come suo architetto prediletto.
E lei che cosa sta facendo in questa stagione segnata da una nuova epidemia?
Mi considero fortunato perché da anni mi sono trasferito a Calcata (Vt), dove posso passeggiare in giardino e godere in questi giorni di primavera lo spettacolo della natura che risorge. Scrivo, disegno, leggo, ascolto la musica e vedo la televisione, quanto basta per sentirsi vivi nonostante l’isolamento. Con il computer e l’apparato di trasmissione predisposto dall’Università di Roma «La Sapienza», riesco far lezione ai miei studenti e, dopo la lezione, ad ascoltare le loro domande e le loro obiezioni. Bruno Zevi diceva sfottendomi che la mia specialità era quella di vedere sempre nel male qualcosa di positivo e nel bene qualcosa di negativo. Adesso mi interessa molto riflettere su quel qualcosa di positivo che si potrebbe trarre da questo virus che ci costringe a privarci del bene supremo della libertà.
Quali dovranno essere, per lei, le risposte della collettività, e quali quelle dei singoli?
Dico spesso ai miei allievi che la nostra società consumistica dominata dal mito della crescita infinita e succube del primato dell’economia, non riuscirà mai a cambiare stile di vita, come sarebbe necessario per salvare la terra e la sua abitabilità, se non verrà in nostro aiuto la natura. Ed ecco che la natura è tornata ad affacciarsi con il suo strapotere e ci fa capire che se smettessimo di correre in macchina e di far viaggiare la merce oltre ogni razionale bisogno, bruciando combustibile, se diradassimo i voli, se riscoprissimo il valore della casa come luogo di lavoro la nostra vita migliorerebbe e potremmo evitare molti dei guai che si delineano all’orizzonte. Torneremo anche nelle città a vedere il cielo stellato, l’acqua de canali di Venezia tornerebbe limpida e forse rivedremmo anche le lucciole di Pasolini. L’insegnamento maggiore del coronavirus è che la rinuncia è la madre della libertà. Vogliamo tutto, vogliamo troppo e abbiamo dimenticato la forza della rinuncia. In una società che ha perso il gusto della buona educazione, del rispetto reciproco, e che disprezza il silenzio, l’essere costretti a obbedire a delle regole può insegnarci qualcosa. Di fronte a una libertà faticosamente riconquistata dovremo riuscire ad evitare le sbornie di libertà che ne tradiscono l’essenza.
All’Università di Roma lei insegna al corso di Geoarchitettura, di sua concezione, fondato su un’idea di architettura intestata all’armonia con l’ambiente. Invita ad imparare dalla Grande Madre, dalla sua economia dell’indispensabile, dai suoi equilibri. Ora più che mai, la Georchitettura salverà il mondo?
La mia idea di Geoarchitettura si sta sviluppando con l’aiuto degli studenti che ogni anno con le loro domande e con i loro suggerimenti mi aiutano a capire cosa è giusto e possibile fare per adeguare il nostro comportamento di architetti alla responsabilità che abbiamo nei confronti del pianeta in cui viviamo, che potrebbe un giorno o l’altro sbarazzarsi di un ospite prepotente quale è diventato l’uomo negli ultimi tempi. Ci sono dei sociologi, come l’amico Domenico De Masi, che pensano che sarà la tecnologia a risolvere i nostri problemi liberando l’uomo dalla schiavitù del lavoro. Io sono convinto che a questa prospettiva ne vada contrapposta un’altra, di carattere umanistico. È giusto che la macchina sostituisca l’uomo nei lavori umilianti e “disumani”, ma l’uomo senza lavoro è come un uccello senza ali, non può costruire la propria personalità, non può conoscere il frutto del sacrificio e rischia di perdere la sua identità. La tecnologia acquista sempre più una pericolosa autonomia. Non è più l’uomo a decidere in quale direzione debba orientarsi ma solo la convenienza economica e il profitto, che riguarda un numero limitatissimo di persone che pensano solo al loro interesse. In questa situazione solo il coraggio dei governanti di orientare lo sviluppo tecnologico in funzione delle esigenze della comunità può salvarci dal disastro. La Geoarchitettura, un’architettura che consideri la terra un essere sensibile da amare e rispettare con sentimento filiale se non potrà da sola salvare il mondo, potrà contribuire a consentire all’uomo di farlo. Oggi l’architettura è il principale agente di trasformazione della crosta terrestre. In pochi decenni l’uomo ha costruito più metri cubi che nei precedenti diecimila anni e non potrà continuare a farlo con altrettanta spensieratezza. Personalmente, come «umile lavoratore nella vigna» dell’architettura, ho sentito il bisogno di indicare una strada diversa da quella dell’«architettura sostenibile». La sostenibilità dà una risposta puramente tecnica a un problema etico ed estetico. La risposta giusta è un’architettura che sappia anche esprimere nel suo linguaggio poetico, la nuova alleanza tra l’uomo e la terra che è un fatto essenzialmente spirituale.
Lei è tra quelli che invocano oggi i principi delle «decrescita felice», teorizzata, tra gli altri, dall’economista Serge Latouche?
Ho considerato sempre Latouche come un maestro di saggezza, un economista conscio dei disastri seguiti al primato della economia sugli altri aspetti della cultura, ma non ho mai creduto che la decrescita possa essere felice. La decrescita è come la vecchiaia; ha i suoi pregi ma anche tanti aspetti negativi e noie da subire. E il sentimento prevalente che si prova da vecchi - ne so qualcosa io che ho quasi novant’anni - è una tristezza illuminata dalla speranza. Ho sempre pensato che per convertire la società alla decrescita sia necessario un fenomeno esterno alla nostra volontà. Ora con il coronavirus la decrescita ci è imposta dalla natura. Quindi saremo costretti a coglierne gli aspetti positivi. A questo punto filosofi, antropologi, sociologi hanno la grande responsabilità di spiegarci come sfruttarla per migliorare la vita dell’uomo.
Recentemente ha detto: «L’obiettivo che si possono dare gli architetti è consentire all’uomo moderno ad abitare poeticamente». Mi spiega meglio le qualità di questo abitare?
«Abitare poeticamente» è una espressione usata da Hölderlin in un frammento giunto fino a noi attraverso il Fetonte di Waiblinger, e Heidegger ne ha fatto il cardine delle sue riflessioni sull’abitare. Per me è un invito a riflettere su ciò che un architetto può fare per tradurre questa aspirazione in una esperienza progettuale e, in proprio, nella sua vita.
Lei è un sottile indagatore di strutture minerali, vegetali e animali. Una volta ha detto di aver imparato a fare l’architetto anche dalle conchiglie: cosa le hanno insegnato?
Le conchiglie frutto della vita animale sopravvivono alla morte di chi le ha abitate, in questo senso sono progenitrici dell’architettura e del suo rapporto con la storia. Più insegnamento di questo!
Altri articoli dell'autore
La splendida dimora gentilizia del Cinque Seicento romano, che ospitò opere di Mantegna, Tiziano, Correggio e Giorgione, è oggetto di un piano di restauro e valorizzazione da 1,6 milioni di euro
La tappa romana, che riunisce oltre 150 opere, approfondisce anche l’importante versante delle arti applicate
Nel 400mo anniversario della consacrazione della nuova Basilica di San Pietro, Palazzo Barberini a Roma riunisce oltre 60 opere per illustrare come il sodalizio umano e culturale tra lo scultore e il papa fu all’origine del Barocco
A promuoverlo il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni: «Cominceremo dal coinvolgimento di persone affette da patologie neurodegenerative o che soffrono di stati depressivi»