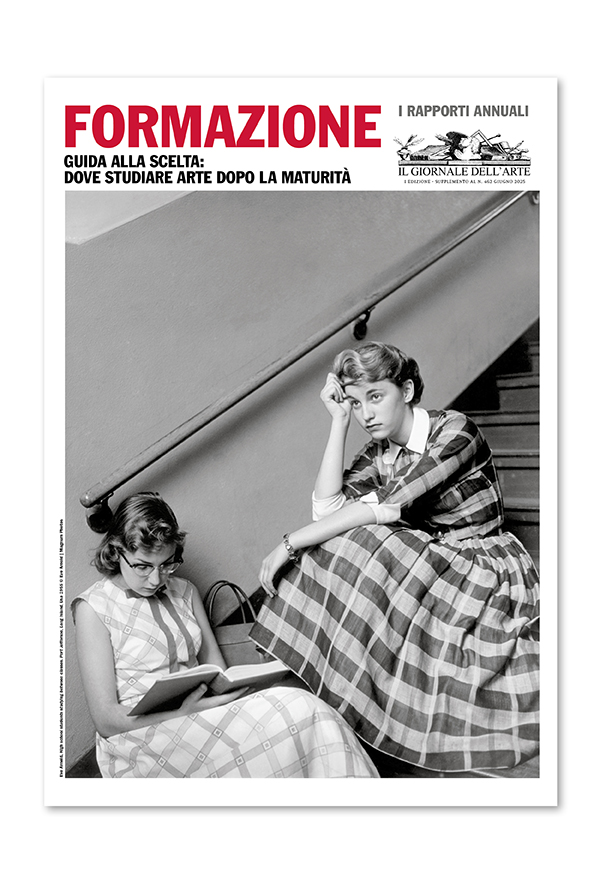Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Francesco Tiradritti
Leggi i suoi articoliQuasi al centro del dipinto «La peste a Roma» (1869) di Jules Elie Delaunay l’angelo buono si libra dietro a quello cattivo che è in procinto di battere con un punteruolo alla porta di una casa. Il numero dei colpi determinerà quello dei morti tra quanti vi abitano. La strada è ingombra dei cadaveri delle vittime dell’epidemia. In basso a destra una donna innalza disperata le mani verso un’edicola con l’effigie di una divinità pagana. All’altra estremità una processione con alla testa un crocifisso scende dall’alto di una scalinata. Sullo sfondo il cielo cupo comincia ad aprirsi.
Gli angeli di Delaunay sono tratti dalla fantasiosa descrizione di un’epidemia che avrebbe colpito Roma e Pavia nella seconda metà del VII secolo fatta da Jacopo da Varazze (o da Varagine) nella Legenda aurea (De Sancto Sebastiano). La contemporaneità tra la croce e la divinità pagana sanciscono senza ombra di dubbio che Delaunay intendeva riferirsi alla cosiddetta peste di Cipriano.
Esplosa nel 250 d.C., un’epidemia sconvolse l’Impero romano protraendosi per circa vent'anni e mietendo 5mila vittime al giorno nel momento della sua maggiore virulenza. Il nome le deriva dal vescovo di Cartagine Tascio Cecilio Cipriano (210-258) che ne diede una dettagliata descrizione nel suo trattato De mortalitate. Secondo alcuni storici, il drastico spopolamento che la Peste di Cipriano provocò è da annoverare tra le cause che condussero alla caduta dell’Impero romano.
Le recenti ricerche della Missione Archeologica Italiana a Luxor (Mail) presso il Cenotafio di Harwa (TT 37), situato sulla Riva ovest di Luxor hanno condotto alla scoperta di un contesto archeologico riconducibile proprio all’epidemia di Cipriano. Questo risultato è stato ottenuto grazie a un paziente lavoro di ricerca protrattosi nel corso di quasi vent’anni e grazie ai dati raccolti è stato possibile ricostruire con precisione le operazioni di smaltimento dei cadaveri degli appestati che ebbero luogo nel monumento.
Il Cenotafio di Harwa era stato realizzato alla fine dell’VIII secolo a.C. ed è oggi considerato uno dei capolavori architettonici e artistici dell’epoca. Nei secoli successivi era stato utilizzato come luogo di culto e come necropoli. Alla metà del III secolo, come gli altri monumenti funerari delle necropoli tebane, giaceva in stato di totale abbandono. È forse per questo motivo che fu scelto per smaltire i corpi infetti delle vittime dell’epidemia di Cipriano.
Nel cortile del monumento, furono costruite alcune calchere (forni per la produzione della calce) nelle quali furono bruciati per circa una settimana blocchi di pietra calcarea provenienti dalla decorazione del cenotafio. Frammenti di mummie e di sarcofagi recuperati nelle sepolture circostanti vennero utilizzati come combustibile. Le pietre furono poi polverizzate e trasformate in calcina con la quale furono coperti i cadaveri degli appestati che venivano deposti uno accanto all’altro nella prima sala ipostila del monumento. Quando probabilmente il numero delle vittime risultò essere più elevato dello spazio a disposizione i corpi furono accatastati nel cortile sopra una pira di mummie e sarcofagi alla quale fu infine dato fuoco.
La scoperta della Missione Archeologica Italiana rappresenta la prima traccia concreta della peste di Cipriano, la cui attestazione era sino a quel momento nota soltanto attraverso fonti scritte. Durante le ricerche sono state recuperate numerose lucerne (dalle quali si è ottenuta la datazione degli strati) e il vasellame utilizzato per mangiare e bere dagli addetti allo smaltimento dei cadaveri. La maggior parte di questo materiale era pressoché intatto. Ritenuto con tutta probabilità infetto fu prudentemente abbandonarlo. Il Cenotafio di Harwa subì una medesima sorte. Le tracce di una sua successiva frequentazione risalgono infatti agli inizi del XIX secolo quando i primi tombaroli cominciarono ad aggirarvisi alla ricerca di antichità.
Dei cadaveri che erano stati sepolti sotto lo strato di calcina sono stati recuperati soltanto pochi resti. Alcuni teschi, bruciati ma intatti, sono invece stati rinvenuti tra quanto rimaneva del falò nel cortile. L’analisi della dentatura è oggi al centro di un progetto interdisciplinare e internazionale che ha lo scopo di isolare il genoma del fattore patogeno che provocò l’epidemia.
Se i risultati si dimostrassero positivi, i dati raccolti potrebbero rivelarsi utili nella lotta di malattie virali o batteriche. Il passato viene in soccorso al futuro. Sembra fantascienza, è invece una delle nuove frontiere della ricerca archeologica.
Altri articoli dell'autore
In un articolo scientifico di prossima pubblicazione, il dottore in Egittologia Jean-Guillame Olette-Pelletier espone le sue ultime riflessioni sulle iscrizioni dell’obelisco oggi in place de la Concorde a Parigi, tra cui la «scoperta» di sette messaggi segreti
Un graffito sulle rocce nello Wadi Rum conferma le spedizioni degli Egizi al di fuori del loro Paese alla ricerca di materiali preziosi
La missione archeologica del Consiglio Superiore delle Antichità egiziano ha rinvenuto la tomba in grado di aggiungere tasselli importanti all’inizio e alla fine dell’Antico Regno, il periodo in cui furono costruite le piramidi di Giza
La struttura in mattoni crudi è stata rinvenuta a Ismailiya, località del Delta orientale oggetto di scavo solo da alcuni decenni