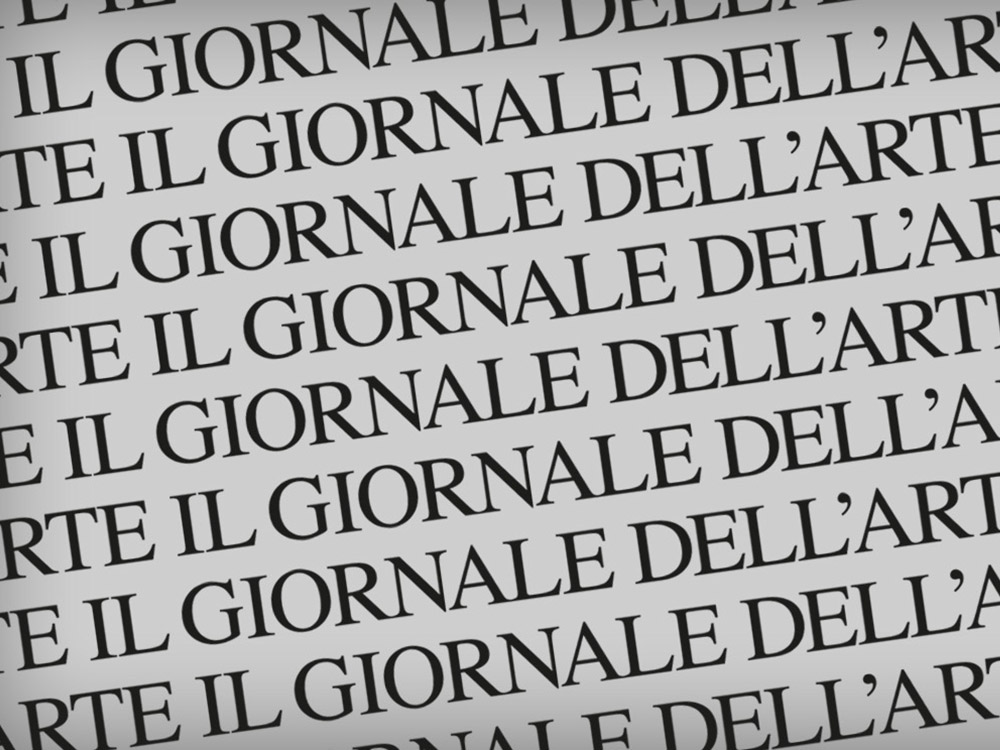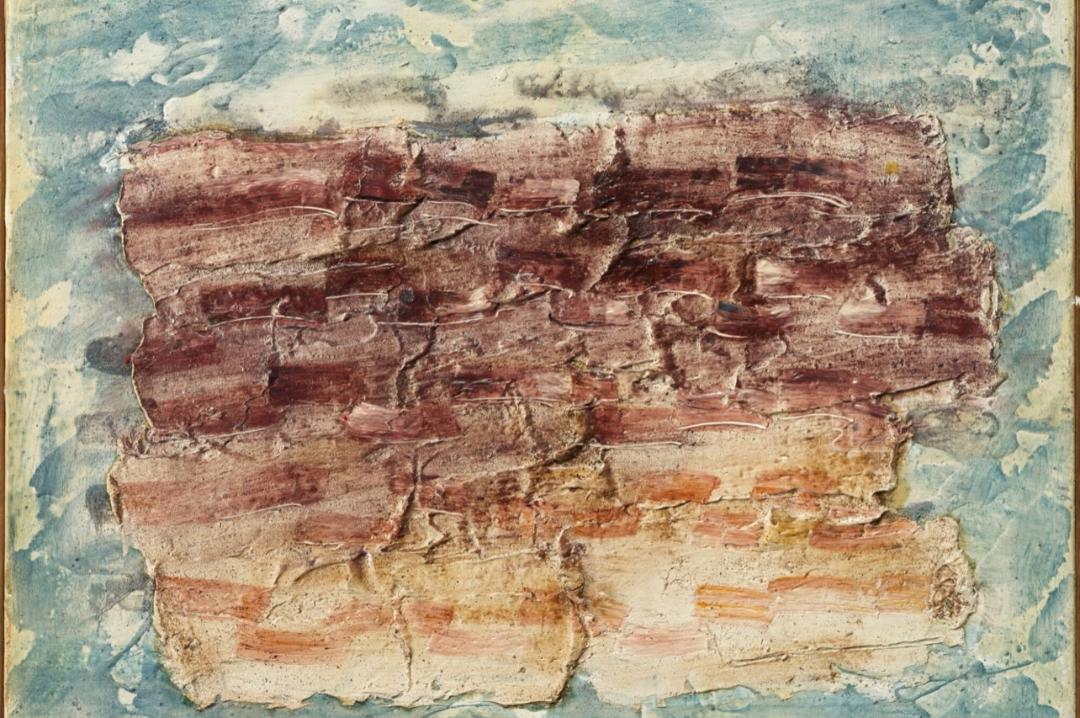Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Michela Moro
Leggi i suoi articoliGrazie al lungo lavoro sulle molte proprietà che il Fai-Fondo per l’Ambiente Italiano protegge (la Lombardia è al primo posto con nove luoghi di «straordinario» valore), Marco Magnifico, al Fai dal 1985, vicepresidente esecutivo, membro del Comitato Esecutivo dal 2010, ripercorre e analizza per i lettori del «Vedere a Milano e in Lombardia» i cambiamenti più significativi che prima e dopo Expo hanno interessato la regione.
Che cos’è cambiato dopo Expo?
Devo riconoscere che mi ero sbagliato: inizialmente ero contrario a Expo, invece ha fatto bene allo spirito, ha riportato nella gente l’orgoglio e l’identità che si erano persi. Non solo il Comune di Milano ma anche la Regione, malgrado tutto, ha riportato un fare più moderato e consapevole della gestione precedente. Si è riguadagnato il lombardo senso protestante di persone che lavorano e non mostrano troppo. Perfino i grattacieli di Milano, che una volta non apprezzavo, mi sembrano molto belli, sono un segno di novità, dell’andare avanti.
Quindi il territorio viene guardato in modo diverso?
C’è più consapevolezza. Penso con soddisfazione alla reazione dei piccoli amministratori del Parco Agricolo Sud, che si sono fermamente opposti al consumo di suolo. C’è un recupero in tema di cultura paesaggistica, forse succede in buona parte d’Italia ma sento una regione che sta capendo la necessità di tornare a guardare ai propri valori, alla propria storia, al proprio modo di fare e a capire che ciò che si ha è un tesoro da salvaguardare.
Qualche esempio?
Il lago di Como è una méta ambita, qualche anno fa c’erano stati goffi tentativi di ammodernare l’immagine del lago, scelto dai turisti proprio per la sua atmosfera ottocentesca. C’eravamo battuti contro un gigantesco porto turistico a Lecco, che avrebbe snaturato alcune parti del lago e che non è stato riproposto dalla nuova giunta. Oggi non ho più questa sensazione. Il sentimento diffuso è la consapevolezza che quello che si perde è perso per sempre. Parlando ancora del lago di Como c’è stata una bellissima opera comune delle amministrazioni sulla variante della Tremezzina, la statale che costeggia il lago dalla parte di Como e Menaggio, molto difficile da praticare. Il lavoro per trovare la chiave giusta è stato straordinario, cercando di limitare al massimo l’impatto che ha sul paesaggio questa nuova strada molto importante e che va fatta. Anche nei piccoli comuni del Varesotto che frequento spesso è risbocciato l’amore per la propria identità.
In quale situazione si trova la cultura?
Le amministrazioni si stanno rendendo conto di quello che devono fare e il pubblico capisce che cosa deve chiedere. Ciò che cinque, dieci anni fa sembrava noioso, musei, mostre, destinazioni tradizionali, è tornato al centro dell’attenzione. C’è un movimento importante intorno alla Certosa di Pavia: nessuno se ne ricordava più ed è una delle glorie non solo nostre ma dell’Italia. Nei paesi circostanti delle amministrazioni virtuose stanno facendo in modo che la Certosa torni a essere il fulcro storico e turistico della zona, ora in mano a frati bisbetici che aprono quando vogliono perché devono pregare, com’è logico che sia, ma è una gestione sbagliata: chi gestisce un monumento di quella portata deve fare il gestore del patrimonio a beneficio di tutti.
Ci sono altre mete che il pubblico sta riscoprendo?
Non ho nulla contro le grandi mostre, ben vengano, ma preferisco guardare al patrimonio fisso. Penso al Sacro Monte di Varese, fino a pochi anni fa considerato patrimonio unicamente dei varesini, oggi, forse perché sito Unesco, la gente inizia a domandarsi che cosa sia e a visitarlo. Qualcuno l’ha definito un’opera di Land Art ante litteram del cardinale Borromeo! C’è una gran voglia di tornare a guardare che cosa c’è attorno e non solo perché si è costretti dalla crisi a viaggiare meno.
Come va il Fai in Lombardia?
Il Fai va come un treno, le nostre proprietà alla grande: i visitatori aumentano, alla Villa del Balbianello sul lago di Como siamo arrivati a 90mila visitatori l’anno, di cui molti stranieri e malgrado il prezzo del biglietto sia aumentato; stiamo pensando di chiuderla un giorno a settimana perché i luoghi vanno tutelati. Villa Panza si sta avvicinando a 60mila visitatori l’anno, con una visibilità internazionale che stupisce sempre. Wim Wenders, dopo la mostra delle sue fotografie lo scorso anno dal titolo «America», ci ha regalato cinque foto dicendo che Villa Panza è stata per lui un’esperienza unica e speciale; sono gesti che colpiscono, specialmente se arrivano da uno come Wenders che di posti ne ha certamente visti molti.
Qual è il sentimento del pubblico che la colpisce di più?
Un’altra nostra iniziativa, La Via Lattea, cercava nei cinque anni precedenti Expo di rimettere in connessione i milanesi con il Parco Sud, il più vasto parco agricolo europeo. Ci abbiamo portato decine di migliaia di persone e questo ha scatenato la voglia di parlarsi e di ricollegare i fili: i milanesi hanno voglia di conoscere il proprio territorio e gli agricoltori di mostrare ai milanesi da dove proviene il latte che bevono. Questo è un progetto finito, Expo è passata, ma continueremo a operare lì, perché si è mosso qualcosa. D’altro canto perfino la vecchia aristocrazia che una volta lasciava andare le proprietà, adesso se ne occupa e non solo per mettere a reddito, ma perché capiscono di aver un ruolo, sanno che avendo avuto tanto un po’ va restituito. È un sentimento radicato nelle nuove generazioni, ne è un esempio il progetto Cento Cascine di Alessandro Belgiojoso.
Quali sono ancora le criticità della regione?
Ci sono episodi della mala gestione del territorio e qui sono contento di non essere tenero con l’amministrazione della Regione Lombardia, che ancora pensa di riempirci di strade. La Broni-Mortara è una superstrada inutile, che taglia senza ragione il Parco del Ticino. Non capiscono, retaggio di antica ignoranza, che i terreni agricoli sono un tesoro inestimabile. Ci sono cose disperanti, per esempio sul lago di Garda a Sirmione c’è la villa di Catullo, che poi non è di Catullo, dove c’è un lavoro enorme da fare. Ci sono i postumi dell’ubriacatura del passato, purtroppo quello che è stato sciupato è perso per sempre.
E quali sono invece i cambiamenti positivi?
L’inversione nella consapevolezza di un numero sempre crescente di amministratori, la curiosità nella gente, che vuole partecipare donando anche solo uno, due o tre euro: quando facciamo le nostre campagne la gente partecipa, perché ha capito che tale patrimonio le appartiene.
Come reagiscono i giovani?
Rispetto a una decina d’anni fa, i giovani tra i venti e trent’anni sono molto più attenti. Abbiamo un maggior numero di volontari giovani rispetto al passato, che si danno da fare e organizzano eventi. L’Albergo Diurno Venezia è stato scoperto dai ragazzi del Fai che ci hanno chiesto di intervenire; osano, propongono idee, hanno trovate completamente diverse dalle nostre. Faimarathon, ad esempio, è un’iniziativa con cui si aprono al pubblico oltre 500 luoghi in 130 città d’Italia proprio grazie all’entusiasmo di 3.500 giovani volontari.
Ci sono delle piccole realtà degne di nota?
Borgarello in provincia di Pavia ha uno straordinario giovane sindaco, Nicola Lamberti, che è stato capace di raccogliere l’intero paese a difesa della settecentesca Villa Mezzabarba, prima che ulteriori speculazioni oltre a quelle già avvenute nel parco della villa distruggessero irrimediabilmente il patrimonio storico che essa rappresenta.
Altri articoli dell'autore
Sculture contemporanee nel giardino segreto della Villa Reale: la natura, il corpo e l'artificio nell’intervento di Sara Enrico per Furla Series alla GAM
Con Lamonea alla guida, la fiera, a cui partecipano 143 gallerie di contemporaneo e moderno, e punta su innovazione e mercato
Bonhams festeggia un importante anniversario e rafforza la sua presenza da Milano a Roma, fino a Firenze, con un team di esperti al servizio del collezionismo di lusso
Vendite per 11,4 milioni e ottimi risultati per Donghi, Fontana e artisti internazionali