
Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Redazione GdA
Leggi i suoi articoliNel 1968 Paolo Icaro tiene una mostra personale alla «Galleria Bertesca» il cui titolo, «Faredisfarerifarevedere», può essere considerato il paradigma della sua poetica. Il suo è un originalissimo percorso alla ricerca di una nuova grammatica del fare scultura. «Decostruire per ricostruire: ovvero Faredisfarerifarevedere». Icaro è anche un artista con una dimensione internazionale e nomade: nei due decenni cruciali per la sua ricerca (gli anni ’60 e ’70), Icaro oltrepassa l’Oceano in transito da Torino a Roma, da New York a Genova, e, negli anni Settanta, si stabilisce a Woodbridge nel Connecticut.
Gli Stati Uniti vogliono dire spazio, e anche minimalismo: nascono così opere fondamentali come le «Forme di spazio» (intorno al 1967), ribattezzate subito dopo «Gabbie», tentativi di raggiungere il grado zero della scultura e del suo linguaggio. Dello stesso anno è anche la nascita del rapporto con Germano Celant e la partecipazione ad alcune delle istanze dell’Arte Povera («Arte povera più Azioni Povere», Amalfi, 1968).
Negli anni ‘70 realizza cicli come «I luoghi del punto» e le «Misure intime»: misurazioni del proprio corpo attraverso l’utilizzo di diversi materiali della scultura in un esercizio al limite tra lo spazio finito della scultura e del proprio corpo e quello infinito dell’io e della ricerca visuale. Icaro si avvicina quindi al gesso, materiale che non abbandonerà più e che conserva l’impronta del gesto che lo ha plasmato. Da qui l’idea di impronta resterà nel suo concetto di scultura: impronta intesa come misurazione di sé stessi al di fuori di sé.
Nel corso degli anni Settanta e Ottanta tiene mostre personali in importanti gallerie europee e americane fra le quali si ricordano: Verna, Zurigo (1972, 1974, 1978, 1985); Françoise Lambert, Milano (1976); Marilena Bonomo, Bari (1976); Massimo Minini, Brescia (1977, 1982, 1989); Paul Maenz, Colonia (1978), Hal Bromm, New York (1978, 1979); Jack Tilton, New York (1985, 1986, 1989).
Nel corso degli anni Novanta è invitato a partecipare a numerose mostre collettive tra cui è utile ricordaere: «Arte italiana degli ultimi quarant’anni. Materiali anomali», Galleria d’Arte Moderna, Bologna (1997); «Au rendezvous des amis. Identità e opera», a cura di Bruno Corà, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato (1998). Nel 2006 è presente alla rassegna Museo Museo Museo. 1998-2006 Duecentocinquanta nuove opere per la GAM, curata da Pier Giovanni Castagnoli presso Torino Esposizioni, dove viene esposto il nucleo di opere acquisito dalla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino nel 2005.
Nell’ottobre 2007 è invitato da Luigi Ballerini a realizzare un intervento permanente per l’Italian Department della Ucla University of California a Los Angeles. Prende parte a numerose mostre collettive, fra cui «Time & Place: Milano – Torino. 1958–1968», a cura di Luca Massimo Barbero (2008) e «Italics. Arte italiana fra tradizione e rivoluzione 1968-2008», a cura di Francesco Bonami (2008–2009).
Paolo Icaro, Torino, 1936
Gallerie e prezzi:
• Galleria P420 (Bologna)
• Prezzi 20mila – 100mila euro
CONTINENTE ITALIA
Una mappa dell'arte italiana nel 2021
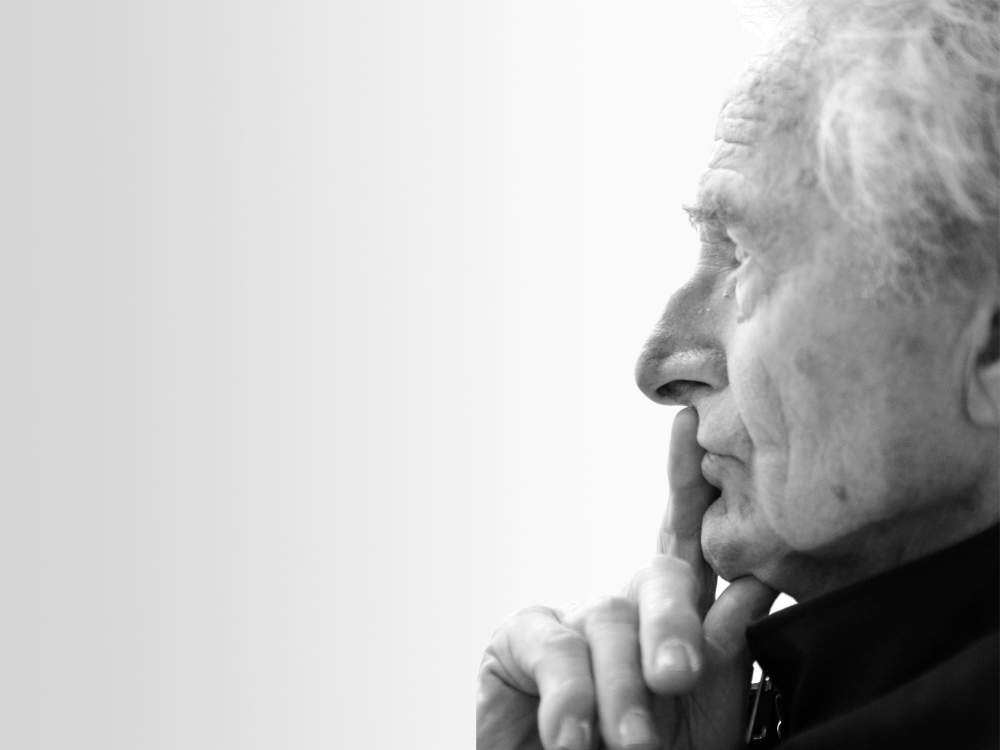
Paolo Icaro. Cortesia Galleria P420
Altri articoli dell'autore
La mostra di Rikyboy a Casa Sponge trasforma il circo in un archivio visivo tra sacro, quotidiano e immaginario popolare, raccontando il viaggio dell’artista tra pittura, calcografia e ricerca sonora nella memoria collettiva e nelle tradizioni lombarde
Arriva in libreria «A Journey into your Inner Self», la monografia che riunisce in un unico volume la ricerca di The Prism. Curato da Marco Senaldi e pubblicato da Electa, il libro documenta opere, metodo e percorso dell’artista nel contesto della scena contemporanea internazionale
La galleria Ronchini presenta nel nuovo spazio di Conduit Street, a Londra, la mostra «Flourish: Gestural Abstractions in Bloom». In esposizione i lavori di Michele Fletcher, Connie Harrison, Shuang Jiang e Shara Mays, accomunate da una ricerca sull’astrazione gestuale e sulla stratificazione pittorica
«Material for a Thousand Stories» è un progetto di arte partecipata ideato da Alice Visentin, curato da Antonio de Martino e promosso da APTITUDEforthearts in collaborazione con Comunità Nuova. L’artista utilizza la tecnica dell’episcopio per trasformare memorie, vissuti ed esperienze educative in immagini proiettate dal vivo. Il percorso coinvolge ospiti, educatori, famiglie e abitanti del territorio in un processo creativo condiviso

















