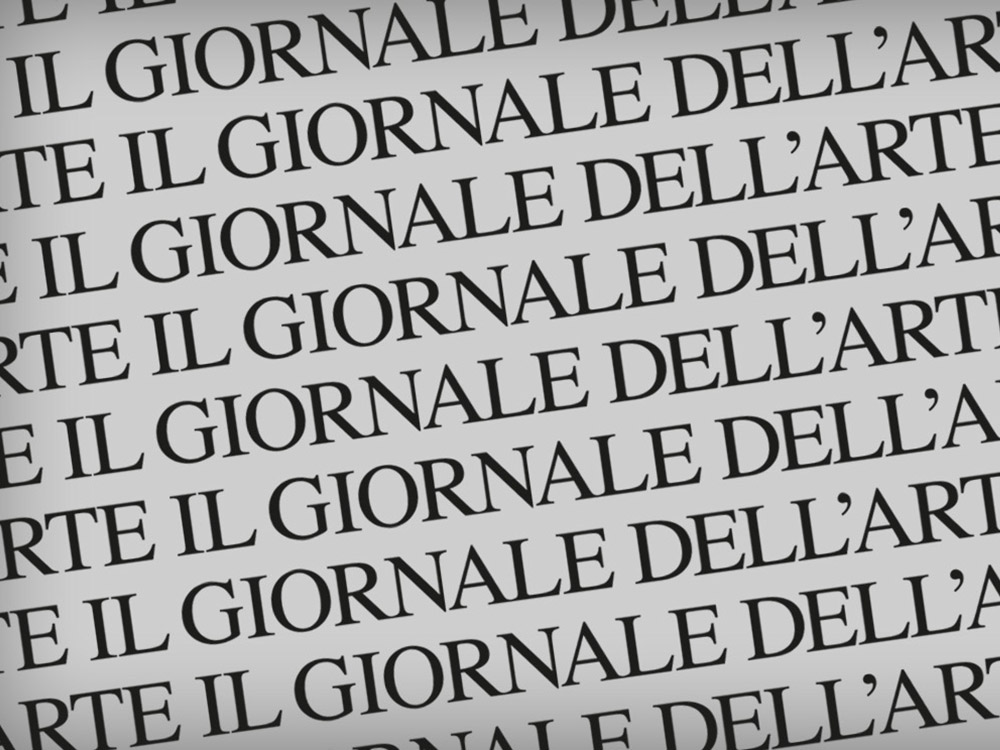Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Dawn Ades, William Jeffett
Leggi i suoi articoliSarà difficile, dopo la mostra allestita alla Royal Academy dal 7 ottobre al 3 gennaio, adottare per loro l’abusata espressione «la strana coppia». Meglio, forse, «attenti a quei due», che diversi lo erano soltanto in superficie, come Roger Moore e Tony Curtis nella storica serie televisiva. «Dalí/Duchamp», attraverso 80 opere, mette a nudo le affinità tra i due gemelli diversi dell’avanguardia. Che cosa li univa? Lo spiegano, in questo estratto dal saggio introduttivo in catalogo, Dawn Ades e William Jeffett, curatori della mostra con Sarah Lea.
Marcel Duchamp (1887-1968) e Salvador Dalí (1904-89), due degli artisti più famosi del XX secolo, sono considerati all’opposto sotto quasi tutti i punti di vista. Duchamp rinunciò alla pittura e inventò il readymade, di cui fece una produzione limitata, mentre Dalí continuò a dipingere in modo prolifico. Dalí inseguì la notorietà e diventò il primo artista-celebrità della storia, mentre Duchamp preferì rimanere in secondo piano, apparentemente distante dall’arte, per giocare a scacchi. Oggi Duchamp è considerato il padre ermetico dell’arte concettuale, mentre Dalí il difensore della pittura, una tradizione artistica alla quale Duchamp stesso sferrò il colpo di grazia. Queste posizioni diametralmente opposte hanno creato un’immagine mitica dei due artisti. Sorprende quindi scoprire che erano non solo amici stretti ma condividevano anche alcuni punti di vista sull’arte e sulla vita che infusero ogni volta nella loro opera, dando vita a paralleli e connessioni inaspettati e divertenti. (...) Dalí stimava molto Duchamp, che a sua volta lo difendeva dai detrattori. Questa amicizia stupiva e irritava molti dei loro reciproci sostenitori. Richard Hamilton e John Cage, visitatori estivi di casa Duchamp a Cadaqués, cercavano di declinare gli inviti per non incontrare Dalí. In un’intervista del 1973 Cage dichiarò: «Era amichevole con Dalí. Non è strano? Ero spiazzato a vedere Marcel adottare un atteggiamento di ascolto in presenza di Dalí. Sembrava quasi come se un giovane stesse facendo visita a un’anziana signora, anche se nel loro caso era il contrario». (...) L’amicizia tra i due iniziò a Parigi nel contesto del Surrealismo (...) e durò fino alla morte di Duchamp.
(...) Non si sa quando i due artisti si incontrarono di preciso. Entrambi esposero nell’importante mostra di collage di Aragon del 1930 «La peinture au défi», alla Galerie Goemans di Parigi, anche se non è chiaro se fossero entrambi presenti all’apertura. Duchamp era tra il pubblico alla prima del film di Luis Buñuel e Dalí «L’Âge d’or» a Parigi nel novembre 1930, seduto accanto a Dalí e Gala. Duchamp e Gala, che diventò la compagna di Dalí nel 1929, si conoscevano dai giorni del Dadaismo a Parigi, quando lei era sposata con Paul Éluard. A metà agosto del 1933, Duchamp e la compagna Mary Raynolds affittarono una piccola casa a Cadaqués vicino a quella di Dalí a Port LlÍgat. Anche se la loro scelta del luogo non fu necessariamente determinata dalla presenza di Dalí (Cadaqués era infatti una destinazione privilegiata dagli artisti prima della guerra: Picasso e Fernande ad esempio vi trascorsero l’estate del 1910), certamente vedevano lui e Gala quasi tutti i giorni. Le fotografie delle loro gite e feste sulla spiaggia confermano la convivialità e gli incontri frequenti, uno dei quali fu ispirazione del testo di Dalí Je mange Gala. Anche Barcellona era nel programma di viaggio di Duchamp, che aiutò Dalí a convincere Man Ray a occuparsi delle fotografie destinate a illustrare l’articolo di Dalí sull’architettura Art nouveau previsto per il numero successivo di «Minotaure».
Il mondo in valigia
Duchamp espresse spesso insoddisfazione per l’arte moderna, lamentando che a partire da Courbet, attraverso gli impressionisti, i fauvisti e persino i cubisti, la pittura si era rivolta solo alla retina: «In passato aveva altre funzioni: poteva essere religiosa, filosofica, morale. Se avessi avuto la possibilità di adottare un’attitudine “anti retinica”, non sarebbe cambiato molto; tutto il secolo è stato completamente rivolto all’occhio, fatta eccezione per i surrealisti che hanno tentato di discostarsene un po’». I quadri di Dalí invece cercano di contrastare questo aspetto. Negli anni ’30 elaborò un’iconografia personale ispirata da miti come quello di Guglielmo Tell, e nel 1933 scrisse un «saggio psicoanalitico», Interprétation Paranoïaque-critique de l’image obsédante, L’Angélus de Millet, che è il testo base per molti dei suoi dipinti dell’epoca, così come la mitologia classica o la Bibbia lo furono un tempo per l’arte (Dalí reintrodusse queste due fonti nelle sue ultime opere).
Un interessante parallelo con le Note che Duchamp scrisse relativamente al suo «Grande Vetro». Entrambi gli artisti combinavano questa attitudine anti retinica non solo, paradossalmente, con una passione per le illusioni e i dispositivi ottici, ma anche con un interesse per la tecnica. Come sottolineò Duchamp, «ho nuovamente introdotto alcune decisioni molto elaborate sui dettagli, persino nei readymade. Il fatto che non lo avessi realizzato con le mie mani non mi ha fermato dal trovare altri modi per applicare la mia tecnica meticolosa su questi oggetti. Suppongo di essere, nonostante me, un uomo preciso». Dal 1935 in avanti si dedicò alla realizzazione di un museo portatile in miniatura di «quasi tutte le mie opere», la «Boîte-en-valise», che prevedeva questioni tecniche complesse. In un certo modo Dalí, non meno di Duchamp, fu un «inventore cerebrale», preoccupato dai «problemi tecnici». Nel 1948 pubblicò 50 secrets magiques, per scrivere il quale saccheggiò trattati sulla tecnica, e nel 1973 «10 contenitori per l’immortalità», una scatola sontuosamente realizzata, nella forma di una valigia, in omaggio alla «Boîte» di Duchamp, contenente pop-up di carta, con disegni in prospettiva bi- e tridimensionali. Forse la prova più evidente della stima di Dalí per Duchamp è nel suo Teatro Museo a Figueres, che contiene riferimenti specifici a Duchamp. Non soltanto il soffitto fatto di sacchi per il carbone concepito da Duchamp per la Mostra internazionale surrealista di Parigi del 1938, ma anche la sua ultima opera, «Étant donnés».