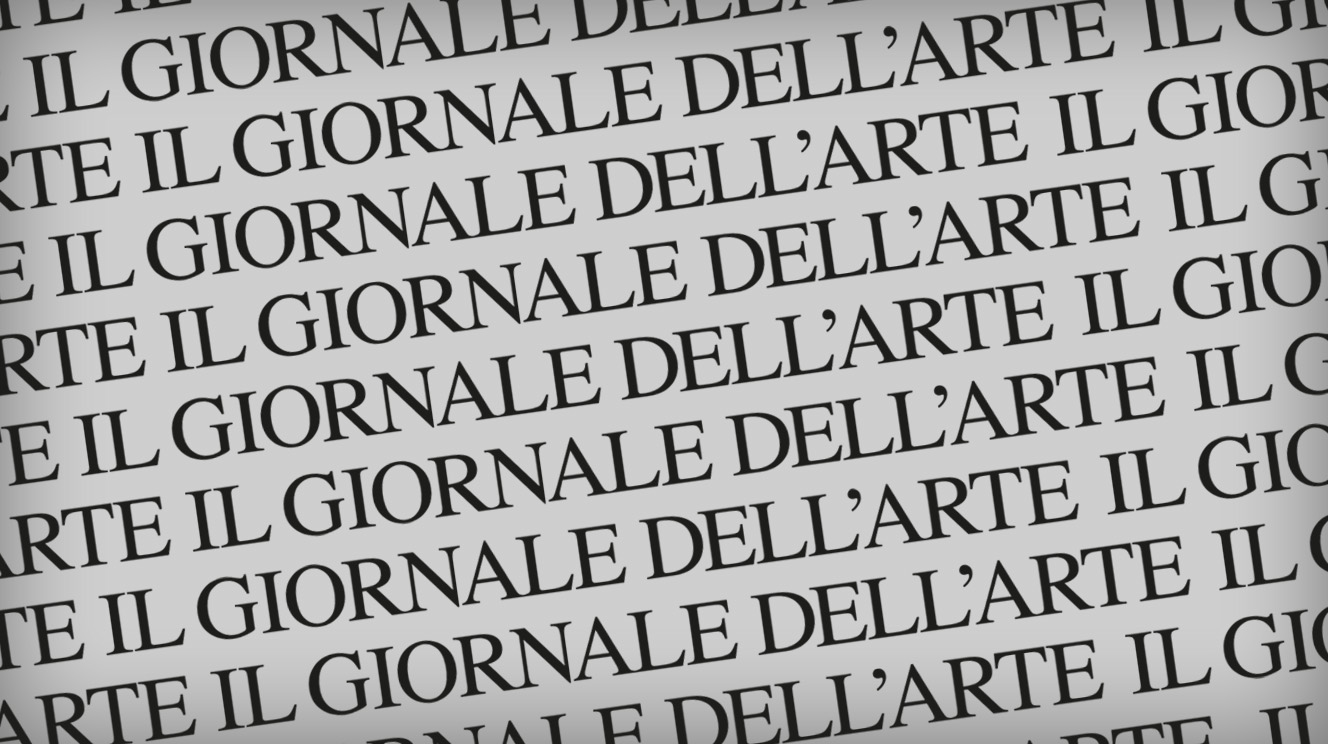Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Milano. Nel «Manifesto dei pittori futuristi» del 1910, fra le molte invettive verso l’arte passata e recente i firmatari Boccioni, Carrà, Russolo, Balla e Severini riconoscevano come maestri tre soli artisti del loro tempo: i pittori divisionisti Segantini e Previati e lo scultore Medardo Rosso, perfetto esempio ai loro occhi di profeta misconosciuto dell’arte nuova. Sull’indifferenza per l’arte di Medardo da parte delle istituzioni italiane non si sbagliavano: come scrive Paola Zatti, responsabile della Gam e curatrice della mostra «Medardo Rosso. La luce e la materia» (dal 18 febbraio al 30 maggio, prodotta da Gam Milano e 24 Ore Cultura), «fino al 1914 i musei pubblici italiani sembrano non accorgersi di Medardo Rosso. L’artista risiedeva a Parigi e fino al 1909 la sua fortuna critica fu quasi esclusivamente straniera». Proprio Milano (che in seguito si sarebbe tuttavia ampiamente rifatta, formando alla Gam una straordinaria raccolta di suoi lavori) fu l’ultima, dopo la Gnam di Roma, la Gam di Torino e Ca’ Pesaro a Venezia, ad acquisire sue opere. Eppure, lui che era nato a Torino nel 1858, dal 1875 si era formato qui, frequentando l’Accademia di Brera (ma fu presto espulso) e la Famiglia Artistica, per aprire nel 1882 il primo studio in via Solferino e dare il via a un percorso di costante sperimentazione e continua rielaborazione delle sue opere. Fu qui che, dopo i primi lavori «scapigliati», Rosso prese a riflettere sulla «materialità» della luce e sulla fugacità della percezione visiva, dando poi vita a capolavori ineguagliati di cui lo stesso Rodin, negli anni parigini di Medardo (dal 1889 al 1922, quando rientrò a Milano per morirvi nel 1928), sarebbe stato suo malgrado debitore. La mostra milanese è scandita in quattro sezioni: la prima presenta 4 opere dai modi ancora veristi, «Birichino», «Sagrestano», «Ruffiana» e «Portinaia». La seconda sezione («La materia, usi e sottrazioni») ci conduce a Parigi, con due soggetti fondamentali nel suo percorso come «Rieuse» (1890-anni Dieci) ed «Ecce Puer» (1906), declinati nel gesso, bronzo e cera. Nella terza figurano quasi tutti i soggetti da lui esplorati, dall’«Henri Rouart» (in cera, gesso, bronzo) a «Uomo che legge», al «Bookmaker»; da «Bambina che ride» a «Bambino malato», a «Madame Noblet», qui in quattro varianti (1897-anni Venti). L’ultima sezione ruota intorno a «Madame X» (1896) da Ca’ Pesaro, unica opera giunta a noi in una sola versione, in dialogo con le fotografie scattate dall’artista (che come molti altri maestri del tempo, da Degas a Brancusi, era un eccellente fotografo): vere opere d’arte anch’esse, sulle quali interveniva con viraggi, abrasioni, collage e segni pittorici, documenti della sua incessante ricerca.
http://www.mostramedardorosso.it/
Altri articoli dell'autore
Nel centenario della nascita musei e spazi pubblici da Milano a Varese, da Lugano a Gallarate, rendono omaggio allo scultore milanese
Attraverso mostre, installazioni e progetti speciali, la 24ma Esposizione Internazionale trasforma l’istituzione milanese in un laboratorio di riflessioni e proposte di 43 Paesi sulle disparità economiche, etniche, geografiche e di genere
L’artista Silvia Ciaccio esplora il confine tra sogno e veglia con opere meditate e spirituali, immerse nel blu e ispirate al pensiero filosofico e alla cultura giapponese
Frutto della collaborazione tra Antonacci Lapiccirella Fine Art e Matteo Lampertico Fine Art, nella capitale tornano le opere dei protagonisti che contribuirono a creare un ponte con New York, da Carla Accardi a Salvatore Scarpitta