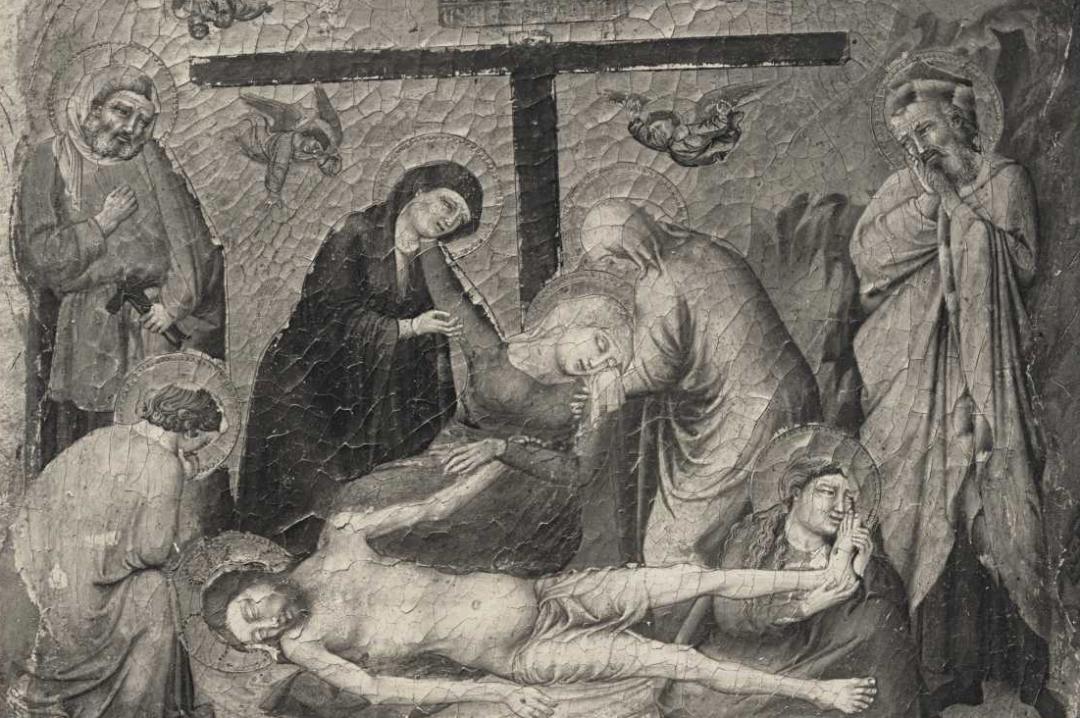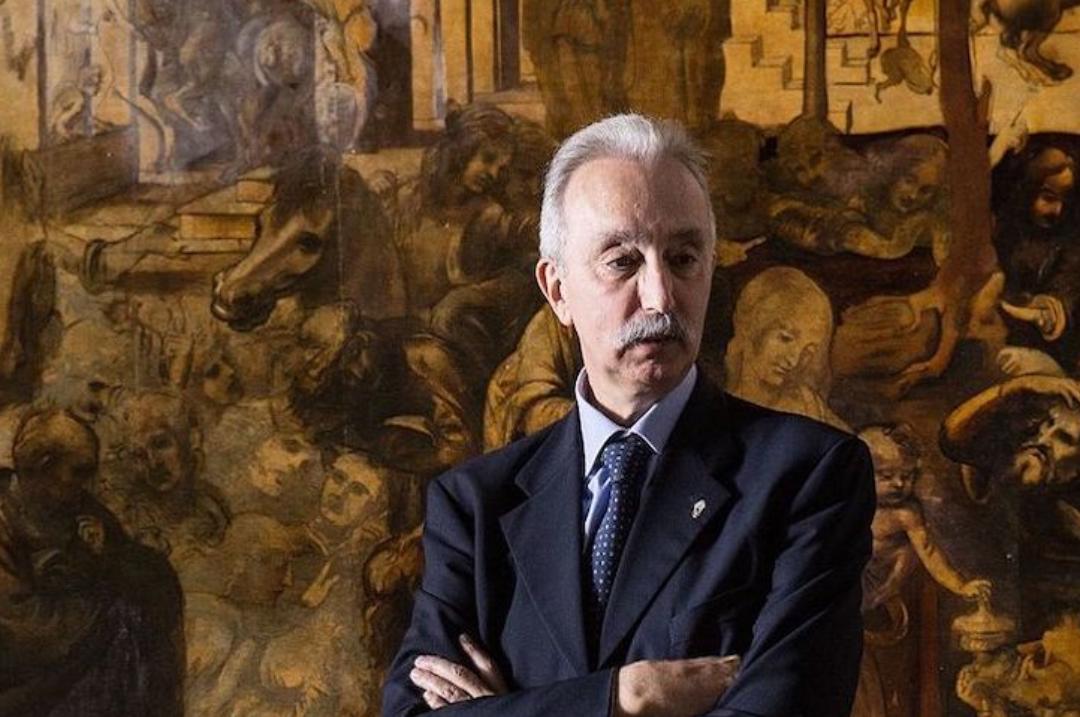Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giorgio Bonsanti
Leggi i suoi articoliSe lo è domandato, fin dal titolo del suo eccellente contributo, la restauratrice torinese Luisa Mensi: «Restaurare le installazioni: un ossimoro?». In effetti, anch’io nel mio intervento ho presentato il problema: «Il restauratore, prima ancora di domandarsi come lo faccio, dovrà chiedersi: lo faccio e, nel caso, che cos’è quel che faccio?».
Il contesto di discussione era la quinta giornata di studio sulla conservazione del contemporaneo, tenuta presso l’Accademia delle Belle Arti di Bologna, che l’organizzava con l’IgIic. Ancor più che nelle scorse edizioni si trattava di interrogarsi sull’identità stessa dell’arte contemporanea, un’identità talmente complessa e sfuggente che si rischia di perdere l’orientamento.
Personalmente ci tengo a chiarire che i problemi non riguardano tanto i materiali, come troppo spesso si sente ripetere quasi di default quando si discute di conservazione del contemporaneo. È ovvio che l’imprevedibilità dei materiali presenta criticità particolari; un quadro di Raffaello più o meno si sa come è fatto, ma con un’opera contemporanea i materiali possono essere i più casuali, e a volte nemmeno l’autore sarebbe in grado di indicare esattamente di cosa si è servito.
Però in qualche modo una soluzione accettabile si raggiunge. I problemi sono piuttosto di ordine concettuale e mettono in discussione l’idea stessa di conservazione. Le installazioni poi sono tipicamente plurisemantiche e trasversali, frequentemente prevedono performance e presenze attive di esseri viventi e inanimati che hanno senso pieno una volta sola, la prima realizzazione.
Certo che si possono ripetere, lo si fa a ogni momento; ma sono le stesse, in tal caso, oppure sono altro? Come la nave di Teseo di cui racconta Plutarco, le cui assi venivano sostituite man mano che degradavano e i filosofi si domandavano se la nave rimaneva la stessa oppure no. È il modello che seguono le tradizioni artistiche orientali, in cui manca proprio il concetto del rispetto per i materiali «originali» cui siamo a volte fin troppo affezionati.
Alcune installazioni nascono deperibili per loro natura, una deperibilità voluta oppure no; alcune irrepetibili, altre desiderano essere replicate; alcune site specific, altre possono essere ripetute enne volte in luoghi diversi. Alcune non perdono di significato, almeno non interamente, se riproposte con materiali diversi, in luoghi diversi, da parte di «attori» diversi; altre calerebbero vistosamente di tono.
La giornata di Bologna è servita allora a proporre una quantità di interrogativi piuttosto che a fornire esempi rassicuranti di soluzioni ineccepibili. Ne è emersa comunque, spererei come punto di non ritorno, la necessità di rifondare totalmente il nostro atteggiamento nei confronti della conservazione del contemporaneo, che non può più modellarsi sulle teorie novecentesche con le loro casistiche assestate, anche se ovviamente dei punti di coincidenza qua e là si presenteranno.
Quale sarà la funzione del restauratore in un contesto del genere? Per certi versi, gli si potrebbe chiedere di assumere responsabilità sempre più importanti ed estese, alcune delle quali provocherebbero lo sdegno dei teorici «tradizionali»: intervistatore, interprete, allestitore, movimentatore, trasportatore, ma anche psicologo, psicanalista, perfino un po’ indovino fino a diventare addirittura collaboratore e, eresia, artista egli stesso.
D’altronde nella musica accettiamo pure che gli artisti siano più d’uno; pensiamo all’opera lirica: ci sono l’autore, il direttore d’orchestra, il regista, lo scenografo, i cantanti, gli strumentisti, i coreografi e i tersicorei: massì, tutti artisti… Sempre più è indispensabile per il fruitore dell’arte contemporanea ricevere adeguate informazioni, e questa è una vistosa contraddizione: da un lato gli si chiede di emozionarsi (una reazione spontanea); dall’altro lato per farlo deve sapere bene di che cosa si tratta, che cosa l’autore aveva in mente, in una specie di processo iconologico assistito.
In presenza di un quadro generale così incontrollabile, il restauratore potrebbe essere tentato di sentirsi svincolato da ogni regola; ma io credo che proprio a quel punto occorra invece un tipico restauratore moderno, vale a dire esperto, colto, consapevole e con un senso dell’etica professionale particolarmente convinto.
Altri articoli dell'autore
Aperto per restauri • Diagnosi sul restauro da restaurare di Giorgio Bonsanti, già professore all’Università di Firenze
Aperto per restauri • A un anno dall’inaugurazione del museo, nella nuova sede di Palazzo Cavalli si è tenuto un convegno rivelatosi occasione interessante e piacevole per presentare un’ampia casistica di interventi conservativi infrequenti
Orietta Rossi Pinelli ripercorre le principali tappe di come sono cambiate le regole dalla Carta di Atene del 1931 ad oggi
Operatività, ricerca e didattica hanno improntato l’attività dell’insigne «ambasciatore» del restauro italiano, per quasi quarant’anni attivo all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, di cui è stato soprintendente per dieci anni