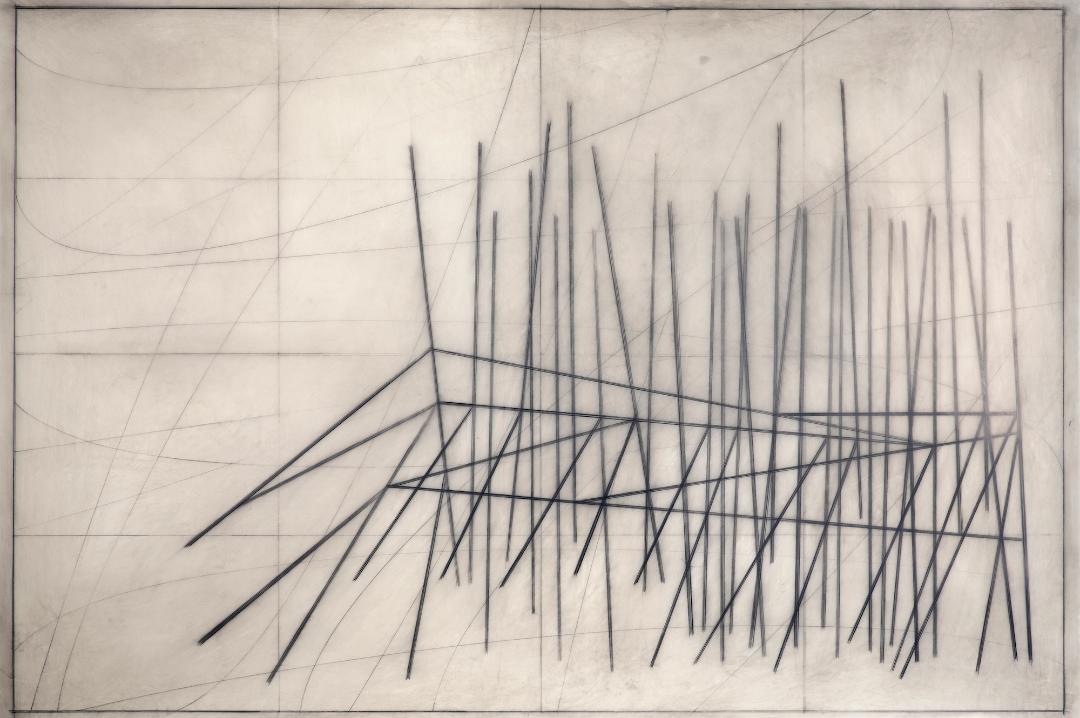Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Stefano Miliani
Leggi i suoi articoliIn ambito culturale, l’Abruzzo è una «regione in transizione con un ottimo potenziale», dà «segnali incoraggianti», ha magari bisogno di «politiche più sistemiche e mirate». La regione gode al contempo di parchi e paesaggi straordinari senza soffrire di un turismo di massa e vanta una spiccata propensione ad accogliere e misurarsi con la contemporaneità, in particolare nell’arte. Delinea un panorama vivace e ricco di spunti Pierluigi Sacco, uno degli esperti di economia della cultura più qualificati a livello internazionale, tornato da qualche anno a vivere nella sua regione dopo un lungo tempo di lavoro trascorso altrove senza aver però mai perso contatti.
Nato a Pescara nel 1964, professore di Economia biocomportamentale e delegato rettorale all’internazionalizzazione all’Università di Chieti-Pescara, tra i numerosi incarichi all’estero quello di Research Associate presso il metaLab dell’università di Harvard, è presidente di Bourges 2028 Capitale europea della Cultura, e dal 2017 al 2019 è stato consigliere speciale del commissario europeo alla Cultura. Ha insegnato Economia della cultura alla Università Iulm di Milano, dal 2023 è coordinatore scientifico de L’Aquila 2026 Capitale italiana della cultura. Ma l’elenco dei suoi impegni potrebbe essere molto più lungo.
Professor Sacco, il «Sistema produttivo culturale e creativo abruzzese» ha prodotto 1,2 miliardi di valore aggiunto, pari al 3,9% dell’intera economia regionale, in linea con la media del Mezzogiorno che è del 3,9% mentre quella italiana è del 5,6%. Sono dati divulgati nel 2023 dal rapporto della fondazione Symbola e di Unioncamere «Io sono cultura». Come valuta questi numeri?
Dal punto di vista della creazione culturale e della produzione creativa penso all’Abruzzo come a una regione in transizione: ha sicuramente un ottimo potenziale e me ne rendo conto in maniera chiara essendo tornato a viverci e a lavorarci molto più da vicino. Però bisogna mettere in atto politiche più sistemiche per favorire la produzione. Credo che nei prossimi mesi assisteremo a uno sviluppo interessante grazie alla disponibilità di varie risorse regionali e nazionali che creeranno opportunità per il potenziamento dell’industria creativa abruzzese. I segnali dunque sono incoraggianti, ma il territorio deve fare un salto di qualità importante. Non per mancanza di talenti e competenze né di cultura imprenditoriale: quello che serve ora sono politiche territoriali più mirate.
Gli stessi rilevamenti abruzzesi calcolavano anche oltre 23mila persone occupate nel settore, pari a un 4,4% dei posti di lavoro nella regione, in linea con il Mezzogiorno che viaggia sul 4,2%, mentre la media nazionale è più alta, il 5,8%. Servono investimenti, strategie apposite?
Esatto. La Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Abruzzo dà abbastanza peso alla cultura e allo sviluppo della sua industria. Secondo me bisogna individuare delle priorità strategiche più chiare ed efficaci. Non si tratta necessariamente di rivoluzionare tutto, quanto di pensare in modo più ambizioso al ruolo della cultura nello sviluppo regionale. E con i grandi mutamenti tecnologici legati all’intelligenza artificiale si aprono frontiere di innovazione estremamente interessanti: i primi dati sembrano dirci che l’IA non riduce lo spazio per il potenziale creativo umano, al contrario è possibile che favorisca un grande salto di scala nella capacità creativa umana. Regioni come l’Abruzzo, proprio perché si trovano a dover fare un salto di qualità in un contesto come questo, potrebbero posizionarsi come leader di sperimentazione se sapranno investire in modo mirato sull’innovazione culturale e sulle industrie culturali e creative.
Un capitolo decisivo è il turismo, tra rischi e benefici. La scrittrice Donatella Di Pietrantonio, in un’intervista nell’inserto sull’Abruzzo de «Il Giornale dell’Arte» del 2024, affermava che i benefici della cultura non devono calcolarsi sul profitto immediato quanto sul «benessere collettivo» e auspicava che non arrivi un turismo aggressivo e di massa bensì lento e sostenibile. Pensiamo alle difficoltà affrontate dal paese di Roccaraso a gennaio quando ha visto riversarsi più di 10mila turisti con oltre 200 pullman e ingorghi connessi: premesso che sarebbe ingiusto vietare un paese a chicchessia, come se ne esce?
Sono molto d’accordo con Donatella Di Pietrantonio. I benefici di crescita economica e sociale della cultura non si calcolano assolutamente sugli impatti economici immediati anche perché possono diventare un boomerang nella misura in cui consumano un territorio, creano congestione, aumentano eccessivamente i prezzi dei servizi locali. Ci sono tanti aspetti da tenere presenti. Secondo me l’Abruzzo ha tutto da guadagnare da un modello di crescita lenta e sostenibile. Non siamo una delle regioni più gettonate dai flussi turistici nazionali e internazionali e questo magari ci penalizza un po’ dal punto di vista economico nell’immediato, ma ci ha permesso di mantenere una certa qualità ambientale e la nostra vocazione di regione verde d’Europa. Si può crescere nella domanda turistica e nelle presenze però evitando assolutamente modelli fortemente estrattivi e favorendo molto di più le offerte turistiche con tempi di permanenza non brevissimi, che non lavorino sul turismo mordi e fuggi, ma al contrario facciano apprezzare soprattutto il fatto che l’Abruzzo ha, in uno spazio fisico molto ristretto, una grandissima varietà di paesaggi e ambienti: dal mare alla montagna, dalla collina alla campagna. Questo favorisce un turismo curioso, esplorativo, che non va nella località super-famosa per mezza giornata e poi va via. Non avere questo tipo di destinazioni paradossalmente ci aiuta invece che penalizzarci. Il caso di Roccaraso era più legato a una dinamica mediatica abbastanza patologica e dagli effetti in ultima analisi controproducenti per l’economia locale, ma fortunatamente non sembra aver avuto seguito.
Però anche nei parchi possono presentarsi problemi di affollamento. A fine maggio il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha chiuso il sentiero F10 fino a metà giugno perché troppe persone volevano fotografare gli orsi e, nella stagione degli amori, pur non volendo li disturbavano.
L’Abruzzo si è distinto finora per la grandissima capacità di far convivere i suoi animali, compresi quelli considerati pericolosi o minacciosi in altri territori, con lo sviluppo turistico. Un’eccessiva congestione turistica disturba in maniera significativa la fauna dei parchi e sono assolutamente d’accordo sul ridurre le presenze delle persone: non possiamo piegare gli animali alle nostre esigenze: sono i loro territori, il valore del parco è legato a loro. Quei provvedimenti sono necessari anche perché gli abruzzesi che vivono in quei territori sono abituati a convivere con gli animali, ma non necessariamente i turisti, e dobbiamo adottare tutte le cautele necessarie per evitare incidenti che comprometterebbero il grande lavoro fatto.
Altro tema, non solo abruzzese, è lo spopolamento dei borghi descritto con garbata ironia da un simpatico film dal discreto successo del 2024, «Un mondo a parte» di Riccardo Milani con Virginia Raffaele e Antonio Albanese. Come invertire la tendenza? Possono funzionare proposte come Aielli, il borgo nell’Aquilano che ha puntato sulla Street art?
L’Abruzzo si sta distinguendo come un vero laboratorio di innovazione sociale legata allo spopolamento. Una delle aree più critiche dal punto di vista demografico dell’intero Paese, non solo regionale, è la cosiddetta Valle Subequana, nel Parco naturale regionale Sirente-Velino, a partire dal paese di 300 abitanti di Gagliano Aterno nell’Aquilano (non uso il termine «borghi» perché non mi piace), che è diventato un laboratorio straordinario di ripopolamento con neoabitanti non necessariamente permanenti, ma per periodi lunghi. È nato così un progetto estremamente interessante di creazione e offerta di nuovi servizi e lo si è esteso agli altri paesi della Valle. È un esempio di come si possa lavorare non sui classici e un po’ stantii modelli dell’albergo diffuso e del turismo del weekend, quanto sull’attirare persone interessate alla qualità della vita, al basso costo, alle relazioni, in ambienti estremamente ricchi dal punto di vista naturale. Non è un caso isolato, in Abruzzo abbiamo tante e diverse sperimentazioni in corso. Giustamente lei citava Aielli che sta facendo molto bene partendo da un’idea molto semplice. Le giovani generazioni abruzzesi stanno mostrando una forte capacità di proposta e di sperimentazione. Solo il tempo potrà dire se dureranno o meno, ma c’è una concentrazione di intelligenze e competenze che merita assoluta attenzione, anche fuori dai confini regionali, come di fatto sta accadendo.
Lei ha usato il termine «sperimentazione» e un campo in cui si sperimenta è l’arte contemporanea. L’Abruzzo ha una storia molto ricca e, oggi, ha luoghi come il Museo MaXXI all’Aquila, ha Fondazioni molto attive e interventi in numerosi piccoli paesi. Quanto incide, a suo parere, questa dimensione?
È molto importante. L’Abruzzo è stata una presenza costante nell’arte contemporanea italiana. All’Accademia di Belle Arti dell’Aquila hanno insegnato alcuni dei più grandi artisti italiani del secondo dopoguerra, Pescara ha avuto una stagione importantissima a partire dagli anni ’70, quando gli esponenti dell’Arte Povera hanno stabilito un rapporto stretto con la città, creando opere di cui troviamo una piccola significativa antologia nel nuovo spazio della Fondazione Pescarabruzzo, grazie alla generosità di Mario Pieroni. Va poi ricordata la straordinaria esperienza di «Fuori uso» di Cesare Manzo, che ha inventato un modello che abbiamo poi ritrovato in tante manifestazioni internazionali. Le Fondazioni sono molto attive, il prossimo anno abbiamo L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 di cui sono coordinatore scientifico, e nel cui programma l’arte contemporanea avrà un ruolo importante. Soprattutto in rapporto alle sue dimensioni, l’Abruzzo è una delle regioni in cui l’arte contemporanea ha un impatto particolarmente forte. Pescara e la sua area metropolitana hanno una concentrazione di gallerie di tutto rispetto, con attività anche a livello internazionale, e il numero dei nuovi spazi è in rapida crescita. Credo che nei prossimi anni questo possa fare la differenza perché il tema non è soltanto alimentare il circuito dell’arte contemporanea, che rischia di diventare autoreferenziale se non si apre al dialogo col territorio e con la società, quanto lavorare su progetti d’arte contemporanea inclusivi, socialmente rilevanti, che rispecchino meglio lo spirito del tempo.
A proposito di contemporaneità, nel 2024 Sambuceto, frazione di San Giovanni Teatino nella provincia di Chieti, ha consacrato la nuova Chiesa di San Rocco progettata da Mario Botta; l’Università di Chieti-Pescara ha appena approvato il progetto di un campus affidato allo studio di Mario Cucinella. Ciò avviene nella piana e non nella cittadella storica sul colle. Perché puntare sull’architettura dei nostri giorni in una zona che non è turistica?
L’ateneo è sempre stato molto attento alla qualità architettonica, il campus attuale della sede di Chieti è già notevole per la qualità della progettazione e il rapporto con gli spazi verdi: i nostri visitatori internazionali restano sempre molto piacevolmente sorpresi. È la cifra del nostro territorio. Anche Pescara, distrutta dai bombardamenti dell’ultima guerra mondiale, ha la vocazione di ricostruirsi un’identità attraverso il contemporaneo. Il progetto dell’espansione del campus è un altro passo significativo. Non dimentichiamo che nel territorio sono state fatte operazioni ambiziose: ricordo ad esempio l’applicazione della legge del 2% (quella che obbliga le amministrazioni pubbliche a destinare una percentuale dell’importo dei lavori di edifici nuovi a opere d’arte, Ndr) nella costruzione del nuovo tribunale di Pescara con un progetto curato da Achille Bonito Oliva e con interventi di Ettore Spalletti, Enzo Cucchi e Michelangelo Pistoletto. L’idea di confrontarsi con le voci più interessanti della contemporaneità è un tratto identitario in particolare dell’area metropolitana di Pescara, un territorio relativamente povero dal punto di vista del grande patrimonio storico-artistico per gli standard italiani.
A metà maggio lei è stato eletto presidente della Fondazione Michetti di Francavilla al Mare, dedicata al pittore Francesco Paolo Michetti (1851-1929): perché ha accettato l’incarico?
Perché è una grande sfida e mi dà un’enorme soddisfazione contribuire alla crescita culturale e di sviluppo socio-economico della regione dove sono tornato a vivere nel 2021 dopo tantissimi anni. È un’istituzione di grande tradizione e valore, è un contesto ideale su cui lavorare. A fine luglio inaugureremo la mostra dell’edizione 2025 del Premio Michetti, che sarà curato in questa e nella prossima edizione da Massimiliano Scuderi, uno dei curatori abruzzesi più attivi e conosciuti a livello internazionale. L’idea però non è semplicemente promuovere il premio annuale ma vogliamo che la Fondazione diventi un centro di crescita culturale aperto al territorio, con attività tutto l’anno fortemente orientate all’inclusione e alla partecipazione. Andremo a toccare tematiche che credo siano molto importanti nello scenario attuale, come il rapporto tra arti e promozione della salute e del benessere, o più in generale l’impatto sociale delle pratiche artistiche e culturali. La Fondazione può diventare un laboratorio di innovazione che può dare un impulso cruciale al territorio. Questa vocazione sociale e inclusiva è molto vicina allo spirito abruzzese: la nostra regione è sempre stata accogliente, interessata a costruire relazioni, è il nostro capitale culturale.
In numerose città italiane la mancanza di alloggi a prezzi decorosi per gli studenti è deflagrante. L’Abruzzo ha tre università, a L’Aquila, a Chieti-Pescara e a Teramo. Esiste questo problema? D’altronde gli studenti portano ricchezza economica e culturale.
Il problema esiste come in tutte le realtà italiane ma se confrontiamo i costi della vita e la disponibilità di alloggi dell’area metropolitana di Chieti-Pescara con le grandi città i problemi non hanno certo la stessa entità. L’Aquila è in una fase di completamento della ricostruzione e anche lì la situazione è oggettivamente molto più favorevole che altrove, e lo stesso discorso vale per Teramo. In tutte le sedi abruzzesi c’è una forte attenzione a migliorare i servizi di accoglienza anche attraverso l’aumento dell’offerta ricettiva per gli studenti, che sono sì una ricchezza per i benefici economici che portano sul territorio, ma lo sono ancora di più dal punto di vista dei talenti e delle competenze. Trovo del tutto miope che le città universitarie italiane tendano a considerare gli studenti più come una mucca da mungere che come patrimonio di competenze da valorizzare.
Per concludere, quali sono i monumenti e le opere d’arte abruzzesi che lei sente più vicini dal punto di vista personale, affettivo?
Ho tantissime memorie affettive dei meravigliosi monumenti del nostro territorio, che ho visitato spesso già da bambino, e tra questi includo anche gli straordinari paesaggi abruzzesi, ad alcuni dei quali sono legato in modo viscerale. Se mi limitassi a citare qualche monumento o qualche luogo farei un torto a tutti gli altri. Ma rimanendo sempre alle memorie personali, non posso non citare le opere di Ettore Spalletti, che mi hanno insegnato a vedere la mia terra in modo nuovo e ancora più emozionante. Ho avuto la fortuna di passare del tempo con lui in più occasioni, ma non abbastanza. E il nostro territorio dovrebbe essere più consapevole della grande responsabilità di onorare la memoria di un artista tra i più grandi degli ultimi decenni, non solo sulla scena italiana, che ha scelto di rimanere tutta la vita qui.
Altri articoli dell'autore
Il professor Mirko Santanicchia illustra in anteprima il restauro della possente rocca del Vignola e il progetto del nuovo Museo Diocesano
Nella Chiesa della Misericordia di San Severino Marche una settantina di opere, quasi tutte su carta, di oltre 40 autori dagli anni Quaranta ad oggi
Encomiabile la ricostruzione della Basilica distrutta all’80% dal sisma del 30 ottobre 2016. Entro un anno e mezzo si prevede la conclusione dei lavori anche nella Cattedrale di Santa Maria Argentea. La sfida, anche qui, è «com’era dov’era, ma con più sicurezza»
Riapre dopo il terremoto del 2016 con un nuovo ordinamento «tipologico» e con opere provenienti dalle chiese allora danneggiate. In mostra anche Giovan Battista Tiepolo e Valentin de Boulogne