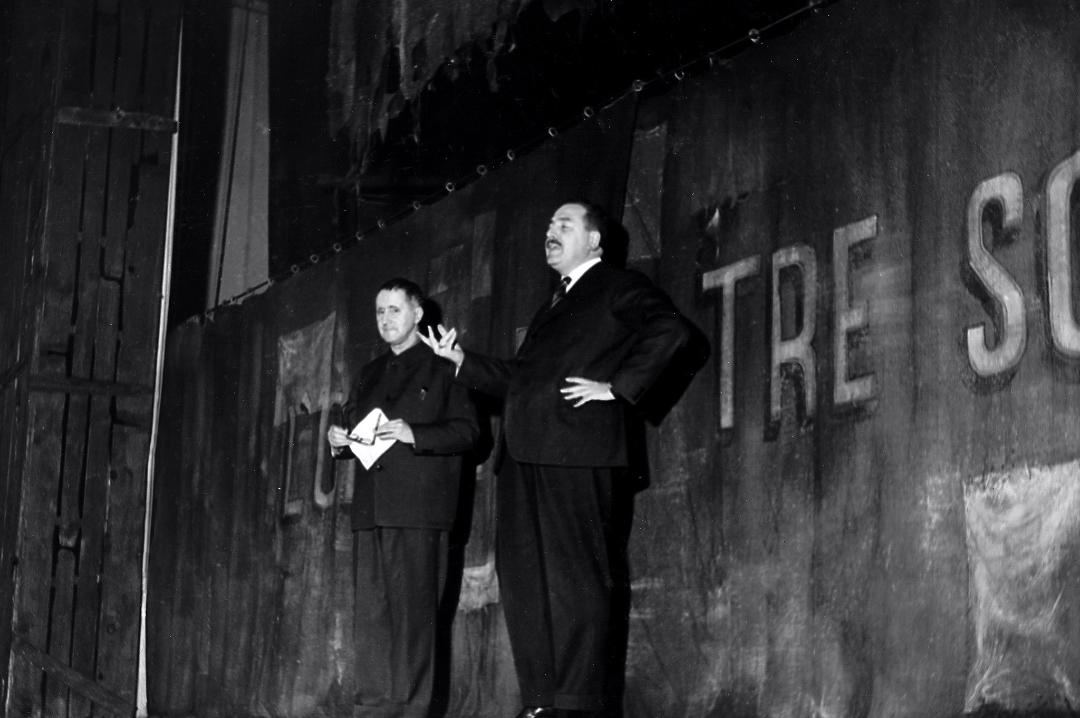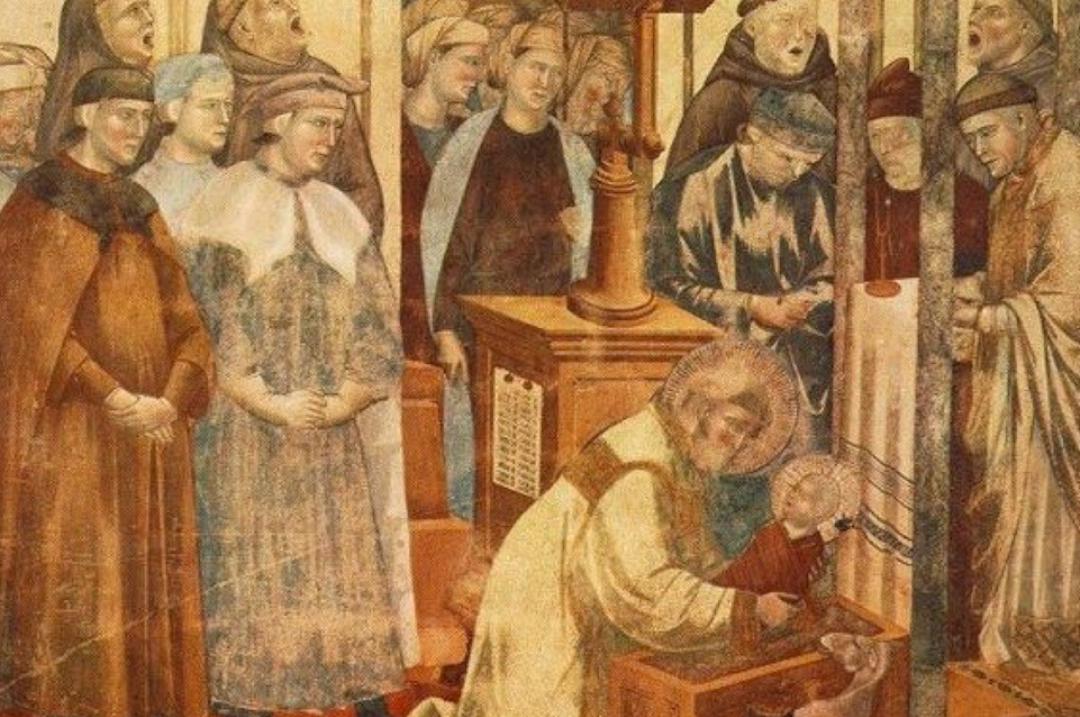Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Sergio Buttiglieri
Leggi i suoi articoli«Il melodramma italiano è un’opera d’arte tutta speciale, costruita sul ciglio d’un abisso di ridicolo, ci si sostiene a forza di genio. Da un secolo, questo equilibrio prodigioso si verifica», scriveva nel 1927 il musicologo Bruno Barilli.
E questo prodigioso equilibrio è ancora attualissimo pensando al Rigoletto che ho appena visto al Teatro alla Scala di Milano con la regia di Mario Martone, l’impeccabile direzione musicale di Marco Armiliato, sua prima riuscita esperienza scaligera, e con le magiche scene ideate dalla grande Margherite Palli che, in accordo con Martone, citano il mitico film «Parasite» di Bong Joon-ho. Pensando quindi a una struttura girevole che permetterà di passare da una dimensione piacevole di benessere borghese a una dei bassifondi distopici.
Giuseppe Verdi, che nelle sue lettere ribadiva ironicamente «i piccoli teatri di una volta eran, si può dire, delle rosticcerie del sentimento pubblico», sembra l’uomo nato apposta per spazzare via col suo pugno sterminatore ogni parassitismo intellettualistico, per mettere in fuga la musicologia ragionante, per scomporre le tele di ragno dei sistemi metafisici.
«Il suo alito ha un sano odore di cipolla e la sua voce è imperiosa, i suoi istinti pieni di veemenza primitiva. Egli ignora le parafrasi, s’intromette furiosamente, taglia i nodi colla roncola, e fa scorrere lacrime e sangue esilaranti, piomba sul pubblico, lo mette tutto in un sacco, se lo carica sulle spalle e lo porta a gran passi entro i rossi, vulcanici domini della sua arte», ci ricorda sempre Barilli. E queste specificità verdiane Mario Martone ce le ha restituite nella sua interezza nel «Rigoletto» che ha riproposto dopo la sua prima scaligera del 2022, sempre con le scene di Margherita Palli e i costumi di Ursula Patzak, sotto la direzione, quella volta, di Michele Gamba. Ma sempre come protagonista l’impeccabile baritono mongolo Amartuvshin Enkhbat, per l’ennesima volta egregiamente alle prese col ruolo di Rigoletto.
«Penso sia fondamentale restituire la violenza che Verdi aveva in mente, ci ricorda il regista, per questo vorrei che si riconoscesse subito una divisione netta tra il mondo del Duca e il mondo dei reietti». Rigoletto, secondo Martone, è il «pusher» del Duca.
Il superdonnaiolo Duca, ben restituitoci dal tenore Gaetano Salas, ha nuovamente incantato Gilda, la giovane attivissima, deliziosa, soprano di origine svizzera Regula Muhlemann. E assieme a Rigoletto ci ritroviamo increduli ad aprire il sacco ritrovando Gilda anziché Il Duca: lei, perdutamente innamorata di questo perfido caccia femmine, si fa uccidere dal killer Sparafucile, interpretato da Gianluca Buratto, per salvare il padre che invece la voleva rifugiata a Verona per toglierla dalle grinfie del Duca.
Verdi, che trasse il «Rigoletto» dal dramma Le roi s’amuse di Victor Hugo lo mise in scena (subito inondato da infinite polemiche) a La Fenice nel febbraio 1851 con l’aiuto, sotto lo stretto controllo di Verdi, del librettista Francesco Maria Piave. Lo stesso era successo nel 1832 con la regia di Victor Hugo che portò in scena il suo Le roi s’amuse a Parigi alla Comédie-Française. Lo tolsero dal palcoscenico già il giorno dopo prima, a causa della indignata censura parigina.
I motivi della proibizione sono sempre gli stessi: al posto del Duca di Mantova verdiano, Hugo aveva messo come protagonista il Re sovrano della grande Francia rinascimentale. Anche lui allegramente dedito ad ogni abiezione libertina: seduzioni di mogli altrui, esercizio del potere a fini sessuali, corteggiamenti sotto mentite spoglie, stupri, visite serali in case di malaffare. Insomma lo stesso personaggio, con altra carica nobiliare, che Verdi ci restituì nel suo «Rigoletto», sempre associato al suo servitore, buffone brutto e gobbo, che poi gli si rivolta contro per cercare di salvare la figlia.
Il Rigoletto inizialmente si avrebbe dovuto chiamare «La Maledizione», e la censura veneziana, visto il libretto, subito lo colpì duramente vietandone la messa in scena a La Fenice perché ritenuto «di una ributtante immoralità ed oscena trivialità».
Francesco Maria Piave, in pochi giorni, tentò subito di ammorbidire il libretto e ribattezzò l’opera con il nuovo possibile nome: «Duca di Vendôme». Ma a Verdi questo rifacimento ammorbidito del testo non piacque assolutamente. E ribadì al librettista che «la maledizione del vecchio così terribile e sublime nell’originale, qui diventa ridicola perché il motivo che lo spinge a maledire non ha più quell’importanza, e perché non è più il suddito che parla così arditamente al Re... In somma di un dramma originale, potente, se ne è fatto una cosa comunissima, e fredda... In coscienza d’artista io non posso mettere in musica questo libretto».
E Verdi alla fine, in una successiva riunione con i censori veneziani e Piave riuscì a convincere tutti a rispettare i punti chiave del «Rigoletto» che conosciamo tutt'oggi e che Verdi definì fin da subito «una delle più grandi creazioni del teatro moderno».
Il suo «Rigoletto» fece furore e generò subito scandali a Venezia e poi in tournée in tutta Italia. Del resto sappiamo che il tema della paternità in Verdi è sempre scottante. La prigionia in cui tiene Gilda è segno della coscienza sporca del protagonista: Gilda paga la colpa del padre di essere colluso. E questo rende terribile il loro rapporto. Nel III atto Rigoletto porta Gilda nella locanda di Sparafucile e le chiede: «L’ami?», e lei gli risponde: «Sempre». In questo «Sempre» il regista legge un gesto di ribellione che rende il personaggio molto più interessante.
E Martone giustamente sottolinea che «nel teatro verdiano contano soprattutto gli elementi di verità, che ha volte possono e anzi devono essere sgradevoli. Più che “bello” o “brutto” mi interessa quindi ciò che è giusto rispetto all'intenzione di Verdi, per ascoltare il grido di quest’opera. Quello che ci dobbiamo chiedere è: cosa riusciamo a scorgere oggi scendendo nelle profondità di questo abisso?».
E lui, assieme a Margherita Palli (che ha avuto una lunga esperienza teatrale con Ronconi) e a tutto il cast, ci ha immerso egregiamente in queste tematiche fondamentali dell’essere umano. Applausi ripetuti a scena aperta e trionfo finale, con la strage nella casa del Duca, alla faccia dei melomani tradizionalisti che non vogliono mai cambiare nulla.
Altri articoli dell'autore
Affidato alla bravissima Fabrizia Sacchi, il testo di Antonio Tarantino messo in scena dal regista premio Oscar e da Stella Savino è un racconto di bassifondi e reietti. Il lamento della madre, una donna di vita, è un flusso inarrestabile di parole, feroce e lirico al tempo stesso
Nell’allestimento di Shirin Neshat dell’opera di Gluck in scena al Teatro Regio di Parma, il cantore e la ninfa sono un uomo e una donna contemporanei che vivono l’amore, il dolore e l’incomunicabilità
Al San Carlo di Napoli, e poi in tournée in varie città, gli incontri straordinari del padre del «Teatro d’arte per tutti» e la sua amicizia con Eduardo De Filippo
Il giornalista e scrittore sta portando in tour per l’Italia il suo fortunatissimo saggio sul patrono d’Italia, di cui il prossimo anno ricorrono gli 800 anni della morte