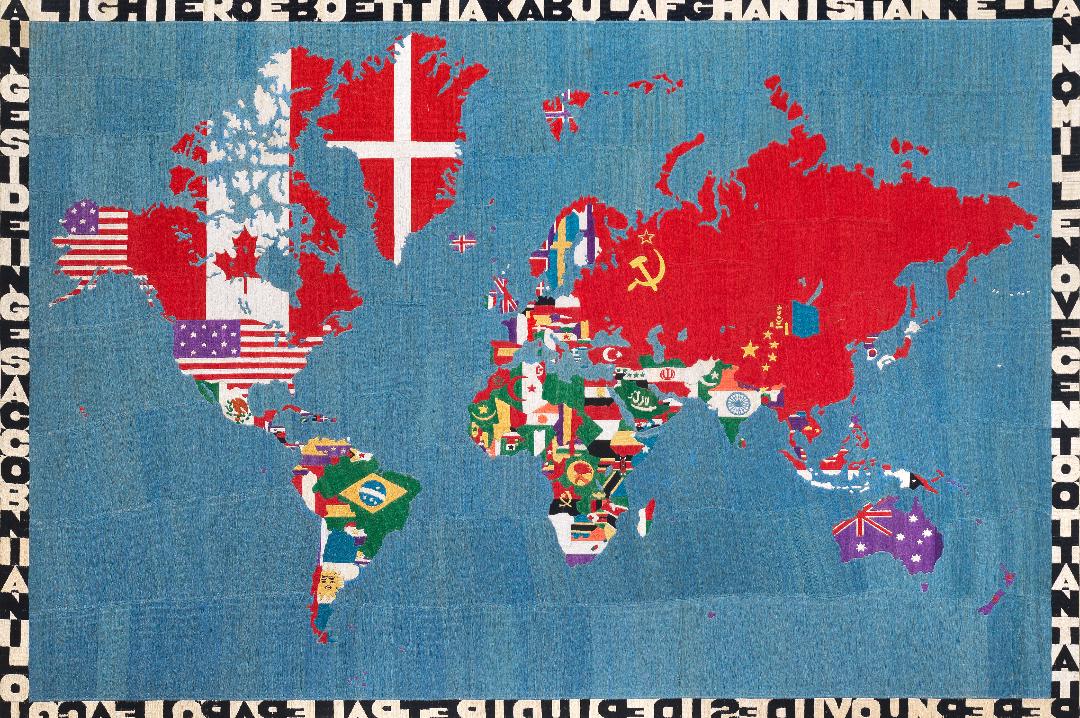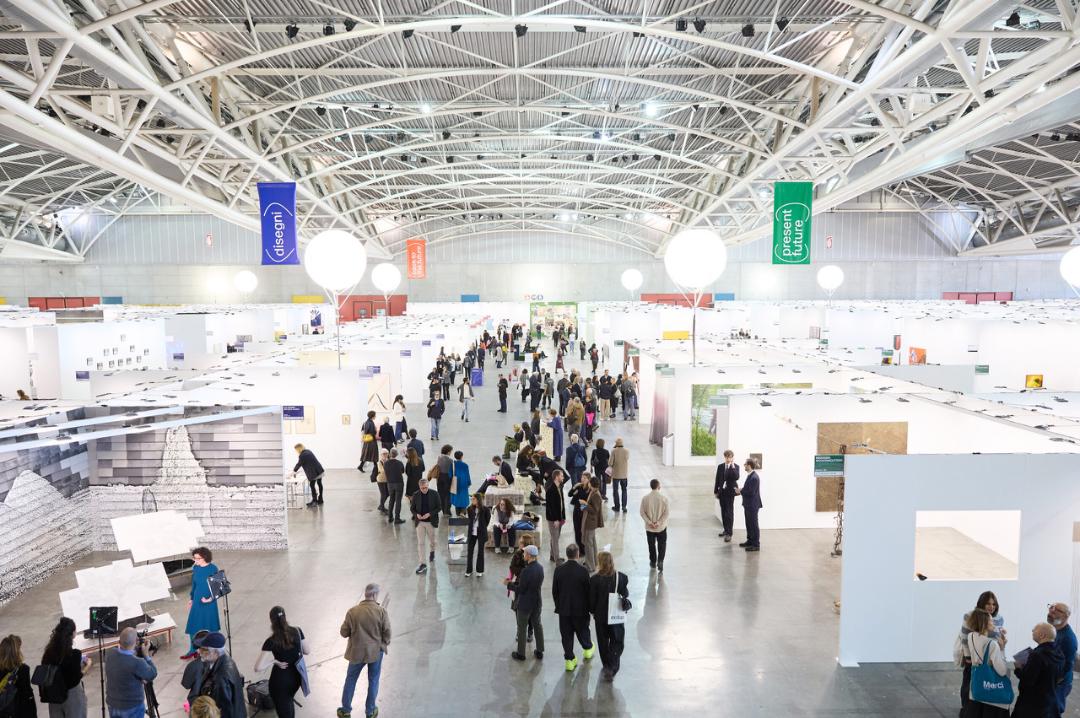Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
ARTICOLI CORRELATI
Il neopresidente di Confindustria Cultura Luigi Abete può già festeggiare un primo traguardo: l’abbassamento dell’Iva sulle opere d’arte passato dal 22 al 5% a cui la sua associazione ha dato un importante contributo. Ma l’obiettivo è più ambizioso, ovvero che il 5% diventi l’aliquota unica per tutto ciò che riguarda la cultura, compresi mostre e musei. In questa sua prima intervista dopo la nomina avvenuta il 14 maggio, Abete apre le porte a gallerie, antiquari e operatori del mercato dell’arte che potrebbero essere rappresentati da Confindustria Cultura al pari di cinema, editoria e musica: «Allargare le maglie è sicuramente uno dei miei intendimenti e l’arte potrebbe fare il suo ingresso attraverso Aicc, l’Associazione imprese culturali e creative». Una svolta determinante per un settore troppo poco rappresentato e sin troppo parcellizzato che spesso manca di pragmatismo.
Abete, che tra i suoi innumerevoli impegni è anche presidente di Civita Holding e fa parte del consiglio di amministrazione della Treccani (si definisce «collezionista d’imprese»), immagina poi un nuovo rapporto tra pubblico e privato affidando la gestione dei servizi museali alle aziende che si potrebbero occupare dei tanti luoghi abbandonati (sono almeno 600) del Bel Paese. Più che in armamenti, sarà necessario riconvertire in cultura. Da qui passa il futuro del Made in Italy.
Presidente Abete, l’Iva sulle opere d’arte è passata dal 22 al 5%, una riforma attesa per decenni. È davvero una svolta?
Certamente. Confindustria Cultura ha sostenuto questo provvedimento assolutamente necessario per rilanciare l’intera filiera. Non aveva alcun senso che l’Italia fosse totalmente emarginata tenendo conto che la Francia applica da inizio anno un’Iva del 5,5% e la Germania del 7%. Ora si riaprono i giochi e il nostro Paese torna a essere competitivo. Questo non può che essere motivo di grande soddisfazione. Ma la mia idea è andare ancora più in là.
Mi spieghi meglio.
L’ipotesi è giungere, durante il mio mandato triennale, all’armonizzazione fiscale con un’aliquota unificata del 5% su beni e servizi culturali. Le mostre, i film in sala e gli spettacoli dal vivo per esempio hanno il 10%, mentre i musei pubblici sono esenti. L’acquisto di un Cd musicale o di un Dvd prevede addirittura il 22%. Un ginepraio da cui è difficile districarsi, che crea ingiustificate disparità. Il 5% insomma per tutta la cultura, come sostiene anche Federculture.
Insieme all’Iva, un altro nodo cruciale è quello della notifica che ostacola la circolazione dei beni culturali considerati d’interesse pubblico con oltre 50 anni. C’è stato uno spiraglio per allungare i tempi sino a 70 anni, ma la situazione non è affatto chiara. Lei è favorevole a un «passaporto europeo» per le opere d’arte?
Senza l’Europa non abbiamo un futuro e dunque sono favorevole a tutto ciò che permette di giungere a norme condivise, sburocratizzando il sistema anche nell’ambito della circolazione.
Per quale ragione le arti visive non sono contemplate da Confindustria Cultura? Sono rappresentate imprese editoriali, discografiche e quelle coinvolte nel cinema, nella multimedialità e nell’audiovisivo attraverso le loro associazioni più importanti. Dell’arte invece nemmeno l’ombra.
Tra gli obiettivi del mio mandato c’è sicuramente quello di ampliare i settori al di là di quelli che ha citato. Per le associazioni delle gallerie e gli operatori del mercato dell’arte lo strumento più adeguato è l’Aicc, Associazione imprese culturali e creative che fa parte di Confindustria Cultura.
A chi si rivolge Aicc?
A chi produce e gestisce servizi per la valorizzazione culturale e comprende i settori della gestione museale, produzione e organizzazione mostre, logistica per l’arte, innovazione e tecnologie culturali, editoria per l’arte e per musei. Tra i soci c’è anche l’Associazione italiana archivi e musei d’impresa.
Rispetto agli strumenti attualmente disponibili questo appare il più idoneo, sebbene accanto ai servizi museali bisognerebbe occuparsi anche della produzione di opere d’arte, un aspetto essenziale per lo sviluppo del contemporaneo. Ma è evidente che la presenza in Confindustria Cultura di galleristi e antiquari rappresenterebbe una svolta determinante.
Si potrebbero creare nuove sinergie dando il giusto spazio alle istanze culturali di settori che talvolta vengono percepiti come elitari, indirizzati esclusivamente a una nicchia ristretta. L’associazionismo è il driver del Paese e dunque anche arte e antiquariato sono i benvenuti.
Le categorie che rappresentano gli operatori dell’arte sono tante, forse troppe. Nell’ambito dell’arte moderna e contemporanea si contano il Gruppo Apollo, Italics e Angamnc, l’Associazione Nazionale Gallerie d’arte moderna e contemporanea. Quanto all’antiquariato ci sono Fima (Federazione Italiana Mercanti d’Arte) e Aai (Associazione Antiquari d’Italia). Non manca poi Anca (Associazione Nazionale Case d’Asta). Con chi di queste potrebbe dialogare?
In questa fase non mi è possibile rispondere. Ma sicuramente sarebbe importante confrontarsi con chi ha una maggior rappresentanza. In base alla mia esperienza, posso dire che ci vuole pragmatismo per ottenere dei risultati e che un’eccessiva parcellizzazione non giova. Cento imprese con tre dipendenti hanno una minor capacità persuasiva di una sola azienda con 100 dipendenti. Chi cresce quantitativamente cresce anche qualitativamente. Ho cominciato l’associazionismo partendo da un’élite e ora mi trovo dinnanzi a un movimento.
Il mercato dell’arte internazionale è concentrato nelle mani di un gruppo ristretto di supergallerie con diverse sedi nel mondo. L’Italia rimane prevalentemente legata ad aziende familiari che, come zattere in mezzo al mare, subiscono le continue mutazioni dei venti.
La situazione mi ricorda un po’ quella degli anni Novanta quando ho gestito la privatizzazione di Cinecittà, avvenuta nel 1997. Prima di allora il settore cinematografico italiano era frammentato, le società di produzione apparivano vulnerabili e un solo insuccesso al botteghino poteva compromettere la loro sopravvivenza. Con la nascita di Cinecittà Holding e di Cinecittà Studios, oggi Cinecittà Spa, si è giunti al consolidamento dei produttori rendendo l’industria cinematografica più competitiva e sostenibile.
Un modello che si potrebbe applicare all’arte?
Le posso solo dire che chi rimane isolato conta come il due di briscola.
Sarebbe quindi disponibile a organizzare un tavolo programmatico con i rappresentanti di categoria e «Il Giornale dell’Arte», nel quale analizzare concretamente la possibilità di rappresentare le arti visive in Confindustria Cultura attraverso Aicc?
Sono sempre disponibile a interloquire con chiunque. Ma prima di fare un passo di questo tipo sarebbe fondamentale sapere con chi avviene il confronto e quali interessi vengono rappresentati. E poi non sarò certo io a propormi. Sono le associazioni che devono fare il primo passo. Io, come le ho detto, posso mettere a disposizione gli strumenti.
Un’altra questione importante per incentivare il settore dell’arte è l’ampliamento dell’ArtBonus, come ha proposto anche Maurizio Lupi di Noi Moderati. Non crede che le detrazioni fiscali dovrebbero favorire anche le aziende che acquistano opere d’arte?
È necessario distinguere tra chi acquista per sé e chi invece lo fa con una finalità pubblica, mettendo il proprio patrimonio a disposizione della collettività. Solo in questo secondo caso vanno previsti incentivi.
Di recente il Gruppo tecnico cultura di Confindustria ha contribuito alla realizzazione di una ricerca sul «collezionismo corporate» in Italia confluito nel volume edito da Marsilio «Il segno dell’arte nelle imprese». Confindustria ha una propria collezione?
No, in quanto rappresenta la galassia delle imprese. Ma in futuro si potrebbe ipotizzare una catalogazione delle opere che appartengono al sistema confindustriale.
Il rapporto pubblico privato è un altro nodo centrale che riguarda anche la gestione e i servizi museali.
A oltre trent’anni dall’applicazione della Legge Ronchey si sta affermando una pericolosa tendenza da parte dell’Amministrazione pubblica a statalizzare sempre più le attività operative gestionali. Basti pensare al Colosseo, la cui gestione dei servizi è tornata nelle mani dello Stato. O a Pompei, dove i privati sono esclusi. Ma questo atteggiamento appare nocivo non tanto per i grandi hub museali, visitati ogni anno da milioni di persone, quanto per l’infinità di luoghi che attendono di essere valorizzati.
In che modo potrebbero incidere le imprese sulle realtà decentrate?
In Italia ci sono almeno 600 luoghi d’arte abbandonati che spesso sono gioielli architettonici o straordinarie testimonianze del passato. Ebbene, vanno rimessi in circolazione incentivando un turismo alternativo che consentirebbe ai territori, anche quelli periferici, di crescere. Tale obiettivo si può raggiungere con il contributo delle imprese intese come attrattori culturali. Sono loro che potrebbero gestire i servizi museali, dalla ristorazione al merchandising, riconvertendo una parte della loro attività.
Lo slogan insomma potrebbe essere «600 luoghi d’arte per 600 imprese».
Esattamente. Una formula che consentirebbe di rigenerare le imprese e contemporaneamente i luoghi della cultura, con ampi benefici per la collettività. Per ciascun operatore privato, il proprio mestiere diventerebbe la propria immagine.
Lei è collezionista?
Sono nato tipografo e da sempre sono collezionista d’imprese.
Se dovesse realizzare una collezione d’arte, su quali criteri si baserebbe?
Idealmente mi piacerebbe realizzare una collezione «sinergica» dove prevalga la circolarità del pensiero, come avviene ad esempio con taluni scatti fotografici di Steve McCurry, che ci proiettano verso luoghi remoti in un viaggio nel tempo di grande fascino e bellezza.
Altri articoli dell'autore
La mappa della Penisola Arabica si allarga: debutta Art Basel Qatar curata da Wael Shawky, sostenuta a suon di milioni di dollari dalla famiglia dell’emiro e dalla sceicca Al Mayassa
La rubrica di «Il Giornale dell’Arte» che stabilisce i momenti cruciali delle tendenze economiche dei principali artisti presenti sul mercato italiano: le quotazioni dell’artista veneziano sono salite con moderazione del 38% in 15 anni, mentre Afro e Birolli hanno perso terreno. Chi viaggia controcorrente ne approfitti
Ha causato perdite anche del 90% in 2 anni. Le maggiori responsabili sono le case d’asta che, dopo aver gettato nel panico il mercato con gli Nft, lo hanno rifatto con i giovani sotto i 40 anni con conseguenze ancora peggiori
Il presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone racconta in esclusiva le novità previste dalla legge quadro «Italia in scena». E dopo l’abbassamento dell’Iva lancia il passaporto digitale