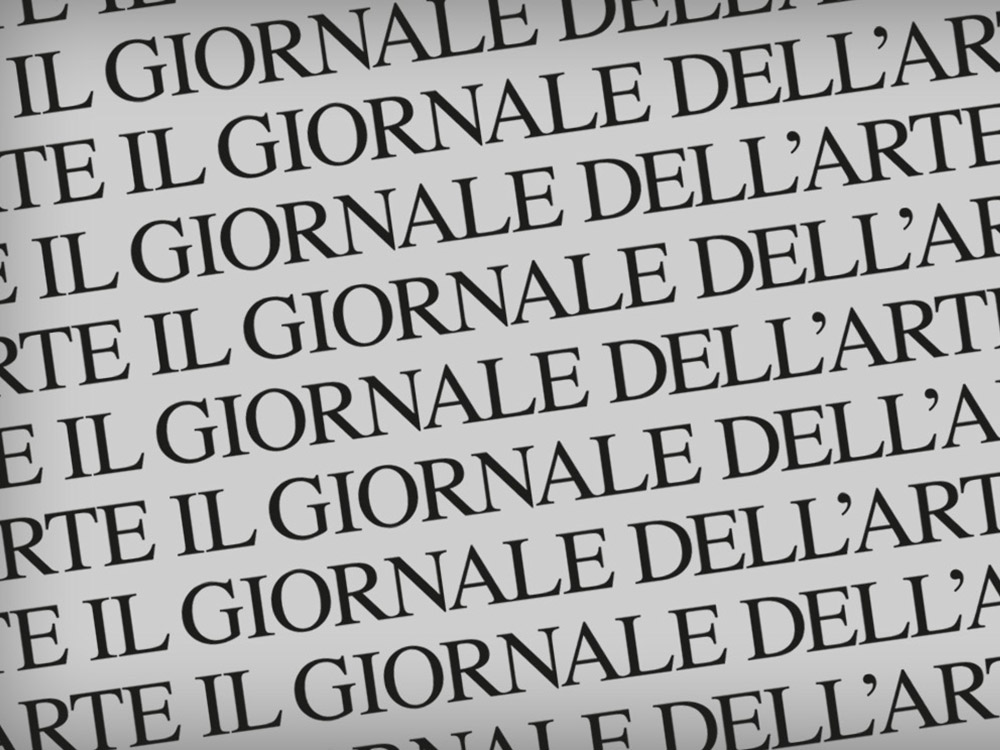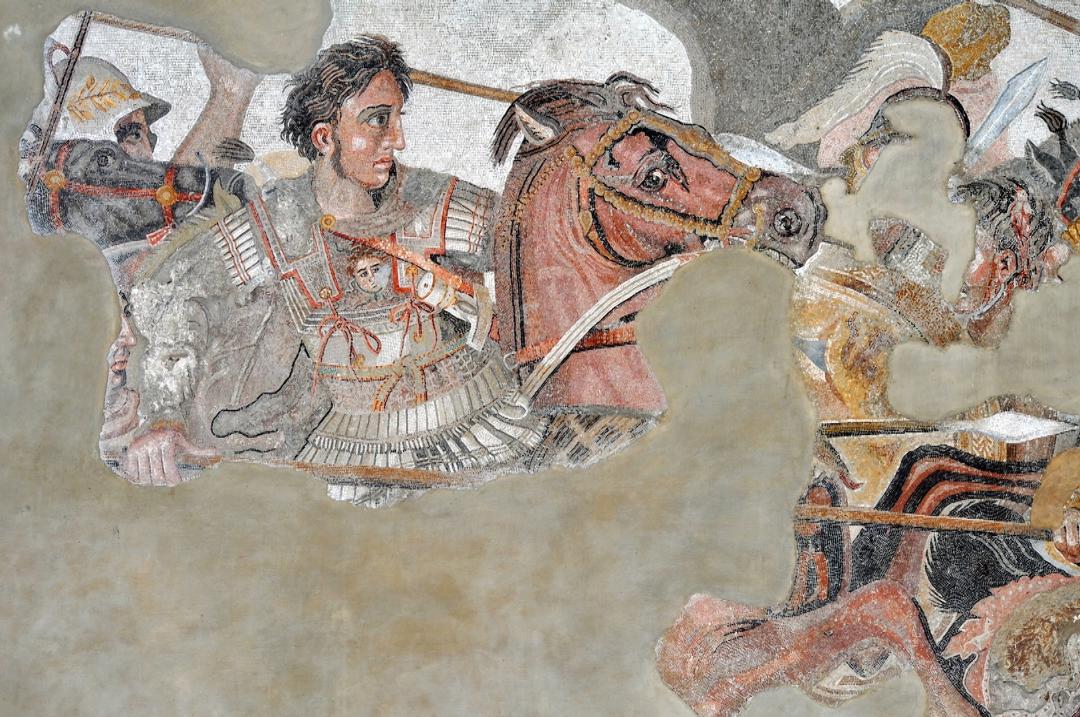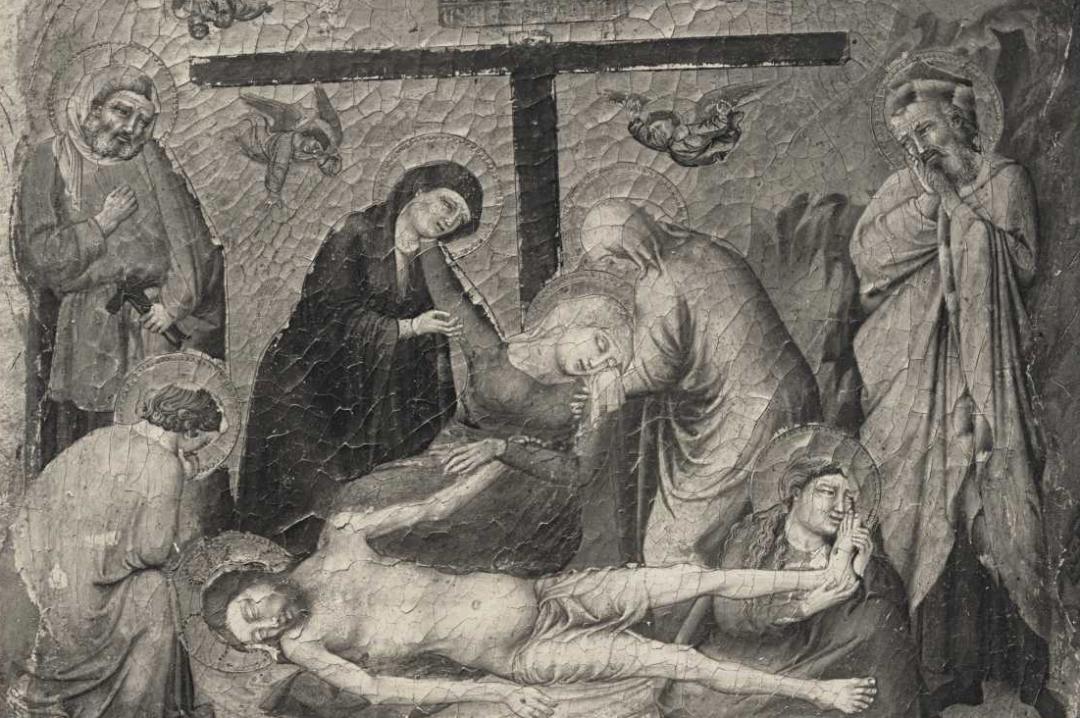Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Giorgio Bonsanti
Leggi i suoi articoliUn titolo e un argomento audaci e impegnativi, quest’anno, per il convegno «Scienza e Beni Culturali» tenuto a Bressanone a fine giugno, perché si parlava de «Le nuove frontiere del restauro-Trasferimenti, contaminazioni, ibridazioni».
Le discussioni sono state animate; ognuno presentava le proprie interpretazioni quanto a cosa intendere per frontiere, ovvero i loro sinonimi o omologhi, quali limiti, confini, ma anche barriere; e in ogni caso forte era l’impulso a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Soprattutto in questo momento di sofferenza per il restauro, un’area estesa che comprende sia le innovazioni tecnologiche che, e soprattutto, un concetto allargato di conservazione: in rapporto dunque con l’ambiente, le città, e l’edilizia non soltanto storica e protetta, ma anche intesa più genericamente nelle sue funzioni d’uso e di presenza nelle realtà urbane e nel paesaggio.
Da Giovanni Salmistrari, dell’Associazione Costruttori del Veneto, abbiamo imparato che il mercato edilizio appare oggi molto più orientato al recupero che alle nuove costruzioni: il 70% del lavoro sta attualmente nella riqualificazione, e la notizia non poteva che rallegrare, anche se raggelava sentire che nella Venezia d’oggi il rapporto fra ultrasessantacinquenni e bambini è di sei a uno. Si è insistito abbondantemente, fin dall’intervento di Daniela Pittaluga della Scuola Politecnica dell’Università di Genova, sulla partecipazione delle esperienze, sulla rivalutazione dell’edilizia comune cui correlarsi, non diversamente da quella normalmente definita come protetta o da proteggere secondo i parametri tradizionali. Di qui l’importanza attribuita alle svariate forme di volontariato, il riconoscimento del valore delle comunità locali: il cosiddetto modello inglese (certo, impraticabile se comunque non sorretto, a un qualche stadio del processo, dalle cosiddette competenze). Di qui i replicati inviti a superare le separazioni fra pubblico e privato, ritenute artificiose e tali da appesantire con zavorra improduttiva le iniziative a sostegno del patrimonio storico e artistico. Emergeva con evidenza l’inderogabilità del superamento di un modello di tutela fondato soltanto sui vincoli e il potere monocratico degli Uffici preposti; e su questo non si può che concordare, prendendo atto oggi che il Paese richiede proprio questo; ma naturalmente rimane il problema della salvaguardia materiale e dell’identità storica del patrimonio edilizio e paesaggistico, senza la quale anche la famosa valorizzazione resterebbe parola vana.
Parafrasando Kant, si potrebbe dire allora che la tutela senza la valorizzazione è cieca, ma anche la valorizzazione senza tutela è vuota. Ricorderemo così il bell’intervento di una studentessa, «professionale» più di tanti del mestiere, a illustrare le sperimentazioni di educazione alla tutela nel Liceo scientifico Belfiore di Mantova. E menzioneremo, fra i molti temi d’interesse trattati, le cave e le miniere, i bunker e i rifugi di terra, le aree industriali dismesse. L’eccessivo entusiasmo ha comportato qualche errore d’informazione; così nell’appassionato intervento di Teresa Perusini si scriveva che i nuovi metodi di puliture acquose inventati in America da Richard Wolbers avevano incontrato l’iniziale indifferenza delle Scuole di Alta Formazione, mentre al contrario fu proprio l’Opificio nei primissimi anni Novanta ad accogliere e promuovere tempestivamente le ricerche della persona che in Italia ha avuto i maggiori meriti in proposito, il chimico Paolo Cremonesi.
Una discussione accesissima è nata a margine dell’intervento sulle attuali operazioni, definite di manutenzione, applicate al MaXXI, che vengono a costare la bellezza di due milioni di euro per un edificio terminato otto anni fa (fin dagli inizi era prevista una manutenzione quinquennale). Da più parti si sono levate proteste contro le archistar cui non può essere più consentito di eludere sistematicamente i temi della sostenibilità reale, a cominciare dalla funzionalità e dall’economicità; forse davvero, come ha sostenuto Stefano Musso dell’Università di Genova e ha ripreso Elisabetta Zendri nelle conclusioni ottimamente riassunte, la nuova frontiera del restauro sta nell’etica. Ciò dovrebbe esser vero per qualsiasi manifestazione della società civile, chissà che la crisi non abbia favorito un risveglio nella coscienza dei cittadini; non andranno più a votare, ma lameno paiono cercare altre forme di partecipazione
Altri articoli dell'autore
Aperto per restauri • Nel mestiere più bello del mondo il «fattore umano» sarà scalzato dall’IA? Speriamo tanto di no
Aperto per restauri • Diagnosi sul restauro da restaurare di Giorgio Bonsanti, già professore all’Università di Firenze
Aperto per restauri • A un anno dall’inaugurazione del museo, nella nuova sede di Palazzo Cavalli si è tenuto un convegno rivelatosi occasione interessante e piacevole per presentare un’ampia casistica di interventi conservativi infrequenti
Orietta Rossi Pinelli ripercorre le principali tappe di come sono cambiate le regole dalla Carta di Atene del 1931 ad oggi