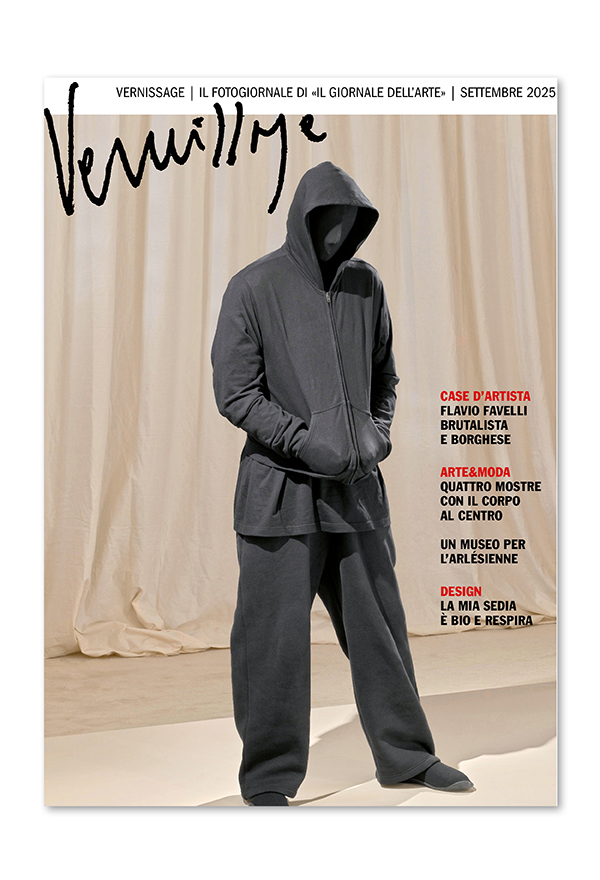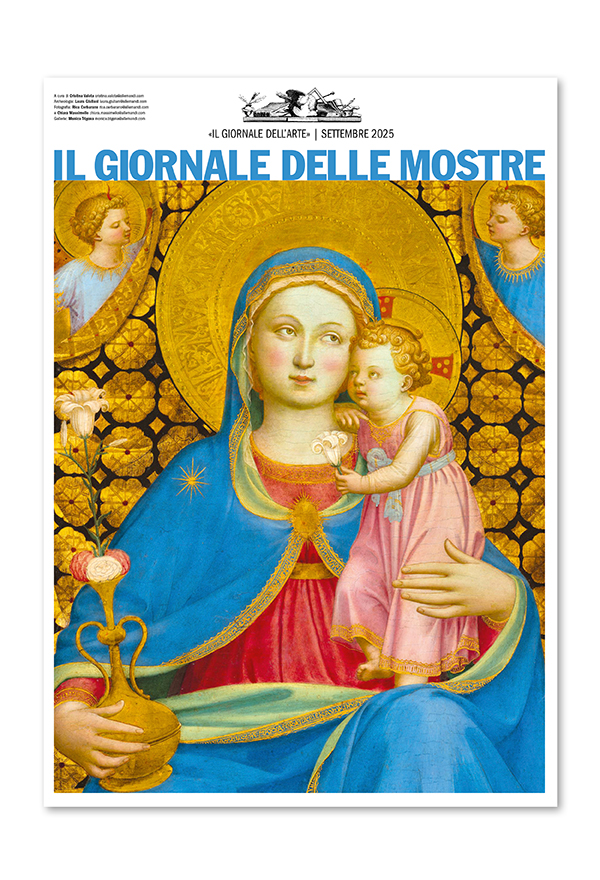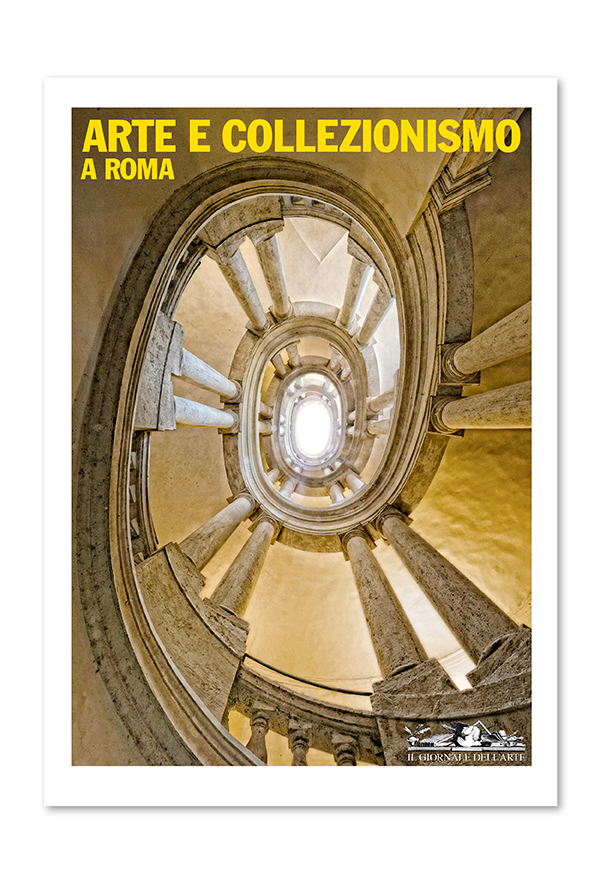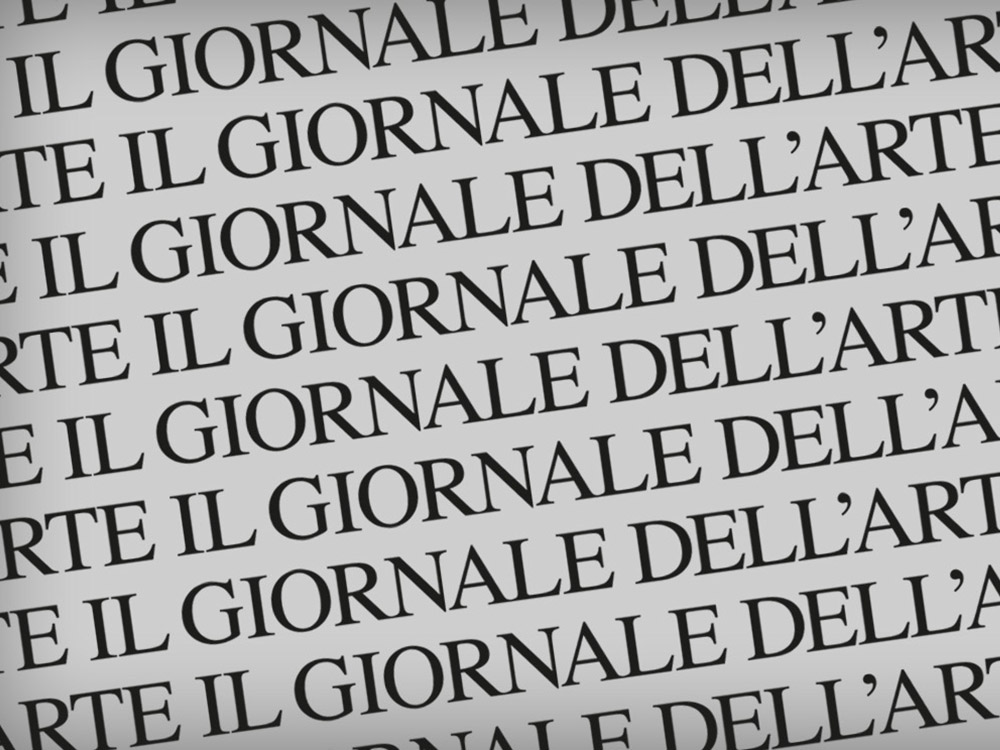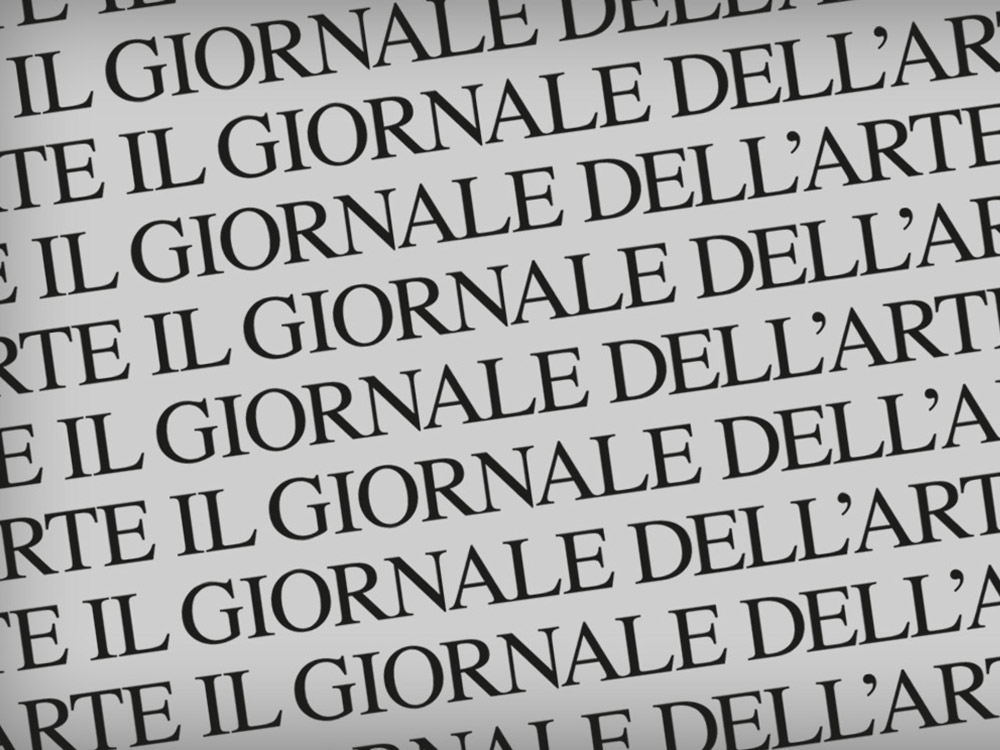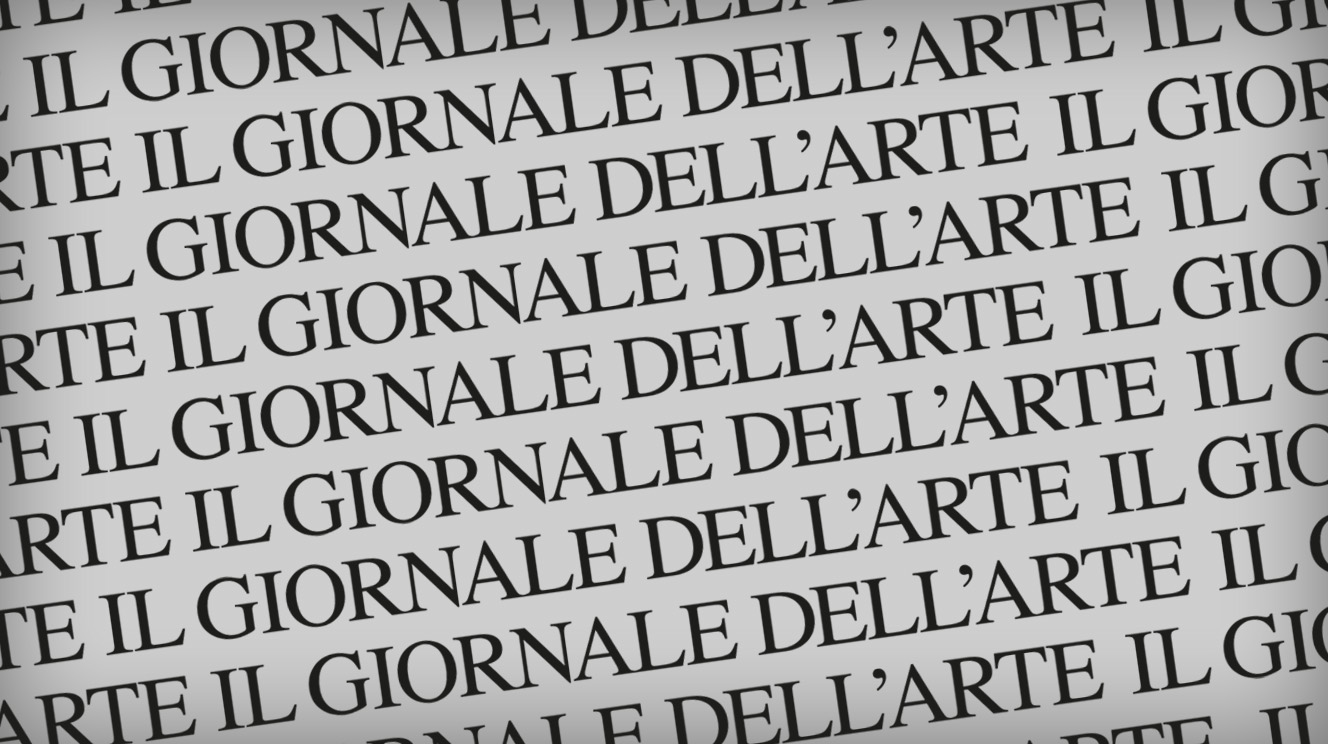Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Jean Clair
Leggi i suoi articoliIl decano dei galleristi parigini, Claude Bernard, è morto nella capitale francese mercoledì 16 novembre a 93 anni, a seguito di una lunga malattia. Nato nell’ottobre del 1929, aveva fondato nel 1957 la Galerie Claude-Bernard che da allora si trova al 5-7 di rue des Beaux-Arts, nel centro di Saint-Germain-des-Prés: «Un dandy gioioso, malizioso ed elegante. Muore un scena come Molière» testimonia Cécile Debray nel «Figaro». E Bernard Blistène, già direttore del Pompidou: «Era l’incarnazione dell’eleganza e della cultura. Lontano dalle mode, ha difeso gli artisti che amava per 70 anni, uno degli ultimi a mantenere una certa idea di pittura. Dotato di un umorismo acre, ha visto gli artisti che aveva sostenuto contro ogni previsione trovare il loro pubblico, apparire ora in tutta la loro maestosità. Con lui scompare il mito del mercante d’arte, oggi molto raro».
Il caro amico Claude Bernard ci ha lasciati in un momento particolare della nostra storia. Un’epoca in cui si smantellano le statue dei grandi uomini, in cui s’imbrattano i capolavori, da Vermeer a Klimt, in cui si bruciano i luoghi di culto, in cui l’educazione sparisce travolta dall’impeto di una volgarità crescente, in cui infine l’intolleranza religiosa diventa omicida. La morale che Claude aveva servito e celebrato era diversa. Se una sola parola bastasse a definire una persona, direi che Claude Bernard era la riservatezza. Riservato come sono i taciturni, i silenziosi. Da qui, forse, il suo volto spesso severo, la sua mancanza di cordialità, la sua freddezza, la sua impazienza di tagliare corto. Ma quella riservatezza non era né disprezzo, né rifiuto, né ritirata. Troppo controllato, troppo trattenuto per esprimere i suoi sentimenti, troppo attento allo stesso tempo per lasciarli trasparire. Un uomo apparentemente freddo ma curioso, cauto ma sorprendentemente presente con chi lo incontrava.
«Riservare» discende dall’etimologia latina di servare, in Cicerone per esempio. Ovvero badare solo ai posteri: conservare, preservare, rinviare per mantenere meglio. Preparare ciò che verrà dopo. Eccoci dopo. Nei musei si chiama «riserva» il luogo in cui le opere d’arte vengono conservate nell’attesa di metterle in luce al momento debito. Chiamiamo riserve anche le annate nobili dei vini che facciamo attendere prima di gustarli. In un periodo di penuria misuriamo le riserve, dal tempo che passa ci aspettiamo un potere di conservazione. L’arte è diventata così preziosa che va preservata prima di essere guardata, conservata prima di essere servita. Una morale, un gusto, un rispetto agli antipodi delle frenesie che oggi regolano il commercio dell’arte. Claude Bernard era l’opposto di quei mercanti che non hanno altra premura se non quella di vendere al prezzo più alto le opere che si vantano d’aver scoperto. Un’avanguardia tonante e pletorica sempre in anticipo sul corpo d’armata, la riserva di quadri che domani dovrà essere valorizzata.
Claude Bernard è stato uno degli ultimi mercanti ad aver saputo conservare il senso e la dignità del proprio mestiere, quando l’intero mercato dell’arte è divenuto un gigantesco mercato di aste, sostenuto da organismi ufficiali che costituiscono non riserve, bensì depositi sempre più grandi delle produzioni effimere dell’arte contemporanea. Riserva, ritiro e riflessione. Ricordo quand’ero studente e visitavo le prime volte la sua galleria. Era lì, immobile e silenzioso, e se un appassionato varcava la sua porta per chiedergli un consiglio, lo conduceva discretamente in una stanza appartata e per lui tirava fuori alcuni dei tesori che teneva in serbo dei quali sottolineava, con poche parole, il singolare interesse.
Severo, riservato, attento, per dare alle opere il tempo di rinascere. «Padre severo», avrebbe detto Lacan. Raramente lo si vedeva sorridere, ancor meno ridere. Mentre oggi in televisione vediamo migliaia di sorrisi e risate che si susseguono senza fine, sui volti di tutti coloro che lì vanno a parlare incuranti che ciò di cui si parla sia spesso tanto grave, tanto spaventoso. Tutto è un pretesto per ridere o sorridere. Mascherata, ironia, sberleffo. Il nostro mondo è diventato così buffo e così derisorio? In questa mascherata senza fine che cosa rimane del valore dell’arte? Il nostro mondo è così leggero da non poter più condividere la serietà che fa esistere l’arte.
Claude Bernard non rideva e ricordava a tutti che, nel conforto e nella gioia che ci porta, l’arte è infinitamente seria. Così, nel tempo, si è formata una compagine di una quindicina di creatori che oggi possiamo considerare il tesoro artistico del nostro tempo, la nostra riserva per un futuro così oscuro. Li conosciamo: da Giacometti a Balthus, da Bacon a Sam Szafran e gli altri. Quelli cui i musei si erano avvicinati solo da lontano, che esponevano così male o così poco o che a volte addirittura rifiutavano di esporre. Sono gli artisti che in questi quattro decenni anch’io ho cercato di far conoscere senza mai essermi consultato con Claude... Più che un evento commerciale o sociale, il vernissage da Claude era l’appuntamento fisso di una certa società, l’occasione per una sera di incontrarci e confrontarci con una piccola folla di artisti, di amatori d’arte, ma anche di collezionisti competenti, di scrittori e musicisti e filosofi, e di semplici amici... un’élite che ogni volta nel mezzo di una volgarità crescente ci si stupiva di vedere ancora sulla scena.
L’incontro dopo cena era diventato un momento alto della civiltà parigina: come se fosse lì, prima di tutto e grazie all’intelligenza e alla generosità di Claude, l’estensione di un’arte di vivere dove ritrovavamo il tono e il calore delle cene descritte da Marcel Proust, delle serate dipinte all’inizio del secolo da Jean Béraud e da Prinet ove si riunivano gli ultimi rappresentanti di una società intellettuale già in via di estinzione. Le stesse persone avrebbero poi scoperto con sorpresa e felicità, nella sua casa in rue de Lille, un museo personale con centinaia di pregiati e intimi souvenir, di dipinti, disegni, ma anche foto, oggetti, manoscritti che testimoniavano una sensibilità eccezionale impegnata a perpetuare e a conservare ciò che di più prezioso c’è nella nostra memoria. E pochi eletti ogni estate nella casa di Claude in Turenna potevano godere quel suo tramandare le qualità più alte di una società che rischiava di sfaldarsi.
Scrittori, filosofi, musicisti selezionati come Jean Guillou e i suoi concerti d’organo nel fienile, sino alle serate intime in ascolto del pianoforte di Alain Planès. E sulle pareti delle stanze, ancora, abbandonate allo sguardo di tutti, migliaia di testimonianze degli amici che ci avevano preceduto, foto, disegni, incisioni e oggetti degli scrittori e dei pittori che erano stati prima di noi gli ospiti eletti tra i quali noi ora circolavamo, quasi intimiditi, come intrusi o importuni.
Chi saprà dire che cosa sono state quelle ore, quei giorni, quelle settimane in cui, durante le serate dei vernissage, i soggiorni alla Besnardière, gli incontri veneziani, rinascevano e rivivevano le caratteristiche più preziose di ciò che un secolo prima era stata la cultura a Parigi? Il mercato dell’arte, certamente, per i pittori e per gli appassionati. Ma anche, calato il sipario e svanita la severità, quella stupefacente generosità che accoglieva con distinzione, sapienza e riguardo l’élite di una società che praticava ancora con delicatezza le arti e le lettere.
Da un lato c’era la galleria, discreta, chiusa e silenziosa, ma anche la gigantesca biblioteca, con le sue migliaia di volumi, così accuratamente disposti che sarebbero stati il vanto di un’università. E c’erano i concerti, dove, una volta di più, credevamo di rivivere quella che un secolo prima era stata la società di Proust. Da oggi cominceremo a misurare quale immensa generosità, curiosità e passione per il prossimo si celavano così bene sotto la riservatezza ostentata di Claude Bernard.

Claude Bernard. Foto: Laura Bossi Régnier
Altri articoli dell'autore
Dall’ultimo libro di Jean Clair, uscito da poche settimane in Francia e dedicato agli amici, pubblichiamo in anteprima il ritratto di Gianadda, scomparso lo scorso 3 dicembre
Zeri aveva suggerito che «fare l’arte moderna è molto più difficile che fare l’arte antica», ma per il celebre saggista e accademico di Francia «i falsi sono molto più numerosi nell’arte moderna che nell’arte antica». Feticci creati dal mercato
«Il Borghese incoraggia le belle arti (...). La sua intima aspirazione è mettere il Bello a terra, al di sotto della peggiore immondizia, e in queste basse opere nessuno puo' superare i porci artisti» (Léon Bloy)