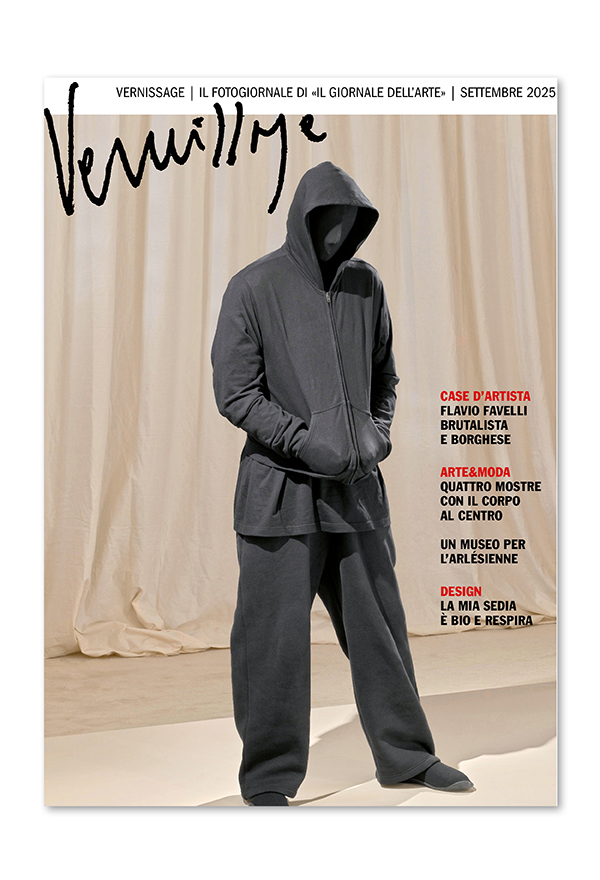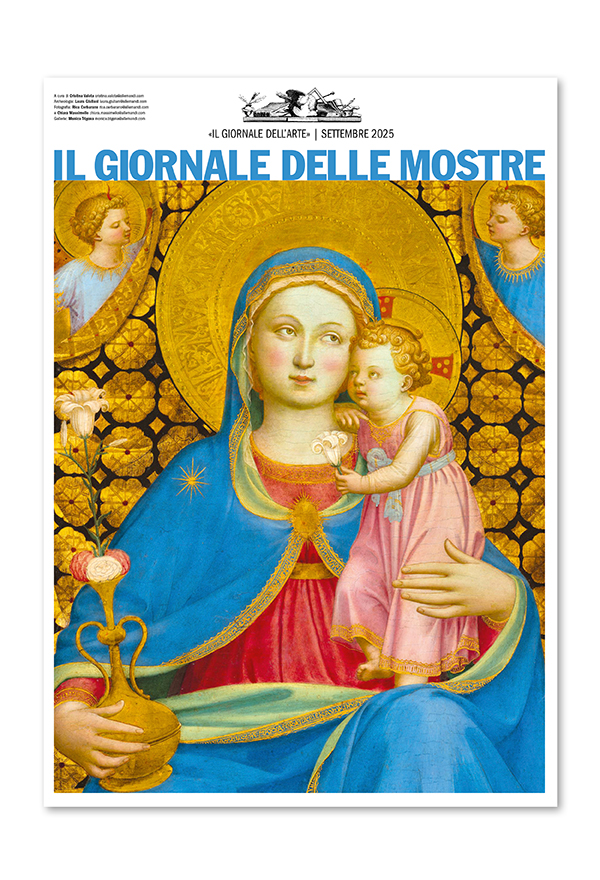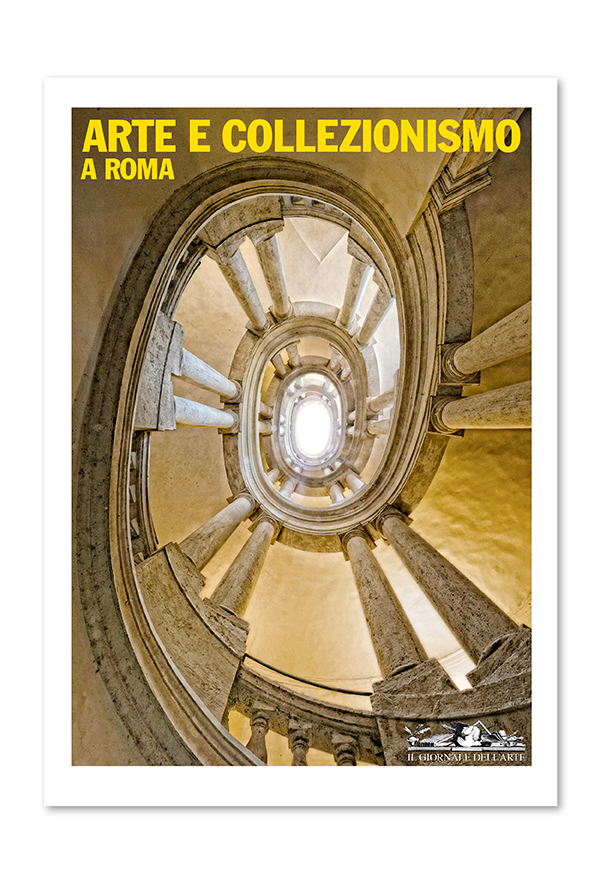Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Matteo Bergamini
Leggi i suoi articoliCi sono parole di cui il mondo dell’arte contemporanea si è appropriato facendone slogan: circolarità, responsabilità, condivisione, accoglienza, tra le altre, senza restituirle alla realtà dei fatti, e delle opere, nella loro interezza.
È tutto quello che non accade, invece, ad Antofagasta (nel «Norte Grande» del Cile), dove da 12 edizioni la Biennale Saco (nata nel 2004 come Festival di Arte Contemporanea), ideata e diretta da Dagmara Wyskiel (polacca naturalizzata cilena, un dottorato in Belle Arti all’Università di Cracovia), si fa teatro dell’arte come strumento per raccontare, indagare e curare un territorio estremo come lo è il deserto di Atacama, il più arido del mondo.
Ma non sono solo le condizioni climatiche a contraddistinguere la regione di Antofagasta: una massiccia attività estrattiva, oggi principalmente di rame e litio, iniziata sul finire del XIX secolo con l’argento e di cui le rovine del complesso industriale dell’azienda Huanchaca (risalenti al 1892, pochi anni dopo la perdita dell’accesso al mare della Bolivia, successivamente agli accordi della Guerra del Pacifico nel 1884) sono un infinitesimo quasi romantico nel bel mezzo di migliaia di chilometri quadrati sfruttati per il loro suolo.
Una condizione che ha portato Antofagasta a essere una città-crocevia senza propriamente esserlo geograficamente: frotte di lavoratori temporanei arrivano e partono da qui, provenienti non solo da tutto il Cile, ma anche da altri stati dell’America del Sud. Per molti di essi, ancora oggi, le condizioni di lavoro e residenza sono precarie, e lo sviluppo urbano antofagastino lo racconta bene: dietro le file di alti condomini su un lungomare disteso per chilometri, si arroccano sulle pendici verticali della Cordillera le tomadas, aggregazioni spontanee sorte al di fuori di piani regolatori e affini, semplicemente come necessità abitative.
In questo scenario, l’arte è un miraggio: «È tremendamente difficile costruire un dialogo con il pubblico in modo paritario, basti pensare che tra i quasi 2.500 chilometri che separano Valparaíso (sulla costa, all’altezza di Santiago, Ndr) e Arequipa (città nel sud del Perù, quasi al confine con il Cile, Ndr) non esiste una sola scuola d’arte, né una facoltà di storia dell’arte, né di fotografia o di cinema, per non parlare di curatela; non esiste un museo che non sia inteso come di cultura popolare, né uno spazio professionale dedicato alle arti visive», ci racconta la direttrice durante l’apertura di «Ecosistemas Oscuros», la 12ma edizione di Biennale Saco (fino al 14 settembre) che si tiene alla Fundación Minera Escondida, in esterno in alcuni cartelloni pubblicitari abbandonati in diversi punti di Antofagasta ma, soprattutto, negli spazi dell’antica Molinera del Norte, complesso industriale molitorio, inaugurato nel 1966 per lavorare il grano proveniente dall’Argentina e produrre farina e altri alimenti, chiuso dal 2016 e oggi in fase di recupero grazie al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

Carlo De Meo, «Ombre». Courtesy Bienal Saco

Francisco Medel, «El pescador de suenos». Courtesy Bienal Saco
«Nonostante tutte le complessità, resto attenta a ogni energia che qui emerge. Negli ultimi anni abbiamo visto fiorire il movimento del collage, soprattutto grazie a Francisco Baeza, artista autodidatta con una straordinaria capacità comunicativa. Qui, nella stessa area della Molinera, Baeza ha creato uno spazio accogliente dove persone di tutte le età si sentono al sicuro per poter sperimentare e sostenersi a vicenda: la Escuelita de Collage. È uno spazio comune, sociale e al tempo stesso artistico. È per questo che quest’anno gli ho proposto di collaborare: abbiamo selezionato cinque artisti locali e per due-tre mesi abbiamo lavorato insieme a una curatela pedagogica, un processo per portare le opere al massimo livello possibile per poter essere presentate in una Biennale internazionale, superando il medium, espandendolo, sperimentando nuovi materiali, concettualizzando. Questo è ciò che mi rende più felice: avere da un lato artisti arrivati da luoghi lontanissimi come il Canada, l’Italia o la Turchia, e dall’altro una forte presenza locale», continua Dagmara Wyskiel.
Ma come ogni Biennale d’arte contemporanea internazionale, appunto, anche Saco fa i conti con le aspettative di un «sistema dell’arte» sempre più omologante, sempre più stringente e che vuole porsi su prospettive planetarie: «Questa Biennale è molto diversa, e questa è in qualche modo una mia scelta. Diversi curatori mi hanno scritto che dovrei abbassare la tensione, semplificare, già che la relazione con il pubblico qui è più complessa che altrove. Ma è proprio a questo pubblico locale, meraviglioso, che negli ultimi anni si è innamorato dell’arte contemporanea in modo incredibile, che io penso. Questa “diversità”, che può apparire straniante, mi conferma che la strada intrapresa è quella giusta, perché significa che riuscirò a coinvolgere e ad affascinare sempre più persone. Creare una mostra omogenea tanto filosoficamente quanto formalmente, qui non serve a nulla».
È tagliente nelle sue dichiarazioni, Dagmara Wyskiel, secca come la luce del deserto che dall’alba al tramonto ti costringe ad affilare lo sguardo per riuscire a comprendere l’infinito intorno, per misurare distanze, per tentare di abbracciare uno spazio che resta labile, che anziché lasciarsi attraversare è lui stesso che ti attraversa.
«Il problema del mondo dell’arte globale, continua la direttrice, è che ci valutiamo sempre tra di noi, così che l’opinione degli omologhi diventa la questione più importante. Qui, anche se nessuno mi valuta, né in bene né in male, lavoro con profonda consapevolezza del luogo. Ecco che quando arriva un curatore “tradizionale” rimane scioccato per questa composizione totalmente insolita e perché parliamo realmente di estrattivismo, di schiavitù, di abuso, di temi legati al corpo umano, alle materie prime, ai moli latini dai quali partivano i prodotti dello sfruttamento destinati al primo mondo».

Javier del Olmo, «Respirar-Resistir». Courtesy Bienal Saco

Joaquín Fargas, «Futuros Especulativos», Fundación Minera Escondida. Courtesy Bienal Saco
E Saco ha fatto di un’altra parola abusata e stanca come «resilienza» la sua cifra identitaria e anche stilistica: 800mila dollari, circa, è il finanziamento biennale che la manifestazione ottiene in parte dalla società Escondida Bhp, una delle miniere di rame più grandi al mondo, situata proprio nel deserto di Atacama a due passi da Antofagasta, in parte dal Ministero della Cultura cileno e ovviamente da altri partner «minori», ma non per questo meno importanti. Una contraddizione in termini ricevere fondi dalla maggiore holding promotrice dello sfruttamento materiale locale? Non proprio: come avviene anche in altri territori, come ad esempio in Amazzonia, nemesi dell’arido, è chiara la logica; l’approvvigionamento di risorse, a volte poco etico o inquinante, permette il sostentamento delle esistenze autoctone e non. Ecco che il deserto si rivela ben più del «niente» che appare in superficie, trasformandosi in vita, morte, ricchezza, questione sociale, sanitaria (l’incidenza di cancro è una delle piaghe della città, a causa della contaminazione dell’aria) e territorio di una sublime e disperata poesia.
Scrive Wyskiel nel testo che accompagna questa edizione: «Quasi duecento anni fa, Charles Darwin affermò che nel deserto di Atacama non potesse esistere alcuna forma di vita. Il naturalista tedesco trapiantato in Cile, Rodolfo Philippi, lo confermò qualche anno dopo, decretando il destino minerario di quelle infinite distese rocciose e desolate. Eppure, se i parametri limitanti della vita stabiliti mezzo secolo fa fossero corretti, il processo evolutivo probabilmente non sarebbe mai iniziato. Intere generazioni di scienziati sono state ingannate dalla loro fiducia nei sensi: credevano che ciò che vedevano fosse tutto, che l’esistenza di qualcos’altro, nascosto sotto la superficie, fosse semplicemente impossibile. Solo circa vent’anni fa è emerso l’interesse per la “biosfera oscura”, i microrganismi del sottosuolo che sfidano ogni teoria su ciò che la vita può sopportare. È qui che sono apparsi i poliextremofili, campioni di resistenza, che si trovano a loro agio sulle pareti asettiche delle navicelle spaziali e sono pronti a viaggiare verso Marte, forse per un ipotetico incontro con i loro simili. Proprio loro, plasmati dalle molteplici condizioni estreme dello spazio, sono gli esseri che ci aspettiamo di trovare là fuori».
Un ritratto che calza a pennello all’altra faccia dell’arte, quella che si compie alla Biennale Saco, anche sotto questo aspetto lontanissima dalle logiche speculative (nel senso economico del termine) che appartengono al tradizionale sistema: qui la produzione è site specific nel senso che ogni cosa viene realizzata in situ e nulla resta all’indomani della chiusura della mostra. Ecco la circolarità: «Visitando Biennali, mi capita spesso di imbattermi in un paradosso: opere che parlano di ecologia con grande sensibilità, ma che nella pratica si scontrano con metodi di lavoro tutt’altro che sostenibili. Basta pensare alle tonnellate di rifiuti non riciclabili che dopo ogni edizione abbandonano Venezia sui vaporetti. La verità è che nel nostro settore regna un preoccupante doppio standard: facciamo tutti ottimi discorsi, ma quando si tratta di concretizzare le priorità diventano altre...A Saco abbiamo scelto una strada diversa: niente imballaggi, niente complicazioni doganali, solo materiali reperiti localmente e rigorosamente di recupero», spiega Dagmara Wyskiel, già che le cifre di produzione, tanto per quel che concerne le opere e l’ospitalità degli artisti, anche nelle residenze che la corporazione Saco offre, quanto per il sostentamento dell’intero team sono decisamente inferiori a quelle di altre colleghe latinoamericane come la Biennale di San Paolo, o quella del Mercosul.

Osceola Refetoff, «Remoto/Conectado». Courtesy Bienal Saco

Valentina Cardellino, «Mantén la calma» (particolare). Courtesy Bienal Saco
Così, quando le opere lasciano la scena, smettono di essere arte e tornano a essere semplici materiali, pronte a rinascere in nuove forme: «Recuperiamo con passione da ogni possibile fonte: dalle fiere minerarie che dopo tre giorni smontano e buttano via tutto, ai convegni scientifici che pur dichiarandosi ecologici producono montagne di rifiuti», racconta la direttrice, aprendoci il laboratorio artigianale creato nel grande cortile della Molinera, dove molti artisti sono stati aiutati dalla manodopera locale ad assemblare sculture, installazioni, oggetti, basi e chi più ne ha più ne metta. E si badi bene: «Questo non è un capriccio altezzoso, ma una precisa scelta etica che abbiamo persino pubblicato sul sito della Biennale, come dichiarazione poetica e politica insieme», aggiunge la direttrice.
Saco, insomma, sembra delinearsi come l’altra faccia della luna, il rovescio della medaglia, con l’irriverenza e la perseveranza che appartiene ai progetti eroici e utopici. Ai sogni, forse. Di certo il Cile, sotto questo punto di vista, ha avuto ottimi maestri: Juan Castillo, ad esempio, artista de La Pampa (come viene chiamato un altro tratto di deserto a nord di Antofagasta), Gabriela Mistral, la prima donna a ricevere un Premio Nobel (per la letteratura, nel 1945) e Patricio Guzmán, regista del documentario «Nostalgia de la luz» («Nostalgia della Luce», 2010), ai quali sono intitolati tre dei grandi spazi della Molinera.
Ed è a causa delle immagini del regista, assicura Dagmara Wyskiel, che innumerevoli artisti vogliono esplorare il deserto di Atacama: «È incredibile come un’opera cinematografica abbia generato nel mondo un interesse che ancora non riusciamo a misurare. Forse oggi, senza quel film, avremmo il 30-40% in meno di artisti e ricercatori desiderosi di lavorare su questi territori. Qualcuno all’inizio mi criticava: “Guzmán non è del Nord, ha solo girato qui un documentario! Non dovremmo privilegiare registi locali?”. Ma il punto è un altro: la sua opera ha aperto una porta su queste geografie e sulla loro storia dolorosa come nessun’altra è riuscita a fare. Questo è interessante, non la sua provenienza».
D’altronde, come ha ricordato il Governatore della Regione di Antofagasta, Ricardo Díaz, durante il suo intervento in apertura alla Biennale: «È stato necessario lo sguardo degli artisti per salvare la Molinera; questa regione ha propriamente bisogno di questo: di trascendere, di smetterla di essere intrappolata in una mentalità di sfruttamento e aprirsi a uno sguardo più umano, che permetta l’incontro, la relazione; per far sì che il tempo si trasformi in storia e che le storie abbiano un senso, oltre lo spazio». È politica, certo, ma è anche poetica.