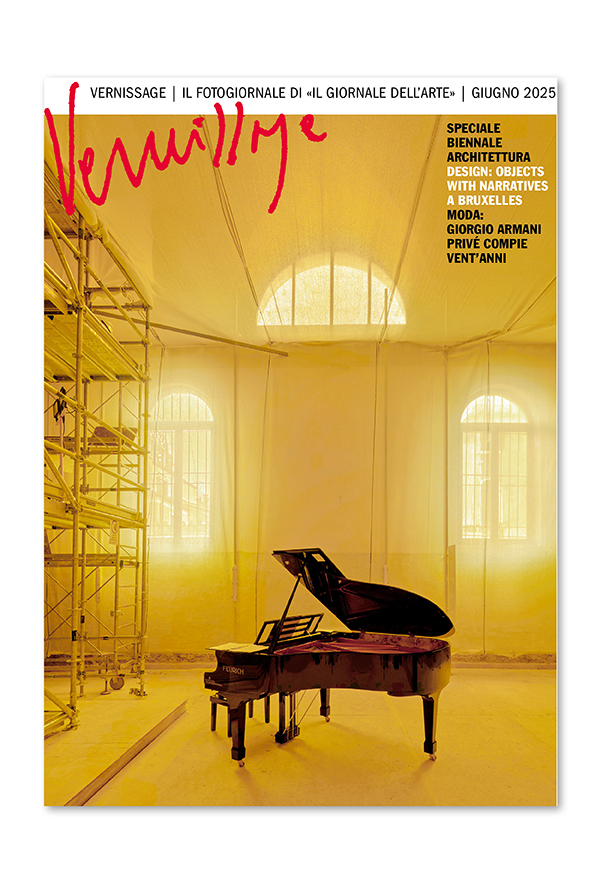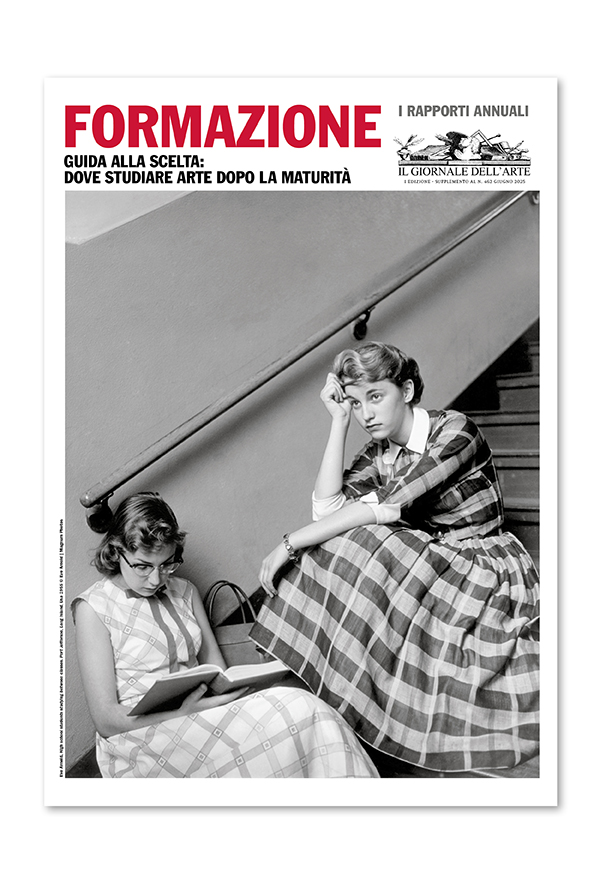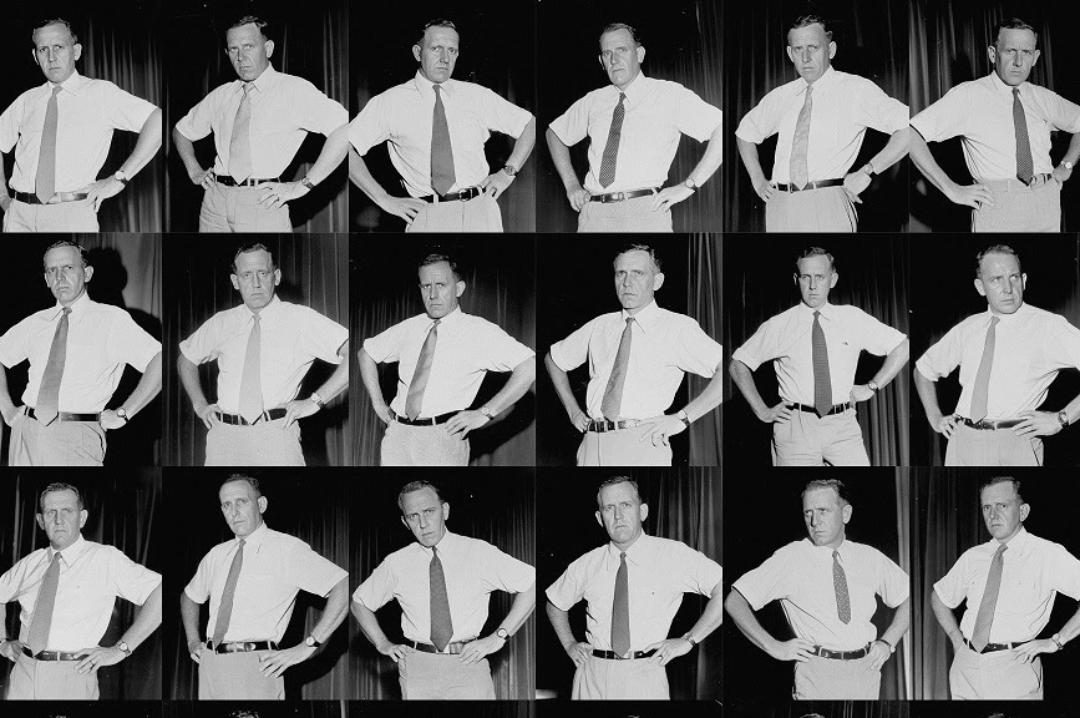Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Guglielmo Gigliotti
Leggi i suoi articoliL’offerta digitale delle istituzioni culturali italiane durante il lockdown non supera l’esame degli esperti. Con poche eccezioni, come il Museo Egizio di Torino, il Castello di Rivoli, Palazzo Strozzi a Firenze, il MaXXI a Roma, la Gamec di Bergamo, il Muse di Trento, la Pinacoteca di Brera e il Museo della Scienza a Milano.
Di questo avviso sono Maria Elena Colombo (nella foto in alto; ha da poco pubblicato Musei e cultura digitale, Editrice Bibliografica) e Nicolette Mandarano (nella foto in basso; autrice di Musei e media digitali, Carocci 2019). Sono entrambe professioniste della comunicazione digitale del patrimonio culturale, docenti di corsi universitari sul tema, con esperienze lavorative nelle istituzioni.
Si è reagito al silenzio con «troppo rumore di fondo» asseriscono all’unisono. Monologhi troppo lunghi, talvolta autoreferenziali, dei direttori, video improvvisati senza avere la strumentazione adatta (e senza postproduzione), foto di bassa qualità, spiegazioni poco limpide. Ma soprattutto ipercomunicazione. «Alcuni hanno attivato contributi quattro volte al giorno, dichiara Maria Elena Colombo, mentre ne bastavano due a settimana, ma ben fatti». «La comunicazione, secondo Nicolette Mandarano, deve essere veloce ed efficace, basata su un linguaggio mirato, che non significa abbassare il livello, ma divulgare con consapevolezza, e soprattutto saper raccontare storie».
La Mandarano svolge anche mansione di digital media curator per le Gallerie nazionali d’arte antica, Palazzo Barberini e Galleria Corsini, a Roma. Per lei, le regole per una giusta veicolazione di contenuti culturali in chiave multimediale, dai canali social ai siti web, sono poche ma fondamentali: «Per prima cosa, ci vuole la creazione di contenuti adeguati, sulla base di una perfetta conoscenza storica dell’istituzione per cui si opera, e in coordinamento con la direzione e lo staff. Poi bisogna conoscere bene gli strumenti digitali con cui si intende veicolare tali contenuti. E infine deve essere elaborato un piano editoriale, che implichi una visione a monte e un progetto operativo. Tutte cose che non si improvvisano. Durante il lockdown, la premura di riempire vuoti ha portato in evidenza la mancanza, per la maggior parte delle istituzioni italiane, sia di una strategia digitale sia di adeguate professionalità».
Per Maria Elena Colombo la formazione di specifiche competenze in questo settore deve iniziare dalle università, in Italia non sempre pronte ad accogliere queste nuove figure di operatori culturali del digitale. Bisogna creare una mentalità adeguata e iniziare a sgomberare il campo dai preconcetti: «Il visitatore fisico e il visitatore digitale creano un’unica realtà organica e costituiscono l’ecosistema osmotico della moderna fruizione dei beni culturali. Bisogna essere pronti a dare voce all’orizzontalità, perché si desidera quello che si conosce, e lo specialismo non aiuta l’inclusione democratica e l’accessibilità, ché altrimenti sarebbe come scoprire l’aspirina senza commercializzarla. Evitando fallimenti comunicativi come il video messo dagli Uffizi su TikTok, bisogna guardare al comportamento virtuoso, per esempio, di Carolyn Christov-Bagarkiev, direttrice del Castello di Rivoli, che ha accompagnato iniziative online esplicitando che il web è una sede tout court e che quindi, durante il lockdown, il museo era da considerarsi aperto».
Gli strumenti devono adeguarsi ai mutamenti della società, per una relazione più serrata. Per entrambe le studiose ciò comporta anche una presa di posizione etica e civile. L’uccisione di George Floyd a Minneapolis, per esempio, ha suscitato sui canali social di quasi tutti i maggiori musei americani interventi in chiave antirazzista. «In Italia hanno risposto ben poche istituzioni, dice Maria Elena Colombo, ma la missione sociale di un museo è anche politica, perché un museo non è mai neutrale, a iniziare dalle scelte culturali che opera».
Nicolette Mandarano ha diretta esperienza a riguardo: in accordo con Flaminia Gennari Santori, direttrice delle Gallerie Barberini e Corsini, in occasioni di tipo celebrativo ha pubblicato sui canali social dei due musei contenuti dagli impliciti risvolti storico politici. «Bisogna essere capaci di gestire tutto quello che può derivare da una scelta simile, spiega la digital media curator, a iniziare da risposte non concordi con ciò che si propone. È un’assunzione di responsabilità che comporta anche la moderazione di eventuali dibattiti, e il dialogo con opinioni avverse. Spesso, queste, nascondono elementi interessanti, se non parti di verità».

Uno dei progetti più significativi durante la quarantena: «Cosmo Digitale» del Castello di Rivoli. Cortesia Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
Altri articoli dell'autore
Aperto alle visite fino al 28 dicembre, Palazzo San Felice sarà sede della Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte su progetto dell’archistar svizzero
54 artisti, viventi, di cui 16 under 35 e 45 alla prima partecipazioni, 187 opere su circa 2.000 metri quadri espositivi, con un’alta percentuale di produzioni site specific. Tutti i numeri di Fantastica, la 18ma Quadriennale d’arte, annunciati oggi a Roma
La mostra alla Galleria Borghese si presenta come un poema in cui l’artista afroamericana ha puntato più sul nascondimento delle opere che sulla loro rivelazione evidente
Il Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma festeggia con cinque mostre che spaziano da Douglas Gordon a Nacho Carbonell, dagli stadi alla Galleria Pieroni