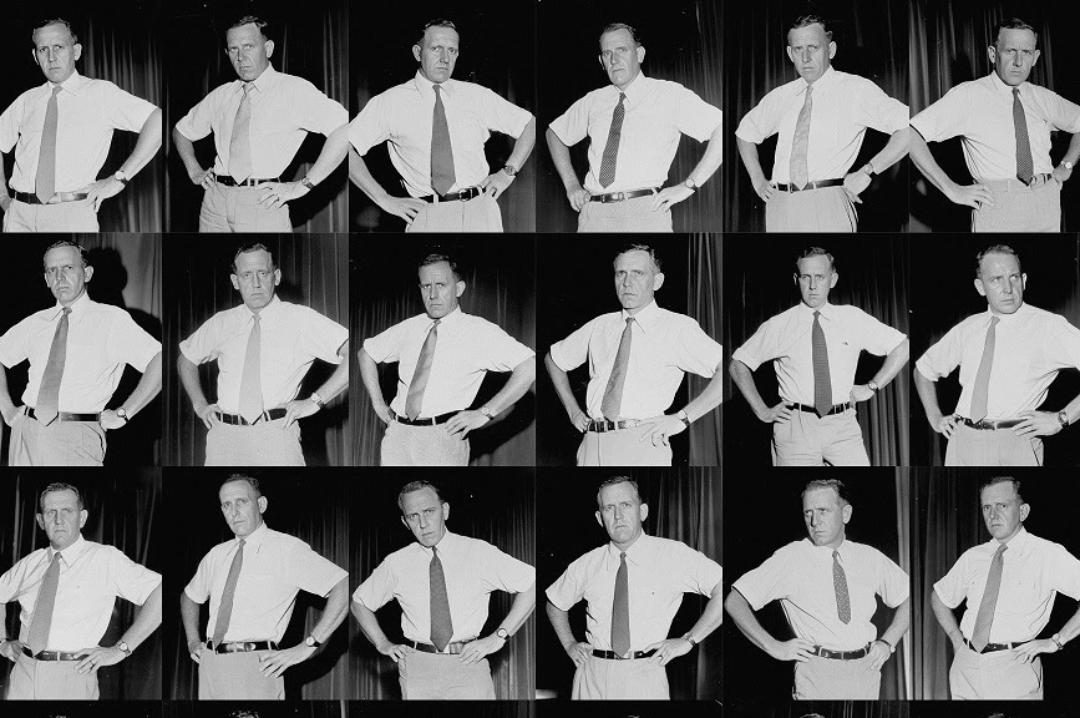Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Andrea Tinterri
Leggi i suoi articoliUn bunker ha le fattezze di un cranio, ha feritoie simili a occhi e rimane bloccato a fissare l’orizzonte, come fosse una forma di contrappasso per la sua staticità bellica. Giovanni Ozzola (Firenze, 1982) fotografa dall’interno della struttura in cemento armato, ormai ricoperta di graffiti, di tracce scritte che testimoniano passaggi e continue risignificazioni. Ma è su quell’orizzonte marino che la ricerca indugia, come nel progetto «Scars-towards ourselves» in cui sull’ardesia vengono impresse le rotte di millenni di esplorazioni, o ancora in «Dust on memories», dove le campane di navi dismesse rintracciano memorie da riattivare o reinterpretare.
Ed è il segno, testimonianza parietale anonima, a interessare l’artista, quel sovrapporsi di passaggi (scrittura, pittura, graffi) che inspessiscono e impressionano la superficie caricandola di memoria spesso indecifrabile, ma comunque degna di cura e protezione, come fosse un dono di cui ignoriamo il mittente. Così nascono «South wall» e «No solidity in a state of vibration», calchi siliconici che vogliono preservare quella grammatica impossibile, quell’equilibrio casuale, inaspettato e intrinsecamente fragile.
Facciamo una chiacchierata con Giovanni Ozzola, che a ottobre sarà alla Quadriennale di Roma nella sezione «Il tempo delle immagini. Immagini fuori controllo?» a cura di Emanuela Mazzonis di Pralafera (espongono con lui Eleonora Agostini, Jacopo Benassi, Andrea Camiolo, Irene Fenara, Linda Fregni Nagler, Teresa Giannico, Massimo Grimaldi, Francesco Jodice, Giulia Parlato e Davide Tranchina), per approfondire la sintassi del suo lavoro, stratificazioni temporali che emergono dalla superficie parietale.
Nella sua ricerca, a partire dal progetto «Dust on memories» (2013), ritornano spesso le campane nautiche ossia quei fari sonori che le navi di grandi dimensioni devono avere a bordo durante la navigazione. Oggetti superstiti del mare su cui lei scrive incidendo sul metallo. Perché tale affezione? E come ricodifica la storia di questi strumenti sonori?
Nel mio lavoro l’oggetto è qualcosa che per via di sue specifiche caratteristiche formali riemerge dall’inconscio carico di nuovi significati. È ormai dal 2006 che colleziono campane nautiche. A spingermi verso questo genere di oggetti è in primis il fascino su di me esercitato da qualcosa che per lunghi anni ha viaggiato divenendo testimone delle storie della navigazione e dei suoi protagonisti, ma ancor più attraente è proprio il concetto di faro sonoro. La campana è faro sonoro nel suo affermare la propria posizione attraverso il suono, un tono unico. Queste specificità fisiche mi hanno portato a considerare la campana come evocativa di alcuni aspetti tipicamente umani, ed è per questo motivo che tale oggetto mi torna in mente nell’ambito dell’elaborazione di opere che indagano la mia idea di umanità e comunità. L’essere umano possiede, per l’intera durata del viaggio che è la propria vita, quel bagaglio contenente le personali esperienze e modi di essere, la cui somma va a costituire quello che anche in questo caso si può definire come tono unico, ovvero un’irripetibile individualità. Inoltre, la campana, con il suo portare con sé un nome, una data (quella del varo della propria nave) e sul corpo i segni di un’esperienza lunga interi decenni, diviene ancora più visibilmente simbolo dell’esperienza umana. Se nel caso di «Dust on memories» (2013) questa corrispondenza mi ha portato a incidere sul corpo delle campane delle frasi per me significative, pensieri che ho letto o udito e che da allora non mi hanno mai abbandonato, per quanto riguarda «Atto unico-campane» (2024), il tono unico della campana mi ha fatto pensare all’armonia nuova e unica che può nascere dal sincero incontro con l’altro, dal trovarsi sul medesimo orizzonte.
L’esplorazione e il viaggio fisico e esistenziale rimangono le direttrici del recente lavoro «Scars-towards ourselves» (2012). Sessanta pannelli in ardesia su cui ha inciso le rotte di esploratori che hanno navigato tra il 3000 a.C. e il 1926 d.C. Il risultato è una mappa che ricostruisce l’endemica necessità di esplorare l’ignoto e forse l’impossibilità di imporre confini politici entro cui limitare le migrazioni. Sembra ci sia una doppia pulsione, quella del singolo esploratore e quella di una comunità intera che lentamente emerge dalla pietra. Come convivono queste due istanze?
«Scars-towards ourselves» nasce da un libro, Il cammino dell’uomo (1947) di Martin Buber. Un testo importante che parla di cercarsi senza prendersi come fine. Ho collezionato per due anni tutte le rotte di tutti gli esploratori che hanno viaggiato verso l’ignoto. Questo bisogno di viaggiare verso l’orizzonte, simbolo potente di un luogo che mai raggiungeremo, è una necessita trasversale a tutti i tempi e latitudini. È stato un grande lavoro di ricerca, volevo che queste rotte fossero le più precise possibili e che includessero i cimenti di persone e individui di tutte le culture ed etnie. Volevo che fosse parte del lavoro chiunque avesse fronteggiato l’ignoto e di cui l’umanità serba memoria. Per questo parlo di una mappa dell’umanità. Tutto questo materiale poi è stato sovrapposto ai punti geografici, a isole, capi, stretti, e infine incise su ardesia, che è una pietra sedimentaria, come la memoria. Ho inciso l’ardesia con una punta metallica, come in una incisione rupestre: le linee bianche sono esito di un graffio nella pietra. La tecnica ha un valore importante nella realizzazione. La necessita di marcare il nostro individuale passaggio sulla terra è un dato ancestrale, che va direttamente dalla cultura di Cromagnon sino a chi oggi lascia la sua «tag» con la propria bomboletta spray. Il risultato è una grande mappa dell’umanità e di come ci siamo mossi per scoprire e mappare l’ignoto. La geografia è totalmente assente ma emerge proprio grazie alla sua assenza. Ciò che mi interessa non è l’aspetto di una qualche presunta conquista, ma piuttosto indagare l’origine e le conseguenze della necessità che alcuni di noi hanno di affrontare le proprie paure e viaggiare verso orizzonti che non conoscono. Chi ha compiuto questo percorso ha inciso una cicatrice nel nostro inconscio collettivo. Se camminiamo su questo pianeta così sicuri è perché qualcuno ha fronteggiato le proprie paure e scoperto luoghi di cui non vi era conoscenza pregressa. Si tratta di individui che compiendo un passo in avanti per sé stessi, in realtà hanno mosso l’anima mundi, creano e modellando simboli che danno identità al nostro inconscio collettivo. Credo che questo mio lavoro parli della responsabilità del singolo e dell’umanità.

Giovanni Ozzola, «Senza titolo. Madrugada»
ARTICOLI CORRELATI
Nei lavori «South wall» (2018) e «No solidity in a state of vibration» (2019) lei crea dei calchi siliconici di pareti vissute dal tempo, con graffiti, graffi, tracce di passaggi generazionali. Che cosa le interessa di queste storie anonime aggrappate al muro?
A interessarmi è la tendenza dell’essere umano a lasciare traccia di sé. Questa particolare inclinazione può realizzarsi nel lasciare il segno della propria esistenza nella coscienza dei propri simili, sia condividendo con essi qualcosa di proprio e individuale, che compiendo gesti significativi per sé stessi destinati a riflettersi su grandi gruppi comunitari, ma ne esistono anche esempi più semplici e concreti. Mi riferisco a quelle tracce fisiche lasciate dall’uomo a testimoniare il proprio passaggio nell’ambiente, che dalla natura invasiva e istintuale, spesso sotto forma di simboli, iniziali, casuali composizioni astratte e brevi frasi incise sulle pareti di ogni epoca e ogni dove, con la loro massiccia presenza sembrano suggerire il comportamento umano del lasciare traccia di sé come un autentico bisogno. Tale aspetto della questione, che mi ha portato a operare degli strappi d’affresco, calchi siliconici che mi permettono di raccogliere e osservare l’immagine di pareti pesantemente segnate. A posteriori, il contatto con questi segni mi fa pensare alla parete come a una superficie sensibile in grado di restituire l’immagine della forza che l’ha impressionata, ovvero l’energia di tutti coloro che anche solo per un momento hanno abitato il suo spazio e così facendo hanno lasciato un’immagine latente di loro stessi nel luogo. Questo è indubbiamente il mio lavoro più fotografico. Una vera e propria stampa a contatto.
La fotografia è uno dei linguaggi che lei esplora più frequentemente. In molte immagini, come «Camera rossa» (2003), «Stanza vuota con luce» (2011), «Wiesbaden, primavera» (2007), «Red curtain» (2021), la luce assume un carattere pervasivo, come se fosse una presenza autonoma.
Nomina delle immagini che mi portano alla mente il desiderio, in qualche modo istintivo, di voler dare corpo a una esperienza, penso a «Camera rossa» (2003): credo che parlare di pervasività sia giusto, in effetti l’immagine sembra essere pervasa da una forza, quella folgorazione di cui parlavo, che silenziosa si è ormai insinuata nell’ambiente. Questa presenza, invadente, sembra nascere dalla calda luce colorata che anima la stanza e che crea quell’atmosfera di cui l’immagine si compone totalmente. Per me queste sono immagini che non si limitano a rappresentare: sono, in sé, una presenza fisica e sensibile, capace di testimoniare i meccanismi silenziosi dell’esistenza, diventando corpo e respiro del pensiero. L’immagine «non rappresenta, è».
Nella sua produzione fotografica ricorre spesso la restituzione dell’orizzonte, quasi sempre il limite tra cielo e mare, ripreso dall’interno di luoghi abbandonati sulle cui pareti campeggiano graffiti a testimoniare una presenza. Che rapporto intercorre tra interno ed esterno, tra la persistenza dello sguardo e l’intenzionalità della fuga?
Le immagini tratte dal bunker ritraggono una realtà contrastante, composta dalla buia pesantezza del cemento, dalle numerose e luminose aperture sull’oceano e dal rumore visivo della vernice spray. A contatto con una tale visione, con l’occhio rivolto verso l’ambiente naturale, la mia impressione è quella di ricevere un invito a uscire dalla mia scatola cranica, visivamente rappresentata dall’angustia dello spazio interno, i cui segni, incisioni e graffiti caoticamente sparsi sulle pareti, si fanno simbolo di pensieri disordinati e incessantemente rumorosi, ma interrotti proprio dalla possibilità di fuggire offerta dall’apertura centrale nell’immagine. Questo desiderio di volersi liberare della propria individualità, porta all’orizzonte, meta irraggiungibile dove rendersi indistinti, non più soli nell’immensità. Quando si raggiunge quella condizione abbiamo una vertigine, l’infinito. La nostra struttura è persa e ci troviamo come sospesi, allora, in quel preciso momento, il bunker, il tuo rumore, la tua scatola cranica, le tue cicatrici e rughe tornano a proteggerti, a darti una forma, a costituirti. Interno ed esterno, non ha giudizio di valore, in entrambi i casi le condizioni ambientali conducono a un’esperienza con te stesso, esperienza attraversabile bilateralmente e per quanto mi riguarda trasformatasi in oggetto del desiderio, una forza che mi spinge a tornare al bunker, cortina che tocca due orizzonti, interno ed esterno.

Giovanni Ozzola, «Senza titolo. Carambola»
Altri articoli dell'autore
Oggi i linguaggi si mescolano dando luogo a forme ibride che superano la fotografia tradizionale: non più memoria e archivio, bensì un ecosistema visivo liquido e immateriale
Dalla fabbrica di Hein Gorny all’archivio Candy, la fotografia osserva il lavoro come forma di pensiero, tra meccanica e umanità. Il confine tra ricerca e committenza visto dall’artista
Dai graffiti alla tela, al vetro: SpazioC21 di Reggio Emilia presenta la prima personale in Italia di EGS
In arrivo a ottobre, alle Gallerie d’Italia di Torino, una grande mostra del fotografo canadese curata da David Campany che ne ripercorre la ricerca dagli anni ’70 a oggi