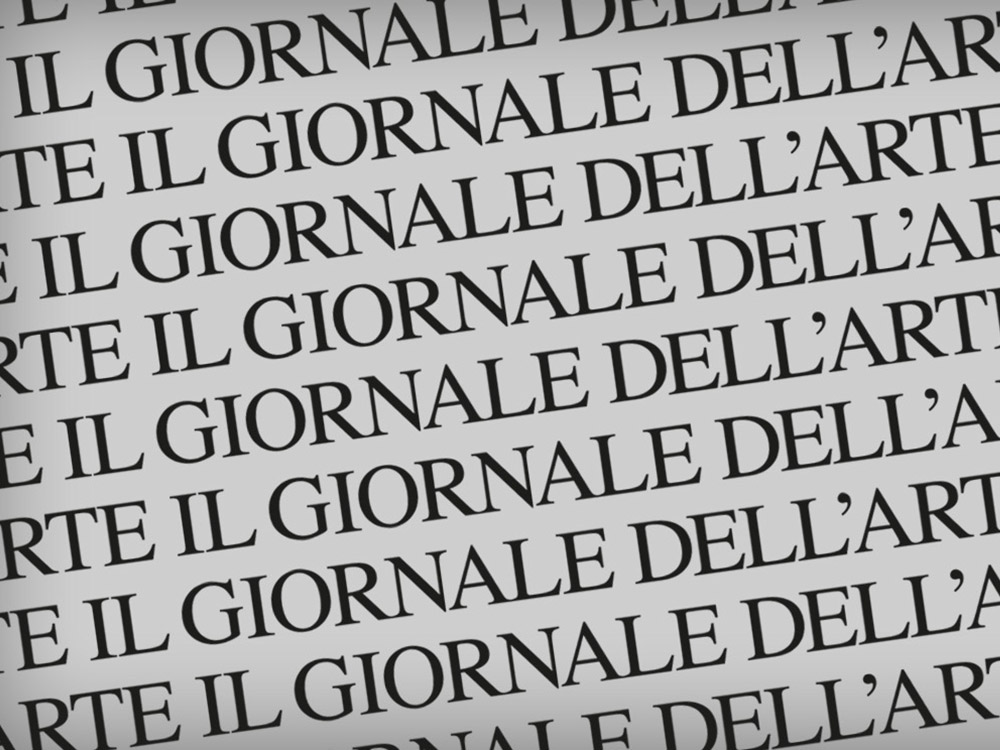Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Laura Lombardi
Leggi i suoi articoliIl 4 novembre 1966, all’alba, l’Arno ruppe gli argini. L’ultima alluvione era avvenuta nel 1844 e i fiorentini si erano dimenticati del pericolo rappresentato dal loro fiume. I danni alla città furono terribili, specie nella zona di Santa Croce, più bassa rispetto al fiume. Gli occhi di tutto il mondo, pur in un’epoca senza internet, furono puntati sulla città culla del Rinascimento e proprio la catastrofe diede forte impulso agli studi e ai restauri: opere come il «Crocifisso» di Cimabue (restaurato, sotto la guida di Umberto Baldini, nei Laboratori della Fortezza allestiti per l’urgenza dal Gabinetto di Restauro della Soprintendenza fondato da Ugo Procacci anni prima), divennero emblema di un faticoso risorgere che non cancellava, secondo le teorie sul restauro di Cesare Brandi (escludendo quindi il feticismo del frammento), la memoria dei traumi subiti.
Ma a che punto è Firenze a cinquant’anni dall’alluvione? Per la ricorrenza la città si presenta con «Toscana Firenze 2016», un ampio progetto, suddiviso in diverse aree (scientifica, della Protezione civile, società e internazionale, infrastrutture territorio e ambiente, restauro, educazione) affidate a diversi comitati, la cui attività è ampiamente documentata in un sito in continuo aggiornamento (toscana.firenze2016.it), che informa il cittadino sullo stato dei lavori idrogeologici, sui restauri delle opere d’arte, nonché sul ricco calendario di mostre, convegni, rassegne di film e spettacoli di teatro, celebrazioni e cerimonie di ringraziamento ai Paesi che offrirono aiuti e, in particolare, agli Angeli del fango, gli eroi fiorentini, italiani o venuti da ogni parte del mondo. Ma la parte più rilevante di questo progetto, avviato tre anni fa grazie all’iniziativa di Giorgio Federici, professore ordinario di Ingegneria civile e ambientale all’Università di Firenze e segretario del Comitato Firenze 2016, è stata quella di creare per la prima volta un organo di confronto internazionale per valutare quanto già fatto, o non fatto, riguardo alla riduzione della vulnerabilità: l’Itsc, International Technical Scientific Committee. Composto da un pool di esperti internazionali, l’Itsc ha offerto del tutto gratuitamente le proprie competenze, presentando il suo «Rapporto finale» all’Accademia dei Lincei a Roma, nel convegno «Florence 1966-2016. Resilience of art cities to natural catastrophes: the role of Academies» (11-13 ottobre), con la partecipazione delle maggiori Accademie delle Scienze mondiali. Quanto emerge è purtroppo che la città è ancora a rischio. «Ci siamo resi conto, spiega Federici, di come, diversamente da quanto avvenuto nel campo dei beni storico artistici che dall’alluvione ha tratto la spinta per compiere notevoli passi avanti, ci sia stato invece, rispetto ai rischi idrogeologici, un fenomeno preoccupante di “rimozione”: il rischio insomma è stato molto sottovalutato. Grazie al ruolo svolto da Italia Sicura, negli ultimi due anni il Governo si è molto sensibilizzato, stanziando finanziamenti che speriamo non siano rallentati dalla burocrazia, e sono state prese iniziative notevoli, come la cassa di espansione a monte di Firenze che è stata appena completata, ma molto rimane da fare. Antonio Paolucci vent’anni fa ci ammoniva: “Noi abbiamo messo in sicurezza tutto, ma Firenze non è sicura”. Perché il fatto è proprio questo: Firenze è un bene culturale nel suo insieme e anche gli stranieri del Comitato sono molto preoccupati nel trovare così impreparati al rischio noi, custodi di un patrimonio che è anche loro. Venezia ha avuto negli ultimi anni stanziamenti dal Governo per circa 10-11 miliardi di euro, la cui metà circa è proprio andata al risanamento della laguna. Qui a Firenze dobbiamo recuperare questo grave ritardo».
Uno dei grandi quesiti intorno a cui ruotano le iniziative è: come reagirebbero oggi Firenze, l’Italia, il mondo di fronte a un simile evento? «Nelle stesse condizioni metereologiche oggi l’alluvione rischierebbe di essere di gravità anche maggiore, dato l’aumento delle costruzioni in aree allora disabitate», precisa Federici. Va tuttavia dissociato dal problema rischio alluvione lo sprofondamento improvviso di alcune centinaia di metri sul Lungarno Torrigiani (proprio sul lato opposto rispetto agli Uffizi) avvenuto pochi mesi orsono, a causa della rottura di un tubo dell’acqua: «Ogni tanto, purtroppo, i muri vecchi crollano, annota Federici, anche lontano dall’acqua, e questo non va confuso con quanto riguarda l’Arno».
Se dunque molto resta ancora da fare per mettere in sicurezza Firenze, un fiore all’occhiello è rappresentato proprio da quanto realizzato nel settore dei beni artistici e librari. «Un grande disastro è stato poi occasione di crescita e di sviluppo sotto tutti i punti di vista, e si è creata da allora un’unione molto forte tra il restauro e il mondo della scienza, tuttora esistente e in continuo sviluppo, spiega Marco Ciatti, soprintendente dell’Opificio delle Pietre Dure. Grazie a un imponente lavoro strutturale e istituzionale svolto dal ministro Giovanni Spadolini insieme a Umberto Baldini, il Gabinetto di Restauro della Soprintendenza fu unito allo storico Opificio delle Pietre Dure fondando nel 1975 un istituto nazionale di ricerca che si trovò a essere prestissimo un riferimento di eccellenza e fece di Firenze la capitale del restauro nel mondo».
Tra i molti beni che in questi 50 anni sono transitati dall’Opificio e vi sono rimasti a lungo (3.500 opere, ora tutte inventariate in un archivio digitale), l’«Ultima Cena» di Vasari era il malato più grave. La sua rinascita è celebrata con l’esposizione dell’opera al Museo di Santa Croce il 3 novembre, iniziativa svolta in collaborazione con il museo stesso e con i due sponsor, la Getty Foundation e Prada. Il grande dipinto di Vasari, rimasto a lungo immerso nell’acqua e nel fango, era stato all’epoca protetto da una velinatura a Paraloid B72 per evitare cadute di colore, ma questa funzione aveva avuto l’effetto di fissare sulla superficie anche lo sporco depositato; inoltre, nonostante la tavola fosse stata fatta asciugare molto lentamente, le deformazioni del supporto e il degrado degli strati della preparazione avevano prodotto danni ritenuti insanabili. Lasciata a lungo nei depositi della Soprintendenza, la tavola era giunta nel 2005 nei Laboratori di restauro dell’Opificio, dove la fase diagnostica, conoscitiva e progettuale si era conclusa nel 2006.
Le mostre Fulcro delle celebrazioni promosse dal Comitato è «Firenze 1966-2016. La bellezza salvata» a cura di Cristina Acidini con Elena Capretti a Palazzo Medici Riccardi (una scelta simbolica di sede perché il Museo mediceo al piano terreno fu devastato dall’alluvione). La mostra, che vede la partecipazione delle principali istituzioni culturali di Firenze, ha rischiato di non aprirsi a causa di insufficienza dei fondi, ma ora è «salva»: a organizzarla è l’Associazione MetaMorfosi, con il fondamentale contributo della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e del Comune di Firenze, ma la data di inaugurazione slitta al 30 novembre (fino al 26 marzo). Pur nel carattere documentario della mostra, con fotografie e filmati di allora e notizie sullo stato odierno delle cose, clou dell'esposizione è una selezione di dipinti su tela e tavola, sculture, libri, documenti, oggetti d’arte applicata, strumenti musicali e scientifici, accompagnati da fotografie storiche che documentano i danni e gli interventi di recupero. Alcune opere portano talvolta ancora su di sé i segni del fango, sebbene i capolavori offesi siano già stati perlopiù curati. Si va dalla «Mater Matuta» del Museo Archeologico al grande arazzo di Michelangelo Cinganelli (1617) delle Gallerie degli Uffizi e sculture che erano al pian terreno; il Bargello presenta pezzi dell’Armeria, alcuni inediti, ma sono anche presenti musei meno noti quali il Cenacolo di San Salvi, il Museo Bardini e il Museo Horne. Il «Crocifisso» di Cimbaue e il complesso del Duomo e del Battistero, con le sue porte bronzee sventrate e la «Maddalena» di Donatello oltraggiata, sono invece evocati per immagini. Tessuti e oggetti liturgici provengono dalla Comunità ebraica, insieme a dipinti, sculture e arredi ecclesiastici delle chiese fiorentine e del territorio: tra queste spicca la «Sacra Conversazione» di Francesco Botticini da Sant’Andrea a San Donnino (Campi).
L’alluvione ricoprì, a Santa Croce, anche il sepolcro di Michelangelo, che incarna l’apice della forma artistica che l’Accademia delle Arti del Disegno, fondata da Vasari, rappresenta fin dal 1563: l’interrogativo su come un evento così grande possa aver influito sulla cultura e sulla creazione artistica di quel periodo è posto dalla mostra qui allestita, «Da Cimabue in qua» (4 novembre-23 dicembre), a cura di Cristina Acidini, Giulia Coco ed Enrico Sartori dove, in un allestimento di grande effetto emotivo creato da David Palterer e Vincenzo Medardi, il disastro è raccontato nei modi e con i segni grafici più disparati da artisti quali Luciano Guarnieri e Piero Tredici, Fernando Farulli e Paolo Frosecchi.
Prossimi all’Arno e quindi molto colpiti all’epoca sono anche il Museo Galileo e la Fondazione Scienza e Tecnica, dove si tiene la mostra «Pescare nel fango. Il Museo e l’alluvione» (fino al 20 novembre) dedicata agli strumenti scientifici restaurati insieme ad altri materiali messi a disposizione dall’Università di Firenze illustrando l’impegno che ha coinvolto fisici, matematici, ingegneri anche all’estero. All’Archivio di Stato troviamo invece «Arno: fonte di prosperità, fonte di distruzione. Storia del fiume e del territorio nelle carte d’archivio» (fino al 4 febbraio ) e la mostra sul restauro dei libri alluvionati dal Fondo Ebraico, a cura della Fondazione Beni Culturali Ebraici in Italia e della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Infine alla sala d’Arme di Palazzo Vecchio dal primo al 13 novembre la mostra «Alfabeti sommersi», a cura di Marco Bazzini e Sergio Risaliti con opere di Emilio Isgrò e Anselm Kiefer, dedicata al tema del libro, grande vittima dell’alluvione, che nelle loro opere diviene elemento pittorico e scultoreo. Isgrò (che nella città devastata fu presente come inviato del «Gazzettino di Venezia») presenta qui un nuovo lavoro, dove le pagine della Vita di Cimabue nelle Vite di Vasari sono cancellate: un duplice riferimento alle cancellature operate dalle acque sui libri della Biblioteca Nazionale e sul Crocifisso di Cimabue in Santa Croce.
Altri articoli dell'autore
Inaugurato il tratto sul Ponte Vecchio con i ritratti di età imperiale, finora conservati nei depositi, in continuità con i marmi di Palazzo Pitti
Nel cinquantenario della sua fondazione, l’istituzione gli ha intitolato la sala dedicata all’esposizione del suo patrimonio storico
La Cappella fa parte del Complesso di Santa Maria Maddalena dei Pazzi nella cui chiesa, all’epoca dei Cistercensi, le donne erano ammesse soltanto due volte l’anno
Il moderno Opd, erede dell’omonima manifattura granducale di fine Cinquecento, compie 50 anni. La Cappella Bardi in Santa Croce è l’ultimo di una serie di restauri capitali condotti dall’istituzione attualmente diretta da Emanuela Daffra che illustra difficoltà ed eccellenze