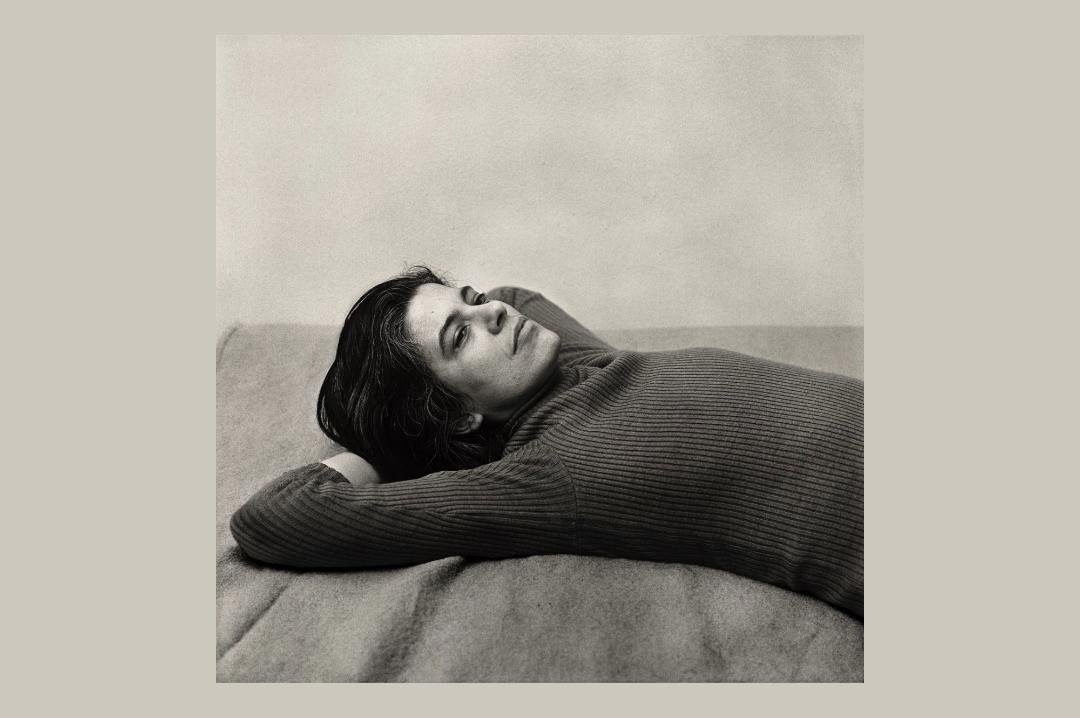Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Rica Cerbarano
Leggi i suoi articoliNel 1984 Fred Ritchin scrisse sul «New York Times» che da lì a poco non saremmo stati in grado di distinguere se un’immagine fosse documentaria o di finzione senza interpellarne l’autore. Oggi, questa riflessione è più attuale che mai, ma spesso è l’esistenza dell’autore stesso a venire messa in dubbio. Le intelligenze artificiali si basano infatti sulla capacità di auto-rigenerarsi: se da una parte il prompt umano è solo uno di una serie di input e processi che sono in grado di procedere in autonomia, svincolandosi dal controllo dell’uomo, dall’altra la circolazione delle immagini IA sul web sfugge a qualsiasi logica di previsione.
Se a questo aggiungiamo la constatazione che il 2024 è stato l’anno in cui l’IA ha sfondato le barriere della politica, diventando a tutti gli effetti uno strumento propagandistico, è facile comprendere come discutere del suo impatto non sia più una questione prettamente artistica (se mai lo è stata), ma un’urgenza sociale che ci coinvolge tutti.
Nelle mani dei governi e dei partiti estremisti, l’IA sta acquisendo un ruolo preminente nella trasmissione di immagini che diffondono non solo disinformazione e fake news, ma anche contenuti visuali talmente assurdi da sembrare inoffensivi. Ed è questo il problema. C’è una parola per questo fenomeno ed è «slop», letteralmente «sbobba, fanghiglia». Indica contenuti di bassa qualità generati dall’IA, come immagini, video, notizie, risultati dei motori di ricerca e interi siti creati per attirare clic.
I suoi tropi sono sempre gli stessi: religiosi (Gesù che abbraccia animali, persone, oggetti; Gesù-gambero in varie forme e declinazioni, Gesù come combattente); patriottici (veterani che tornano a casa, bandiere sventolanti); emotivi (anziani che piangono da soli, nonne che preparano torte, bambini alle prese con costruzioni improbabili).
L’estetica slop
Ma l’estetica slop non si ferma a rappresentazioni più o meno fotorealistiche che in alcuni casi potrebbero essere considerate contenuti «innocenti», alla stregua dei meme (che poi, anche questi, innocenti non sono).
Si tratta ormai di un fatto politico, un’arma nelle mani della propaganda, a livello globale. Difficile dimenticare le immagini antitrans e islamofobe diffuse dalla Lega nel maggio 2024 (un uomo incinto con la barba, uomini in abiti arabi tradizionali che bruciano la Divina Commedia), e quelle comparse sull’account del ministro Salvini con donne e bambini che mangiano insetti, richiamando la teoria del complotto sulla presunta imposizione di cibo a base di insetti da parte dell’Ue. Senza dubbio non c’è lettore che non sia incappato nel video pubblicato a febbraio da Trump, dove le macerie di Gaza diventano un resort di lusso con ballerine (barbute), idoli d’oro dalle fattezze trumpiane e soldi che piovono su un estasiato Elon Musk. Forse quello che tanti non sanno, però, è che questa clip, creata originariamente da un videomaker di Los Angeles con una funzione satirica, è stata solo successivamente incorporata e risucchiata dalla comunicazione trumpiana, talmente esplicita da apparire al contempo ridicola e annichilente nella sua efficacia propagandistica.
Le immagini IA veicolate dall’estrema destra dipingono spesso forme di crudeltà e violenza verso gruppi specifici (come donne, migranti, Lgbtq+), promulgando fatti o concetti totalmente inventati e risultando quindi tutt’altro che innocue. Che siano vere o meno, poco importa. Che siano esteticamente accettabili nemmeno.
Nelle mani di chi si appropria dei concetti di postverità per far vincere la regola del «vale tutto», quale strumento migliore dell’IA? Se, come ormai abbiamo imparato, le immagini fotografiche non sono più traccia del reale, ma proiezioni del punto di vista di chi le scatta, perché non può essere così anche per immagini che fotografiche non sono? Sembra che i totalitarismi postmoderni abbiano studiato i grandi teorici della fotografia, prelevando dal concetto di postdocumentario una lezione importante: niente è reale quanto gli stereotipi. Mentre la fotografia, nel corso degli ultimi 30 anni, ha cercato di combattere i bias che sottendono alla creazione di immagini (e quindi di opinioni) l’estremismo politico ha capito dove battere per mobilitare le masse. Non è importante che cosa è rappresentato, ma quale bias tocca.
L’immagine come costrutto artificiale
Guardando gli artisti che a vario titolo si occupano di IA oggi (mi riferisco soprattutto a quelli che hanno cominciato a sperimentare con la «democratizzazione» del mezzo e non a chi si occupa di questa tecnologia da decenni), viene da chiedersi quanti stiano effettivamente mettendo in atto una critica di tutto ciò. Si vedono suggestive ricostruzioni di epoche storiche mai esiste, distopie futuristiche dal sapore decadente, storie familiari ricucite dando in pasto all’algoritmo i volti dei propri cari, e nei più fortunati dei casi riflessioni sulle questioni tecnopercettive dell’immagine in quanto costrutto artificiale. Sembra quasi che i fotografi si divertano. Si sentono forse liberati da quel macigno che pesa sulle loro spalle dagli anni ’90, ovvero il postfotografico? Ora non solo la fotografia mente, ma addirittura inventa.
Emblematico è il caso di Michael Christopher Brown, fotogiornalista che collabora con testate come «National Geographic» e «New York Times». Nel 2023 Brown ha realizzato un progetto interamente con Midjourney, rappresentando le migrazioni tra L’Avana e la Florida, sulla base delle storie di persone in fuga da Cuba. L’efficacia di operazioni come queste è ancora da definire, ma viene da chiedersi se sia effettivamente un gesto responsabile nella sua interezza: raffigurare qualcosa che non è mai stato visto in prima persona non equivale a restituire una visione parziale e stereotipata? E se questa modalità venisse adottata per scopi nefasti e manipolativi (come già sta succedendo) quale sarebbe allora la nostra posizione?
Che cosa c’è dopo la postfotografia?
In questo scenario intricato e in rapidissima evoluzione, c’è una domanda che continua ad assillarmi: che cosa c’è dopo la postfotografia? E soprattutto, che ruolo ha questo paradigma che tanto ha influenzato, giustamente, il nostro modo di guardare al visivo, nell’incremento dello scetticismo collettivo verso le rappresentazioni fotografiche?
Se da una parte la creazione di contenuti IA indebolisce la fiducia del pubblico nelle immagini, dall’altra il concetto di postverità applicato alla fotografia ha ormai eroso il suo potere di testimonianza e quindi di cambiamento sociale, che in un momento storico come questo è più cruciale che mai. In un saggio del 1995, Post-Documentary, Post-Photography, Martha Rosler già teorizzava le conseguenze del concetto di postfotografia. La perdita di fiducia nella capacità della fotografia di rappresentare la realtà avrebbe comportato anche la scomparsa del suo valore come riferimento sociale, privandola del ruolo di strumento per comprendere e interpretare gli eventi del mondo. E così è stato. Il dibattito artistico attorno all’IA rischia di essere l’ennesimo colpo di grazia, offuscando le reali implicazioni sociali del nuovo mezzo tecnologico, ma soprattutto tralasciando una riflessione improrogabile sul ruolo che la fotografia dovrebbe assumersi nella società.
E qui emerge un tema fondamentale: se raramente si affronta il tema dell’etica applicata alle nuove tecnologie, ancora più raramente lo si fa in qualsiasi altro ambito della fotografia, soprattutto in Italia. Per esempio, nelle scuole sembrano non esserci insegnamenti ufficiali dedicati a codici di condotta inclusivi e rispettosi, se non per libera scelta dei docenti che decidono di affrontare la tematica all’interno dei loro corsi.
Nei festival di fotografia, a parte rare eccezioni, la responsabilità professionale e morale (che si traduce prima di tutto in una ridefinizione del rapporto tra fotografo e fotografato, e di conseguenza nell’utilizzo e diffusione consapevoli delle immagini) viene relegata a qualche progetto minore. Nei musei poi non è ancora arrivato il concetto di postdocumentario, figurarsi quello di etica fotografica. La fotografia socialmente impegnata è stata abbandonata a favore di una fotografia intelligente, umana e/o artificiale. Ma è probabilmente arrivato il momento di tornare a essere meno intelligenti e più etici. La fotografia, quella che può fungere da prova documentale e strumento di protesta, ci servirà.
Altri articoli dell'autore
Un progetto partecipativo realizzato in Emilia celebra la fotografia come esperienza collettiva
Alle Gallerie d’Italia-Torino 27 opere, dalle fotografie più importanti della fine degli anni Settanta a quelle più recenti, di uno dei più significativi e influenti fotografi contemporanei
Il direttore de Les Rencontres d’Arles, la rassegna dedicata all’ottava arte più longeva e prestigiosa del mondo, ci racconta il suo festival: artisti emergenti, grandi maestri e un legame forte con il territorio
Alla Bundeskunsthalle di Bonn una mostra ricca di immagini e spunti sulla vita di una delle voci più lucide del contemporaneo. Resta però in superficie l’analisi della sua riflessione sull’etica della fotografia