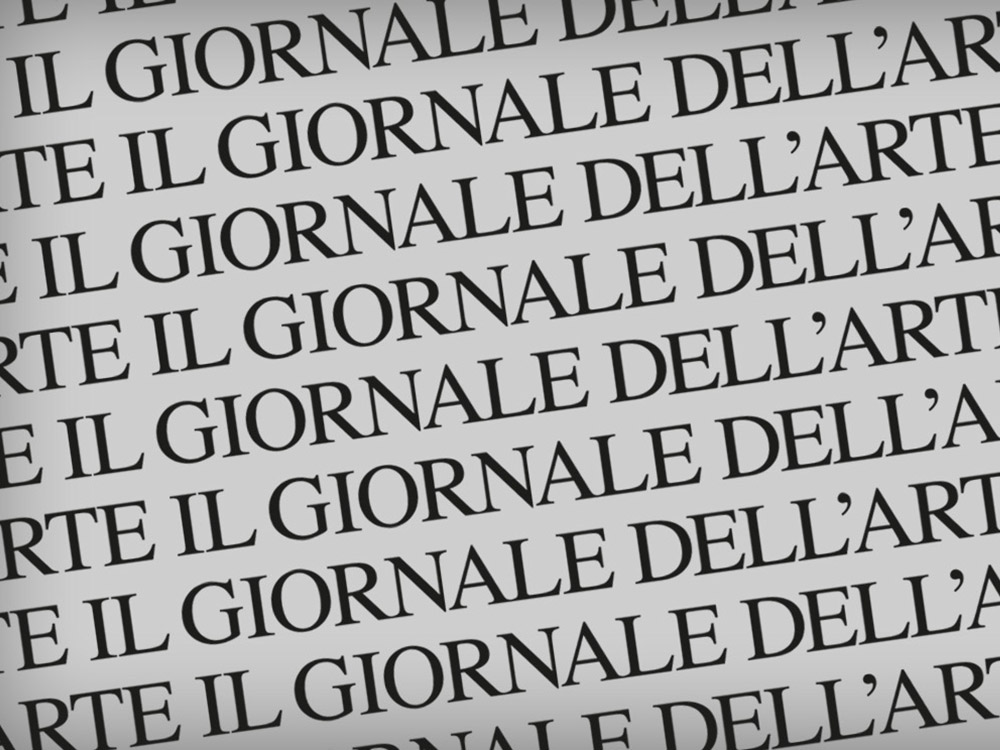Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
.jpeg)
Flaminio Gualdoni
Leggi i suoi articoliDice che uno gongola. Nel 2016 i visitatori dei musei italiani sono stati 44 milioni e mezzo, sei in più del 2013 e uno e rotti in più del 2015, per dire. Segno che a far funzionare un po’ le cose, poi le cose funzionano. Beninteso, i dati sono solo numeri, dunque poi vanno capiti. Per dire, gloriarci della nostra crescita mentre altrove i visitatori sono in calo, e qui il ministro annunciante il portento un po’ ha maramaldeggiato, vuol dire tutto e niente. Il Louvre che perde due milioni di visitatori in due anni dice più che altro che i turisti stranieri, da sempre la larga maggioranza nell’ordine del 70%, adesso hanno molta meno voglia di andare a Parigi (al Louvre -61% di giapponesi, -31% di cinesi, -18% di americani) per ragioni che con l’arte non hanno nulla a che fare. Invece quando il pubblico è meno turistico le cose vanno diversamente visto che il Pompidou, dove la maggioranza dei visitatori è indigena, ha aumentato vistosamente, superando i tre milioni (tre milioni! in un museo di contemporaneo!) e toccando con Klee i 400mila.
Per quanto riguarda noi, la crescita è una gran bella cosa, stando attenti però a considerare che realtà mature e stabili tengono più o meno il patrimonio di biglietti che avevano, mentre quelle in sofferenza, dove le cose si stanno progressivamente aggiustando, segnano aumenti vistosi. Colosseo e Uffizi sono suppergiù al punto di prima, e Brera perde addirittura un po’. Pompei aumenta, la Venaria e Caserta crescono molto, la Borghese un pochino. Che è come dire che se una realtà non era troppo malmessa progredire è un bel problema, e altrove se c’era molto da fare e si è fatto molto, molto si è avuto. Un po’ come la faccenda della crescita del pil: più facile che aumenti vistosamente in posti sfigati che in posti che erano già economicamente ben messi. E poi in certi luoghi le mostre fanno il loro, altri le mostre non le posson fare proprio eccetera.
Il caso che mi diverte di più è quello dell’Antiquarium di via del Seminario a Trieste, che può annunciare festosamente lo strabiliante aumento percentuale di visitatori del 933%: record, roba da farci titoloni, non fosse che in numeri assoluti è passato da 120 a 1.240 visitatori.
Comunque il fatto è certo. A metterci due lire, in cultura, i soldi tornano indietro e ci si sente anche meno baluba, il che è gratis e non è male. Alla faccia di quel ministro là con la erre blesa che diceva il contrario, e per fortuna pare scomparso dai radar del mondo.
Lui è svanito, ma quelli convinti che investire soldi in cultura sia una gran rottura, un po’ come l’obbligo di leggere i Promessi sposi a scuola, sono ancora tanti, visto che, nei mala tempora che currunt per i bilanci, quelli del Mibact sono assai più mala degli altri: quindi abbondano anche nel presente Consiglio dei ministri.
Lo so, non ci azzecca niente, ma il mio animo contadino non riesce a non fare il confronto. Ogni volta mi vien da pensare che il motore, dico solo il motore, mica tutto l’ambaradan completo, di un aereo F35 (posto che mai vedremo l’ambaradan medesimo tutto intero, visto che cominciano a non crederci più tanto neanche gli americani che lo fabbricano) costa quindici milioni (un aggeggio intero circa centoventi), una roba che a Franceschini un po’ di problemi li risolverebbe: non tutti, «roba minima» come cantava quello con le scarpe da tennis celebrato da Jannacci, «roba de barbùn» com’è giusto che sia, se si guarda dal punto di vista delle stanze dove si puote: ma un po’ sì. Meglio qui che in un aereo la cui storia sembra un’illusione della mente come il gioco del monopoli, ma meno divertente. E comunque meglio non fare una spesa pirla che menarsela con la spending review da mane a sera. Poi mi vien da pensare che per fortuna in questo caso il ministro può fingere di ignorare che ci sia anche la Sicilia, la quale i suoi beni se li amministra da sé, dove si verificano amenità tipo i quarantadue custodi del museino di Centuripe (per poco più di 3mila visitatori; a Brera a custodire sono in poco più di cento). Avesse pure quella tra i piedi, anche tutte queste statistiche sobriamente ottimistiche andrebbero a quel paese.
Altri articoli dell'autore
Il Criptico d’arte • Conosciuto anche come Vasco dei Vasari, l’architetto italiano fu un personaggio anomalo: nonostante il suo contributo al Futurismo, indagò il modo in cui l’anarchia influenza l’arte
Il Criptico d’arte • La vicenda della Banana di Cattelan: da provocazione sul mercato a oggetto di gesti insensati e fuorvianti
A Milano una collettiva di 12 artisti omaggia in altrettante puntate il capoluogo culla della tecnica artigianale e artistica in grado di passare da generazione in generazione
La grande mostra sul movimento artistico voluta dall’ex ministro Sangiuliano in realtà arriva dopo settant’anni di studi specialistici sull’argomento. Ma l’Italia non è futurista