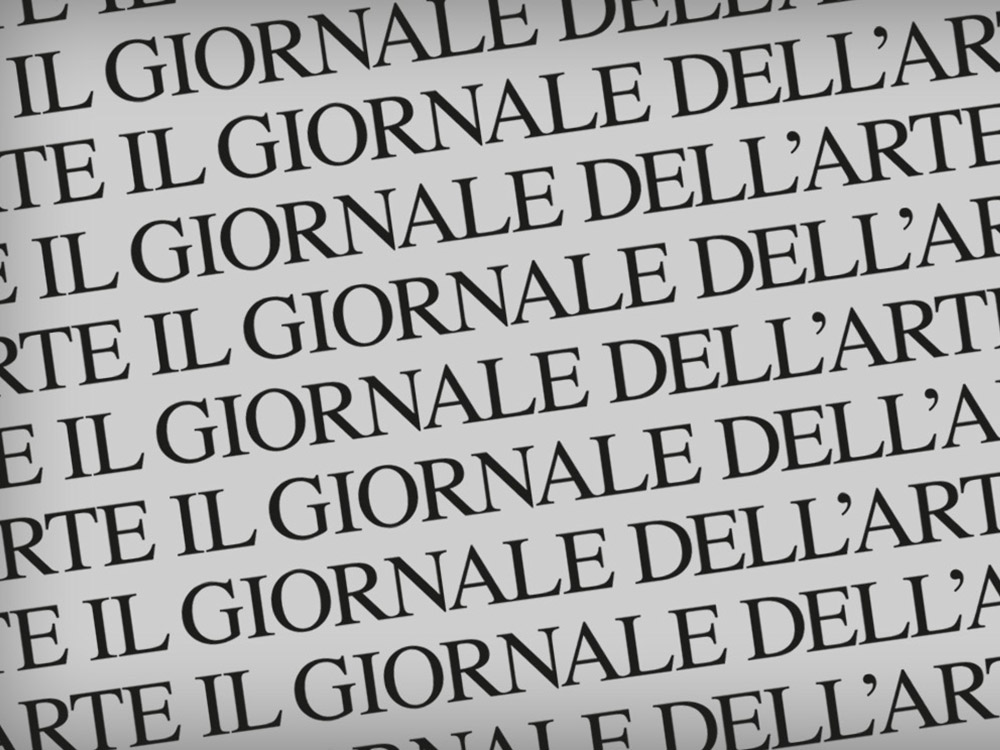Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Fabrizio Lemme
Leggi i suoi articoli
La legislazione fascista in materia di belle arti è stata, senza dubbio, un esempio di intervento illuminato del legislatore in una materia di non facile disciplina. Essa non si limita alla sola fondamentale legge 1 giugno 1939 n. 1089 (esempio insuperato di come deve essere congegnato un intervento legislativo), ma si estende anche a leggi complementari, delle quali ci piace ricordare quella che reca la data dell’11.5.1942 n. 839. Essa ha introdotto nel nostro ordinamento la regola in virtù della quale gli edifici pubblici realizzati dalle Amministrazioni dello Stato debbono comprendere opere d’arte, per un costo pari al 2% dell’intera spesa. Si tratta di un notevole incremento della committenza artistica ufficiale e pertanto essa non può ricevere che il plauso e la piena attuazione anche in tempi di «magra», come gli attuali. Nel gennaio 1991, su questo giornale (cfr. n. 85, p. 18) feci un primo intervento riepilogativo sulla portata della legge. Il mio ritorno all’argomento mi è stato ispirato da un lettore, che mi ha rivolto al riguardo due specifici quesiti: il primo, se la legge trovi applicazione anche per le infrastrutture stradali e ferroviarie; il secondo, se chi realizza tali infrastrutture possa, non debba, aggiungere a esse opere d’arte.
Prima di affrontare gli argomenti di interesse del lettore, debbo sgombrare il campo dagli equivoci. La paternità della legge del 2% va riconosciuta a Giuseppe Bottai, grande ministro della Cultura che, al di là di ogni nostalgia, in me completamente assente, non possiamo non rimpiangere, oggi che siamo caduti così in basso. Essa è stata più volte novellata: una prima volta, con la legge 29 luglio 1949 n. 717 (che ha doverosamente eliminato alcuni riferimenti, ormai divenuti incongrui, recati dalla legge 839/42: ad esempio, quelli al Partito Nazionale Fascista, parificato a una amministrazione pubblica o alla Confederazione Fascista dei professionisti e degli artisti); una seconda volta, con la legge 237/60, che ha introdotto una modifica in materia di collaudo; una terza volta, con le leggi 412/75 e 54/79, che hanno eliminato il riferimento dell’obbligatorietà degli interventi artistici nell’edilizia scolastica e universitaria; una quarta volta, con la legge 27/2012, che ha escluso l’obbligatorietà di tali interventi «nelle costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonché negli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore ad un milione di euro». Così spianato il testo normativo, la cui attuazione a lungo non è stata praticata, tanto che nel mio intervento del 1991 mi ponevo il problema se la legge potesse ritenersi abrogata per «desuetudine», chiarisco che essa è tornata ormai di prepotente applicazione.
Vediamo, allora, di chiarire i due dubbi. Per una questione lessicale, qualunque «infrastruttura» e in particolare quelle stradali e ferroviarie evocano una realtà del tutto eterogenea rispetto al concetto di «edificio», il cui senso comune è circoscritto alla costruzione realizzata dall’uomo e destinata ad accogliere stabilmente al suo interno persone o attività loro connesse. L’infrastruttura, viceversa, indica soltanto un intervento che media fra più strutture primarie: ad esempio, un nodo stradale, un nodo ferroviario, una congiunzione tra più strade o più linee ferroviarie. Dunque, i due concetti sono tra loro talmente eterogenei che non è consentita l’estensione dall’uno all’altro neppure attraverso il procedimento interpretativo dell’«analogia». L’analogia, infatti, si richiama al tropo (luogo comune) di eguaglianza. Pertanto, l’obbligo di realizzare interventi artistici nelle infrastrutture è da escludere per mancanza di previsione normativa e incompatibilità logica.
Veniamo allora al secondo problema: la legge del 2% ha l’effetto di rendere obbligatorio l’intervento volto a inserire manufatti artistici negli edifici pubblici, ma, al di là dell’obbligo, chi progetta e realizza opere pubbliche in genere è vincolato solo da ciò che è obbligatorio oppure può anche andare oltre?Mi spiego: chi vada a Terni è colpito da due belle sculture di Pomodoro, realizzate all’interno di due aiuole spartitraffico (dunque, tipiche infrastrutture). Il sindaco di Terni non era obbligato a tale inserimento, il cui costo, fra l’altro, è enormemente sperequato rispetto a quello, modesto, imposto dalla realizzazione dell’aiuola. Ma nessuno, certamente, potrà addebitargli tale intervento, che contribuisce non poco a elevare il livello della periferia ternana. In conclusione, anche ciò che non è obbligatorio è normalmente possibile. L’unico requisito indispensabile è quello della opportunità: ed essa è normalmente presente in qualunque intervento dotato di dignità d’arte, nozione diversa da quella, opinabile e soggettiva, di vera ed effettiva opera d’arte, intesa come creatività.
Altri articoli dell'autore
I beni culturali possono essere dichiarati di particolare interesse solo se la loro esecuzione risalga ad almeno cinquant’anni
La capacità (e l’obbligo) di correggersi della Pubblica Amministrazione
Va introdotta una distinzione tra ricerca significativa e ricerca inutile: la prima aggiunge qualcosa alle conoscenze già acquisite, la seconda si limita a riproporre il «déjà dit»
Il conflitto tra Russia e Ucraina mette in luce un relativismo che parte da Giovanni Battista Vico