
IL NUMERO DI DICEMBRE 2025 in edicola
In allegato:
Il Giornale dell'Arte
IL NUMERO DI DICEMBRE 2025 in edicola
In allegato:
Vernissage
IL NUMERO DI DICEMBRE 2025 in edicola
In allegato:
Il Giornale dell'Economia
IL NUMERO DI DICEMBRE 2025 in edicola
In allegato:
Il Giornale delle Mostre
IL NUMERO DI DICEMBRE 2025 in edicola
In allegato:
Focus Restituzioni
IL NUMERO DI DICEMBRE 2025 in edicola
In allegato:
Il Giornale dell'Arte
IL NUMERO DI DICEMBRE 2025 in edicola
In allegato:
Vernissage
IL NUMERO DI DICEMBRE 2025 in edicola
In allegato:
Il Giornale dell'Economia
IL NUMERO DI DICEMBRE 2025 in edicola
In allegato:
Il Giornale delle Mostre
IL NUMERO DI DICEMBRE 2025 in edicola
In allegato:
Focus Restituzioni
Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
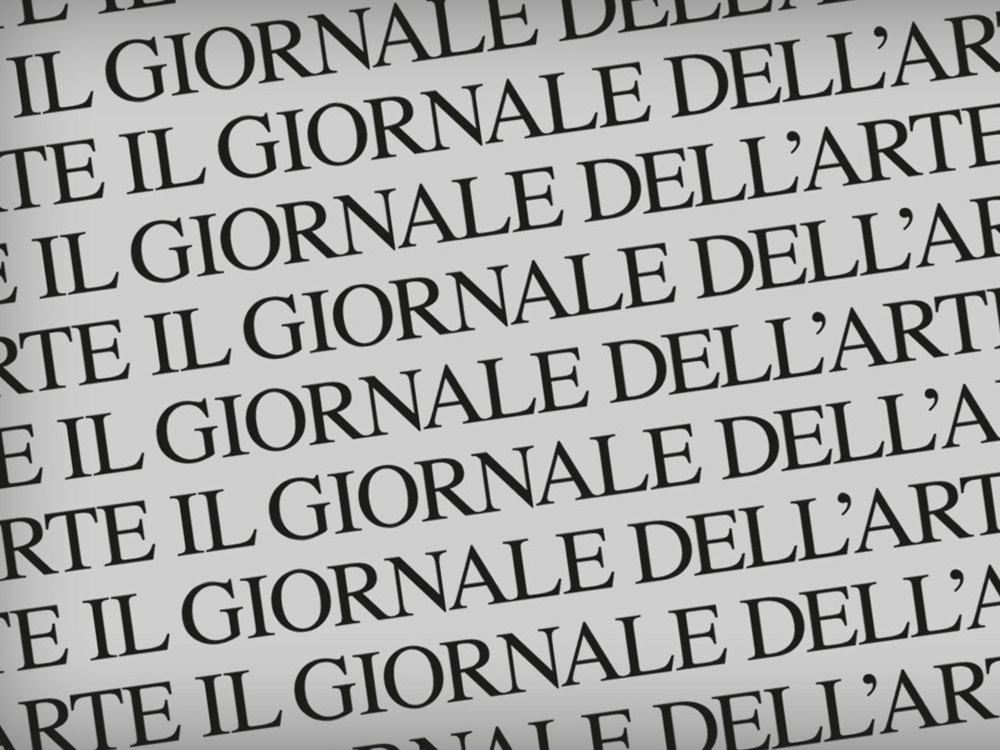
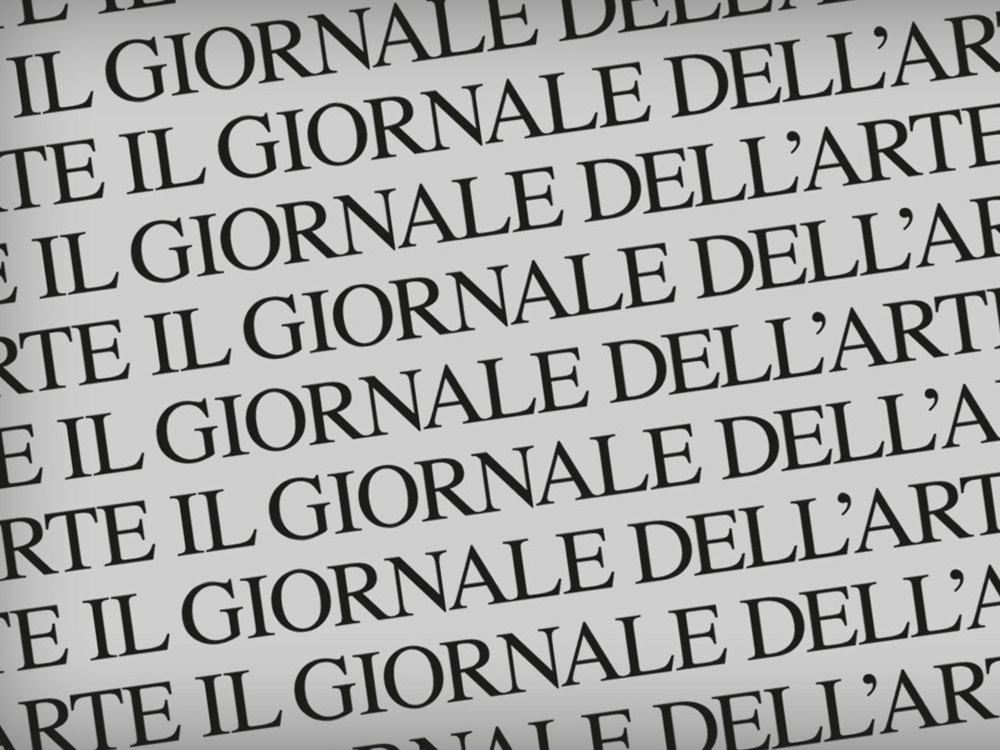
Dedicata alla scultura lignea «ticinese» (ticinese perché creata qui o perché qui importata in antico) dal XII al XVIII secolo, la mostra riunisce una cinquantina di opere, alcune inedite e tutte restaurate in quest’occasione, giunte da musei, chiese e monasteri del territorio, proponendosi come la prima vera ricognizione di questo aspetto sinora assai poco indagato della cultura visiva ticinese.
In mostra figurano sculture romaniche, come la «Madonna» di Arogno e opere gotiche (di un gotico di volta in volta prezioso, come nella «Madonna» di Origlio, o drammatico, come nel «Crocifisso» di Olivone), e importanti pezzi rinascimentali, spesso opera degli stessi artisti che operavano con grande fortuna a Milano e nel Ducato (i De Donati, il «Maestro di Santa Maria Maggiore», autori dall’ambito di Giacomo Del Maino e il manierista Battista da Corbetta), per spingersi poi negli assai meno esplorati secoli successivi. La scultura lignea è oggetto di studi da non più di quarant’anni, specialmente nei territori contigui del Piemonte e della Lombardia, ma del suo lungo percorso è soprattutto l’età rinascimentale a essere stata scandagliata più a fondo, mentre il Medioevo e il Sei e Settecento sono tuttora poco esplorati.
Questa mostra, tuttavia, oltre a presentare una prima vera ricognizione sulla scultura lignea del Medioevo, offre alcune «primizie» critiche anche per il Rinascimento, esibendo pezzi mai esposti prima, come la «Madonna di Loreto», da Bellinzona, e la «Vergine» ora di collezione privata ma un tempo a Minusio, o raramente visti, come la «Madonna con il Bambino» dalla parrocchiale di Malvaglia; oppure sculture attribuite in quest’occasione, come la coppia di «Angeli» da Giornico o il «Cristo portacroce» dalla Chiesa di Loreto a Lugano.
Non mancano le sculture di area tedesca, importate qui sin dal Medioevo, ma moltiplicatesi al tempo della Riforma, quando molte chiese cattoliche, convertite, furono spogliate dei loro arredi sacri, talora avviati verso il sud (esemplari la «Pietà» di Claro, le sculture delle ancone di Monte Carasso, dal Landesmuseum di Zurigo, e l’altare di Foroglio). Non meno importanti le novità critiche offerte dalle sezioni del Sei e Settecento, provando come in questo periodo prenda il via una forte importazione di opere lignee, prima da Milano e dal Comasco, poi anche da Piemonte e Liguria. Molte anche qui le nuove attribuzioni, mentre s’impongono per spettacolarità il tabernacolo di Santa Maria del Bigorio, il «San Vincenzo Ferrer» da Vacallo e il «Beato Angelo Porro» da Mendrisio.










