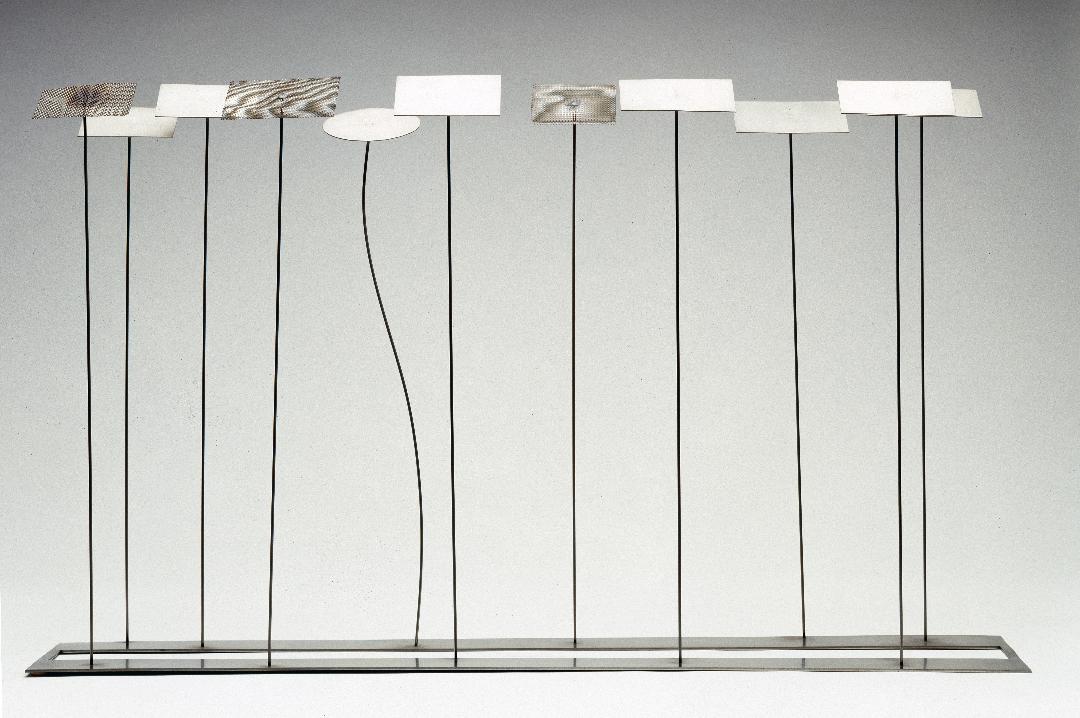Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Franco Fanelli
Leggi i suoi articoliNell’arruolamento di artisti non sovraesposti, meglio se quasi sconosciuti e provenienti da angoli del pianeta remoti rispetto al sistema dell’arte (ma pronti a diventare esotiche prede di galleristi e collezionisti), quelli schierati a Documenta sembrano avere un altro passo rispetto ai loro colleghi di scena alla Biennale di Venezia, almeno a giudicare dalla qualità delle opere. Al di là delle apparenze e dei programmi, le due mostre non sono così distanti nei contenuti. In fondo i temi dei transpadiglioni di Christine Macel a Venezia sono abbastanza capienti da poter inglobare varie attitudini, dalla pura visionarietà all’antropologia, dalla sociologia all’etnografia, dal libro alla politica.
Adam Szymczyk, direttore di Documenta, sapendo che la politica è già di suo un crogiolo nel quale rimestare tutto quanto sopra elencato, rispetto alla Macel ha puntato con maggior decisione su questa sola impronta, conscio che in una fase come quella attuale, che lui in catalogo definisce «pericolosa», in cui populismi e terrorismi, immigrazione e guerre impongono una riformulazione del concetto di democrazia, i «fatti» (anche, ma non solo, perché dilatati dai media) sono così suggestivi e addirittura iconici da surclassare la più sfrenata fantasia. Figuriamoci quella degli artisti d’oggi, la cui creatività e la cui voglia (o capacità) di sperimentare sembrano essersi da qualche tempo atrofizzate in un accademico neoeclettismo. Anche per questa ragione è facile andare a rimorchio della cronaca.
A Kassel si vedono opere che non anticipano la realtà, come ci si aspetterebbe dall’arte, ma la illustrano, con figure e comportamenti. Documenta 14, dunque, poggia su un «testo» tragicamente ricco di spunti, in questo ancora più generoso rispetto a quelli offerti in passato da altre edizioni simili, come quelle dirette da Catherine David o da Okwui Enwezor. E per quanto, nei casi migliori (e con rare eccezioni) gli artisti che vi partecipano sono soltanto i Gustave Doré della cronaca, in base all’estetizzazione di quel «testo» primeggiano su quelli invitati dalla Macel. Non è dunque merito del pragmatismo di Szymczyk, né colpa dell’eccessiva e quasi utopica fiducia di una storica dell’arte francese rispetto agli attuali interpreti della disciplina da lei amata se, a parità di condizioni (entrambi i curatori non offrono un taglio e un disegno precisi, ma si limitano, anch’essi, a «mostrare»), le opere di Documenta sembrano più forti.
E ancora: a Kassel la storia, anche quella della cultura (nelle sedi istituzionali scelte come location anche simboliche), è rivisitata alla luce della memoria soprattutto politica e sociale, con non pochi riferimenti a un argomento di sicura presa, quello del passato imperialista e nazista della Germania, mentre la cronaca è narrata con un canovaccio quanto mai popolare (o populista?), che verte sul neocolonialismo finanziario (di qui il «risarcimento» alla Grecia bastonata da Angela Merkel).
A Venezia lo sguardo al passato, anche nei padiglioni nazionali, è spesso di tipo formale, nello sforzo di richiamare a nuova vita il cadavere delle avanguardie e delle neoavanguardie, attive in tempi lontani in cui l’arte si misurava con la realtà senza farsene mero specchio. Ma proprio su questo fronte la mostra di Venezia ha rivelato clamorosi buchi di creatività da parte degli artisti, fermi alla citazione nostalgica o al ricalco, attualizzato ma non per questo rivitalizzato, di moduli e modelli ormai privi di contatto con il presente.
Il confronto tra i «documentaristi» di Kassel e i sognatori stanchi di Venezia finisce così con un malinconico e preoccupante zero a zero. Con una constatazione: se a Documenta molte opere prevalgono su quelle della Biennale, non una appare in grado di misurarsi con la drammaticità del «Faust» messo in scena a Venezia proprio nel Padiglione tedesco. A Kassel un’opera così non c’è. E il dubbio è che non ci sia perché, seppure vicina a temi di assoluta emergenza sociale, quell’opera è formalmente eretica rispetto alla dogmatica e didascalica ortodossia di una mostra che, per origini, sede, tradizione e destino sembra prigioniera della sua stessa ormai antica identità. Un’anima che, ad aggravare la situazione, ha smarrito anche la profondità e il respiro dei tempi di Arnold Bode, Manfred Schneckenburger, Harald Szeemann, Rudi Fuchs e Jan Hoet. Nella tanto strombazzata discesa alle Madri ad Atene, città gemellata a forza, Szymczyk e i suoi artisti hanno clamorosamente ignorato non solo il mito e la tragedia autentici, ma anche il sorriso degli dei, utile, se non altro, a ridimensionare la hybris dei curatori.
Altri articoli dell'autore
100 opere in una retrospettiva al Museo di arti decorative Accorsi-Ometto: dagli acquerelli autobiografici degli anni ’30 alle ultime carte, 70 anni di trasgressioni e di «gesti erotici» di un’artista insofferente a ogni etichetta estetica e stilistica
Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale
53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere
Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi