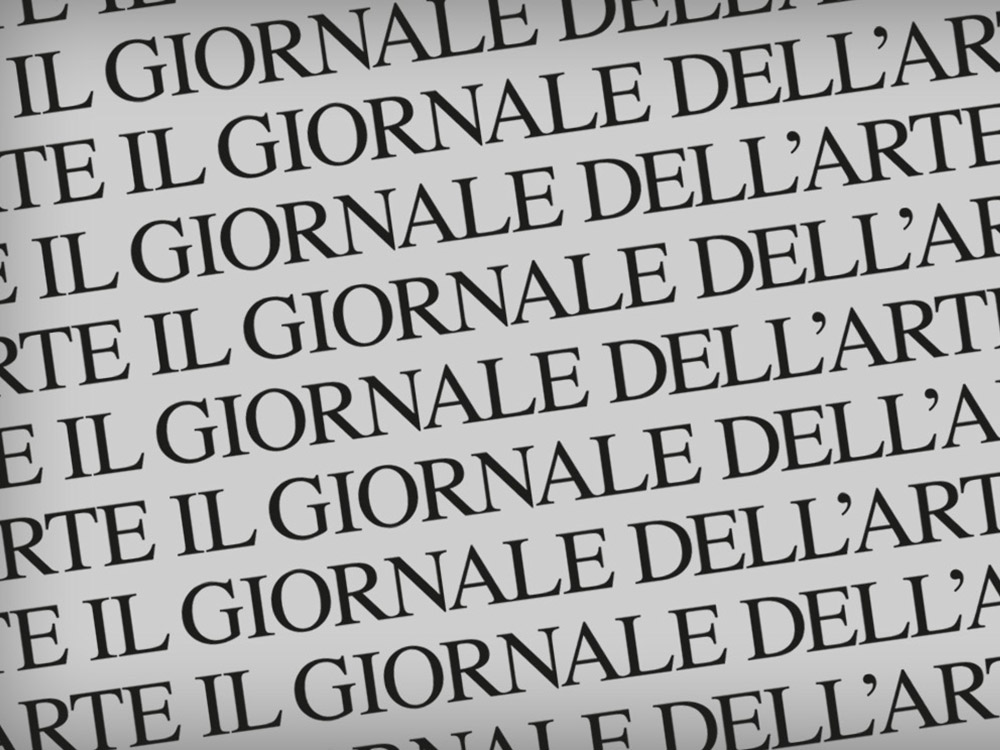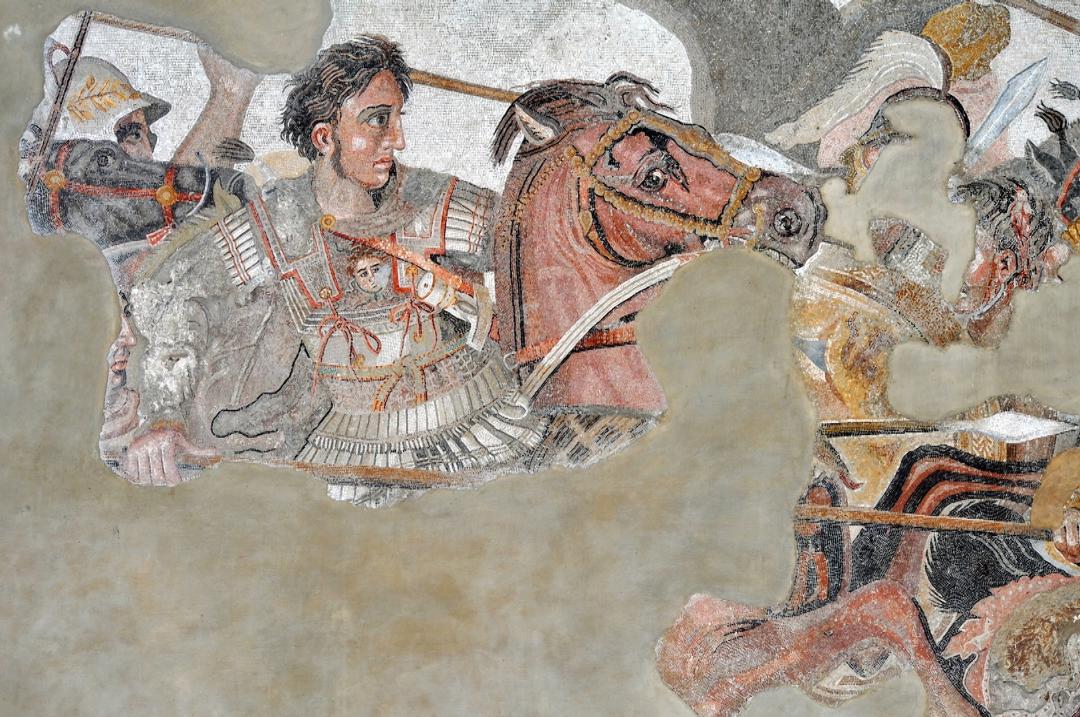Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Giorgio Bonsanti
Leggi i suoi articoli
L’inesistente analogia tra strumenti scientifici e musicali
Ogni intervento di restauro e conservazione deve essere preceduto da una fase di studio dell’oggetto. Devono essere accertati i suoi materiali costitutivi e le sue coordinate storico-antropologiche (lasciando per il momento da parte la cosiddetta «intenzione dell’autore», concetto ingannevole). Ferma restando la bontà del modello italiano, che prevede la collaborazione delle diverse professionalità utili al conseguimento del risultato, e tenuto conto che è solo il restauratore a potere «manipolare» l’oggetto, cioè mettervi le mani sopra, è proprio a lui che in ultima analisi compete come diritto/dovere la conoscenza profonda dell’opera.
Dei sei percorsi formativi in cui si articola oggi l’insegnamento del restauro (Allegati B e C al DM n. 87, 26 maggio 2009), il sesto è intitolato a Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici e Strumenti musicali. Fino a oggi, nessuno degli Istituti accreditati ha aperto corsi di insegnamento in questo Percorso VI. Il primo sarà, nell’anno scolastico 2016-17, presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia (sede di Cremona), e già si capisce che gli strumenti scientifici saranno presenti «in maniera meno preponderante», come onestamente dichiarato.
Con ciò non intendo avanzare dubbi sulla qualità dell’insegnamento relativo; semplicemente segnalare un’evidente incongruenza, laddove il legislatore ha creduto di ravvisare fra le due categorie un’analogia che è di fatto inesistente. Non sono difatti i materiali in sé (legno, metalli) a qualificare, ma l’identità degli oggetti; prova ne è che ben difficilmente si troverà un restauratore di liuteria che abbia lavorato su un barometro a sifone di Gay-Lussac o su un focometro di Silbermann (troverete un utilissimo indice analitico delle strumentazioni scientifiche sul sito dell’Arass Brera, benemerita associazione creata da un gruppo di pensionati che si appoggia a Open Care di Milano).
Oggi in Italia i restauratori di strumenti scientifici sono pochissimi, proprio perché la conservazione di questi oggetti non spetta a chi è competente di legni o metalli, pena gravissimi rischi di stravolgimento dell’oggetto; a cominciare dalla decisiva operazione preliminare di scegliere se restituirgli il funzionamento o fermarsi all’involucro. Occorrerà correggere un apparentamento anomalo e nel frattempo vegliare affinché lo straordinario patrimonio italiano di strumenti scientifici venga trattato con l’indispensabile prudenza.
Altri articoli dell'autore
Dalla legge Bottai del 1939 al Codice Urbani del 2004, la nozione di restauro si è ampliata fino a comprendere ogni testimonianza di civiltà. Non solo dipinti o sculture, ma anche oggetti d’uso, strumenti, tessili, manufatti e persino espressioni immateriali. Un percorso che riflette l’evoluzione del pensiero conservativo e il significato stesso di Restituzioni come progetto inclusivo e identitario
Qualcuno avrebbe preferito una chiesa di nuova progettazione al posto della prima, riaperta dopo il terremoto del 2016, così come qualcuno oggi vorrebbe un edificio moderno al posto della dell’edificio in parte crollato a Roma
Ritrovati nel 2013, i dipinti che il pittore realizzò in occasione dell’Esposizione romana del 1911 sono stati restaurati presso l’Istituto Centrale del Restauro: Laura D’Agostino e Paola Iazurlo hanno dedicato un libro all’artista e al delicato intervento
Aperto per restauri • Nel mestiere più bello del mondo il «fattore umano» sarà scalzato dall’IA? Speriamo tanto di no