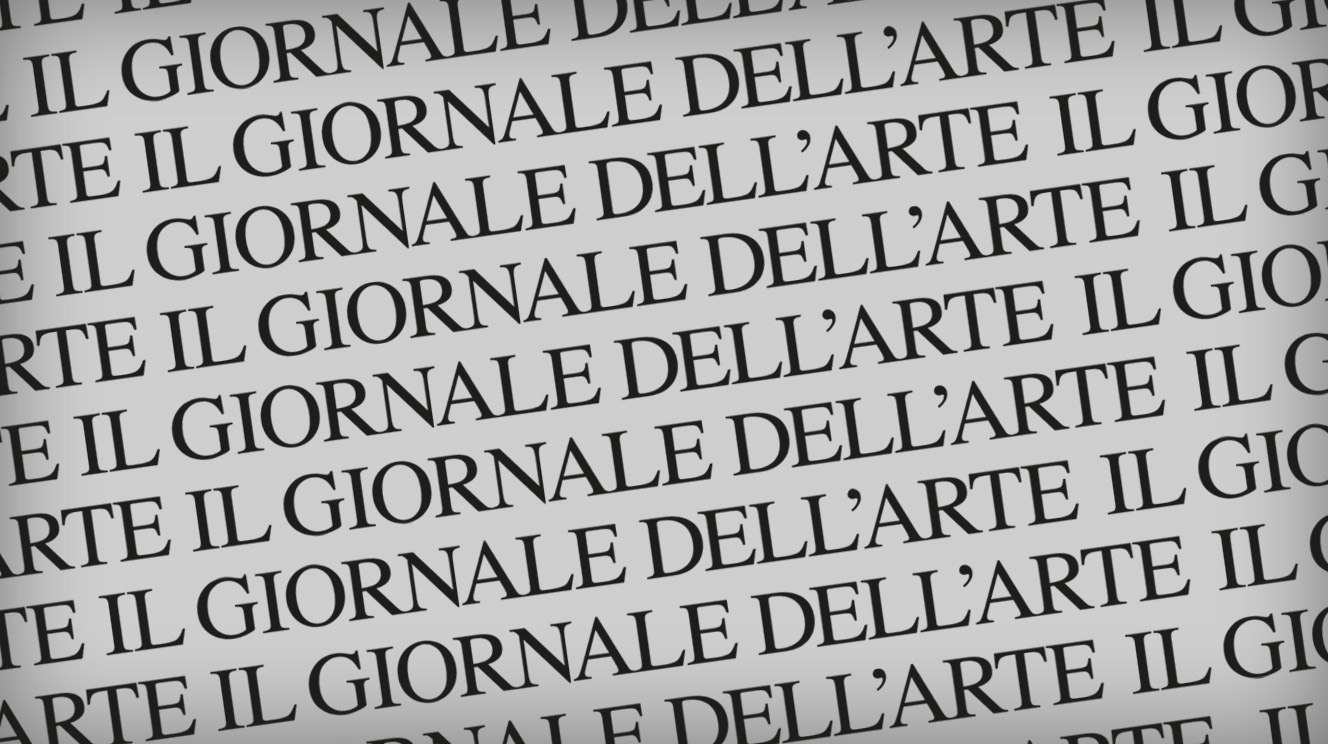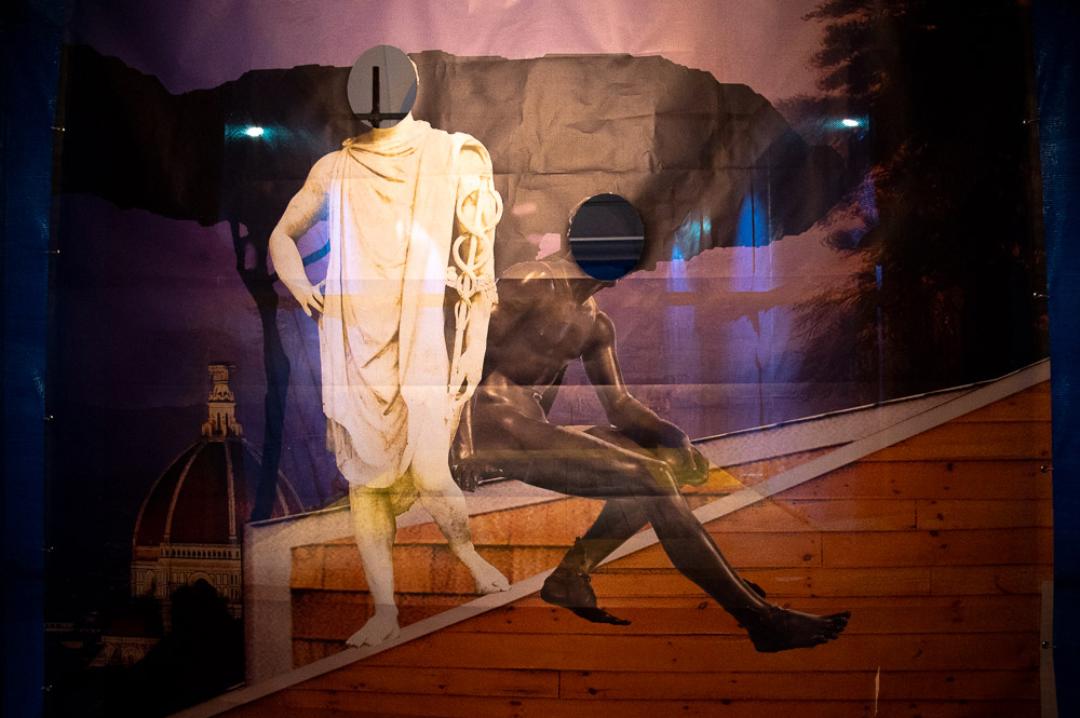Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Laura Lombardi
Leggi i suoi articoliL’apertura, molto attesa, del nuovo Museo dell’Opera del Duomo il 29 ottobre svelerà il suo nuovo allestimento studiato per accogliere la maggiore concentrazione di scultura monumentale fiorentina al mondo. L’Opera del Duomo risale al 1296, ma il museo, fondato nel 1891, era insufficiente a contenere le opere, specie con l’aumentare delle sculture, che per ragioni conservative, dopo il restauro, avrebbero dovuto essere accolte nel museo.
Con l’acquisto nel 1997, per 9,1 milioni di euro, dell’attiguo settecentesco Teatro degli Intrepidi, ridotto ad autorimessa, 3mila metri quadrati si sono aggiunti ai precedenti 2.500. Il progetto degli architetti fiorentini Adolfo Natalini, Piero Guicciardini e Marco Magni, consta oggi di 25 sale suddivise su 3 piani, grazie a un investimento complessivo dell’Opera del Duomo di 45 milioni di euro, che comprende la revisione di 600 dei 750 pezzi esposti, con circa 130 restauri importanti.
Fulcro del museo è la grande sala (36x20x20 metri) con la ricostruzione dell’antica facciata medievale, smantellata nel 1586-87, in cui sono ricollocate, secondo il disegno cinquecentesco, le quaranta statue, e circa sessanta elementi di rivestimento esterno con decorazioni scolpite e musive (le opere più importanti, ma di alta collocazione, sono tuttavia fruibili in basso, sostituite da calchi nelle nicchie).
Di fronte alla porta mediana della facciata, si trova la «Porta del Paradiso» di Lorenzo Ghiberti, e ai lati le altre due porte del Battistero, ciascuna sovrastata dai rispettivi gruppi statuari cinquecenteschi; infine i due grandi sarcofagi romani che dal Medioevo al Rinascimento furono all’esterno del Battistero. Da questo luogo, in cui è ricreato il dialogo tra l’Antichità, il Medioevo, il primo Rinascimento e la Maniera, proprio della cultura fiorentina, si passa ad ambienti più raccolti, come la «cappella delle reliquie», la sala con la «Maria Maddalena penitente» di Donatello e quella della «Pietà» di Michelangelo. Qui si conclude il primo percorso di visita, da cui si può accedere all’uscita.
Chi vuole proseguire troverà nelle gallerie dei piani superiori gli altri capolavori del museo: le sculture per il Campanile di Giotto, gli oggetti legati alla costruzione della cupola brunelleschiana e, al secondo piano, le opere del tardo Cinquecento e primo Seicento, i modelli lignei dei progetti di Buontalenti, Dosio, Silvani per la nuova facciata e le statue effimere e dipinti realizzati per le nozze del granduca Ferdinando I con la principessa Cristina di Lorena nel 1589.
La particolarità del museo è quella di offrire continui punti di vista sulla grande sala della facciata, postazioni inaspettate per far comprendere i rapporti tra le opere, non solo fisici ma anche concettuali, spirituali, secondo la volontà del direttore del museo, monsignor Timothy Verdon. «Il nuovo museo dell’Opera, realizzato in un antico teatro, fa spettacolo: presenta i capolavori del primo Rinascimento fiorentino come protagonisti del dramma della riscoperta dell’essere umano per cui l’Umanesimo di quel tempo è conosciuto», commenta. Dai piani alti il percorso riconduce al primo piano del museo storico, dove sono, tra l’altro, le cantorie di Luca della Robbia e Donatello. Documentata è infine la realizzazione a opera di Emilio De Fabris della nuova facciata, negli anni Ottanta del XIX secolo, con progetti risalenti agli anni di Firenze capitale d’Italia (1865-71), che tanto appassionarono, ma anche divisero gli animi dei fiorentini.
Altri articoli dell'autore
«Il mio lavoro non è politico, ma piuttosto sociale, perché in politica ci si rivolge a un periodo troppo breve, mentre io mi occupo di questioni più esistenziali», spiega l’artista belga
Il programma espositivo, realizzato con l’American Academy in Rome, mette in relazione le ricerche di T.J. Dedeaux-Norris e Heather Hart con i materiali d’archivio dello scrittore William Demby
Un’intera sala è dedicata al massimo scultore in cera attivo nel capoluogo toscano a fine Seicento: Gaetano Giulio Zumbo
La mostra a Pisa curata da Francesca Dini ripercorre lo sfavillante periodo, a fine Ottocento, in cui Parigi era il centro culturale del mondo. E tra i protagonisti di quel nuovo clima, gli artisti italiani che scelsero la capitale francese come patria d’adozione, tra cui Boldini, De Nittis e Corcos