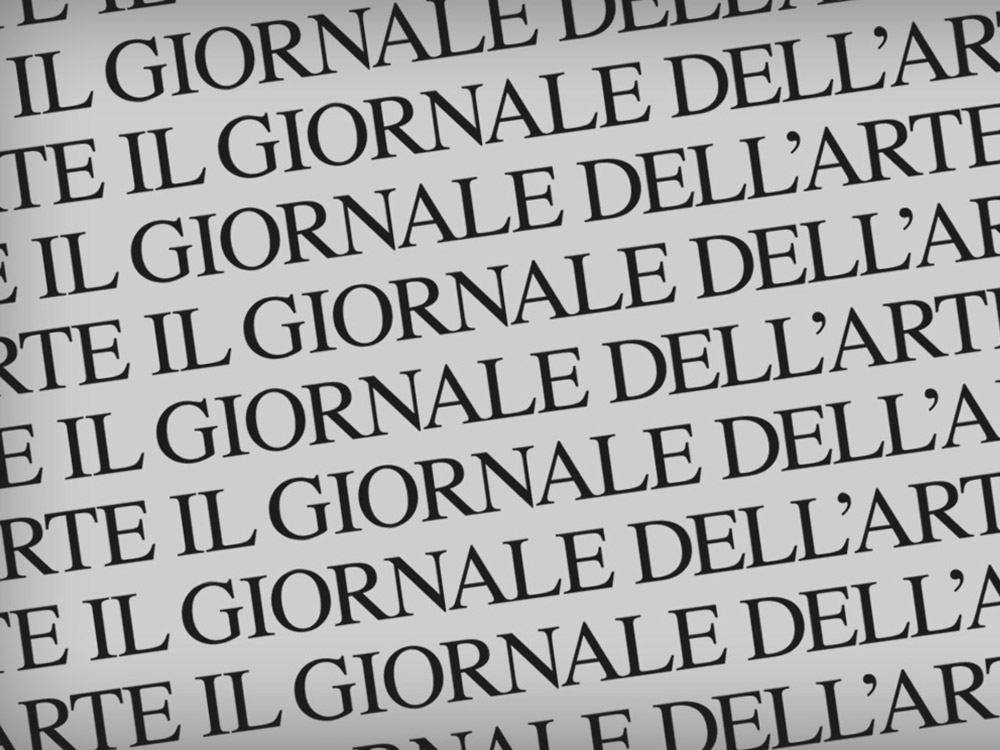Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
.jpeg)
Flaminio Gualdoni
Leggi i suoi articoli
Il «dialogo tra due maestri» è quello che dovrebbe avvenire, nei proclami della nuova mostra del Musée Picasso, tra Picasso stesso e Giacometti. In fondo i presupposti ci sono. Famosi sono famosi. I due si sono conosciuti (e ci mancherebbe, in quella Parigi là) e in qualche occasione pure incrociati. E poi e poi, sono due personaggi dalle aneddotiche lussureggianti, perfetti entrambi per l’immaginario banal-pop che domina i grandi show che vanno per la maggiore. Vuoi mettere uno che conserva sculture microscopiche in una scatola da fiammiferi e un altro che ramazza cose in giro e le monta facendone delle opere? Dunque metterli insieme è un affare a prescindere, l’effetto è assicurato. Che avessero vent’anni d’età di differenza (il che, alle date dell’avanguardia storica, corrisponde circa a un’era geologica) e che avessero scelto di coltivare idee di arte fondamentalmente diverse sin dalle premesse, e dunque fossero un po’ come l’acqua e l’olio, non cale: sarebbe una roba difficile da spiegare, quindi meglio neanche nominarla. Per dirne una. Giacometti rimugina tutta la vita su cosa possa essere la scultura, s’intende l’idea fondamentale dello sculturale che si aggira tra l’essere e l’esistere, e sul perché abbia senso, e ne trae quel po’ po’ di lavori che frantumano molte delle stesse idées reçues dell’avanguardia del secondo dopoguerra. Picasso fa della scultura, la fa come fa ogni cosa, tra altre cose, con il suo gioco dirompente di spavalderie e di derive concettuali e formali. La fa perché esiste una roba che si chiama scultura, perché altri l’han fatta e la fanno ma lui di più, perché è come un ghiacciaio che inghiotte tutto morenicamente e lo restituisce verniciato di genio. Picasso ragiona per misure affermate, l’altro per dimensioni intimamente necessarie, dubbiose e pericolanti nello spazio.
Se serviva una mostra per spiegarci che i due partono da presupposti radicalmente diversi e fondamentalmente inconciliabili, che seguono due percorsi problematicamente tutti divaricati e giungono a esiti sideralmente distanti, fatto salvo che, essendo entrambi dotati di cervello e occhi, si tributano reciprocamente un educato rispetto (ma dopo il 1951, neanche quello) allora l’occasione è perfetta.
La mostra è in realtà la sommatoria di due belle personali messe nello stesso posto, con le opere che si salutano compitamente all’ingresso e all’uscita e che nulla fanno né per cercarsi né per ignorarsi. Poi, certo, due nomoni sul manifesto «is megl che uan», come diceva la pubblicità.
Altri articoli dell'autore
Il Criptico d’arte • Conosciuto anche come Vasco dei Vasari, l’architetto italiano fu un personaggio anomalo: nonostante il suo contributo al Futurismo, indagò il modo in cui l’anarchia influenza l’arte
Il Criptico d’arte • La vicenda della Banana di Cattelan: da provocazione sul mercato a oggetto di gesti insensati e fuorvianti
A Milano una collettiva di 12 artisti omaggia in altrettante puntate il capoluogo culla della tecnica artigianale e artistica in grado di passare da generazione in generazione
La grande mostra sul movimento artistico voluta dall’ex ministro Sangiuliano in realtà arriva dopo settant’anni di studi specialistici sull’argomento. Ma l’Italia non è futurista