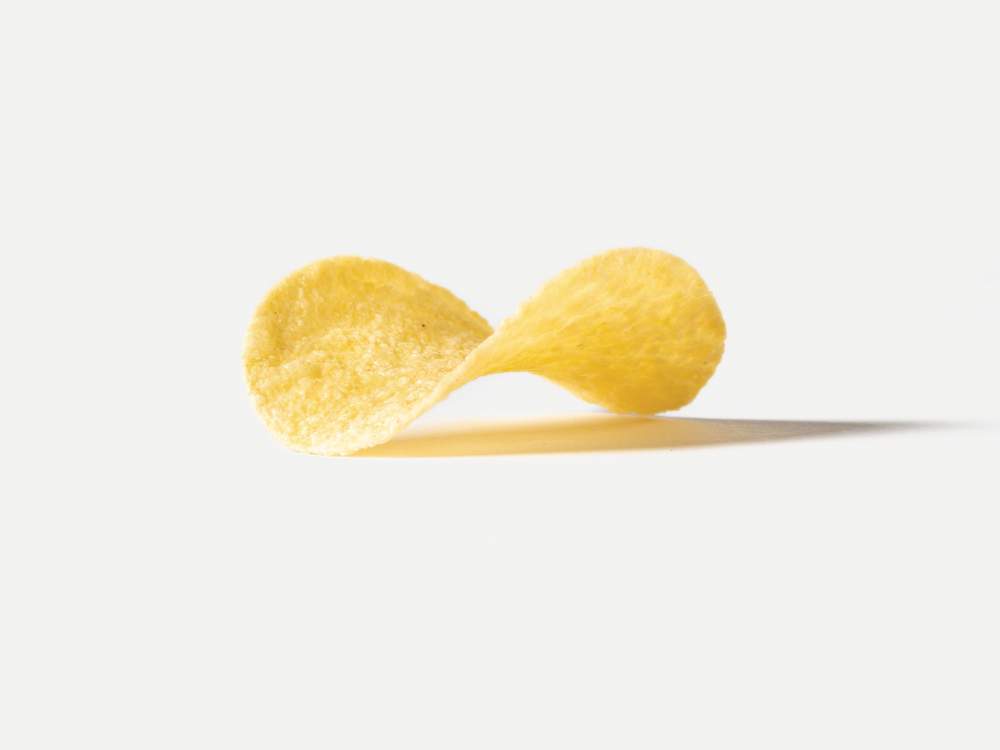Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Stefano Salis
Leggi i suoi articoliIn occasione della mostra in Triennale, Electa pubblica Steinberg A-Z, un catalogo-enciclopedia a cura di Marco Belpoliti che in un centinaio di lemmi ci guida alla scoperta dell’opera di Saul Steinberg, Vi hanno contribuito Stefano Boeri, Marco Sammicheli, Claudio Bartocci, Stefano Bartezzaghi, Francesco Cataluccio, Gabriele Gimmelli, Nunzio La Fauci, Francesca Pellicciari, Mario Tedeschini Lalli e Stefano Salis, autore della voce Mappe. Autogeography che qui proponiamo in anteprima.
«Non ho mai visto R. Sarat. Ecco un posto da visitare l’anno prossimo». È il primo novembre 1988: Steinberg manda ad Aldo Buzzi una riproduzione del suo atto di nascita, il primo dei documenti (in ordine di apparizione nella sua vita) che costituiranno una ossessione identitaria lungo tutta la sua vita. Documento che Steinberg si affretta come a «smentire»; a porre, immediatamente, una distanza dal luogo che certifica la sua nascita eppure a lui ignoto.
Talmente ignoto che gli sembrerà, vista l’altra sua ossessione per le mappe, un nome inventato giusto per collocare la sua nascita. Il demone dell’identità (vero sottinteso a tutta l’arte di Saul Steinberg) qui è ridotto alle sue costanti resistenziali che Steinberg non si stancherà mai di perseguire: documenti, mappe, disegni, realtà, finzione, maschera. Ci sarebbe da scrivere libri, forse: o da disegnare una mappa. Per paradosso (un’altra di quelle cose che a Steinberg erano congeniali), Steinberg diventerò celebre per una mappa, quella della vista del mondo dalla Nona Avenue di New York, ma, tra le tante mappe che disegnerà, ce n’è una, splendida, del 1966, che si intitola significativamente «Autogeography» che raduna, in una delle tipiche modulazioni della cartografia che Steinberg eseguiva regolarmente, i luoghi importanti della sua vita. Paradosso nel paradosso, nata per essere una proposta di pubblicazione di copertina del «New Yorker» di quell’anno, la mappa non verrà mai pubblicata in vita. Eppure.
Eppure si tratta forse della più nitida disanima del suo perlustrare luoghi, fisici e mentali, che Steinberg ci ha lasciato. Il mondo è ricreato alla misura esatta di Steinberg, e lungo un fiume che domina e si insinua in una placida pianura, l’autore si esercita a «nominare» luoghi: collocandoli del tutto arbitrariamente in un disegno che è, al tempo stesso, qualcosa di astratto e una descrizione precisa dei suoi movimenti. «Autogeography» è così una mappa (per oggettive ragioni tecniche), ma anche un paesaggio (altro tipico disegno del mondo steinberghiano) ma anche una cartolina, come quelle che amava collezionare (e alla fine della sua vita erano molte) e spedire: quasi che fosse un preciso messaggio dai luoghi che lo avevano interessato.
In che modo? Non tutti hanno la stessa importanza, evidentemente: e Steinberg sembra ricordarsene. Ci sono posti, infatti, che hanno l’onore di un lettering più vistoso. Sono certamente quelli nei quali ha abitato, dunque rivestono un posto speciale nel suo cuore. Ramnicul Sarat, appunto, Bucuresti (in rumeno), Springs, Amagansett, New York e, ben collocata su un’isola a sé stante in quello che sembra un lago, Milano.
Ma non è solo questione di posti «vissuti». Ci sono quelli di origine come Buzau, il luogo della Romania da dove venivano i nonni (imbucare le lettere e gridare «La Buzau» alla cassetta è uno degli aneddoti più divertenti dello Steinberg bambino rumeno), o Odessa, altra tappa di partenza della famiglia, e poi i luoghi, molti, visitati durante la Guerra, e disegnati in reportage singolari, omaggi alle altrui geografie delle quali è bello appropriarsi (non manca Orani, paese natale di Costantino Nivola), città entrate nella «narrazione» steinberghiana per motivi di vacanza o di passaggio (Butte in Montana, Tuba City, Arizona «dove ho comprato un cappello») ma che servono a fissare lo sterminato paesaggio del disegnatore, e persino Harar, in Etiopia: luogo caro a Steinberg per via letteraria.
È il posto, infatti, nel quale si rifugerà Rimbaud (una presenza intellettuale costante nello Steinberg scrittore-lettore), dopo avere lasciato la vecchia Europa. La mappa, insomma, è uno scenario e un paesaggio interiore. Lo è sempre in Steinberg, ma qui si rivela nella sua nudità più cruda: solo nomi che servono ad evocare, non mostrare, situazioni, persone, atmosfere.
C’è un portato sentimentale che non è percepibile al lettore non informato: nessuno era autorizzato a conoscere i dettagli della biografia di Steinberg per cogliere nessi e connessi di quei nomi depositati («nomina nuda tenemus», avrebbe insegnato Il nome della rosa, romanzo non caro a Steinberg) piattamente sulla mappa e lanciati quasi a caso come semi da far germogliare in una prateria innaffiata dal fiume della sua vita. Ma resta ciò che la mappa significa, a partire dal titolo. Che è il solo titolo possibile per le mappe, tutte un’«autogeografia» nella quale non contano le distanze chilometriche ma quelle del cuore, la grandezza delle città ma delle esperienze che si sono vissute, il tempo dilatato della vita che scorre, svolta e si ripiega, creando laghi, strettoie, cascate.
Ciascuno, sembra dirci Steinberg, si cerchi, disegni e viva la propria autogeografia, carta millimetricamente più esatta di qualsiasi compilazione ufficiale. Quasi a sancire una sorta di risarcimento di quella mancata pubblicazione originaria, il «New Yorker» pubblicò la mappa a tutta pagina in un numero del 2005. Accanto a «Map of Saul», un sobrio articolo di Roger Angell.
L’articolo inizia con una frase che lascia interdetti. «Mai sicuro delle sue origini, Saul Steinberg inventò la città rumena di Ramnicul Sarat, come posto per la sua nascita». La spiazzante sicurezza con la quale viene trattata la questione dell’«invenzione» del luogo è, in fin dei conti, il più brillante dei paradossi, e l’incarnazione fattuale di quella insostenibilità dei documenti come oggettivazione della nostra esistenza. È una rivincita postuma di Saul, l’uomo che non vide mai il suo luogo di nascita. Fino a farci dubitare che davvero esistesse.
© Electa e l’autore. Per gentile concessione dell’editore

Un lavoro senza titolo (1965) di Saul Steinberg, New York, The Saul Steinberg Foundation. © The Saul Steinberg Foundation / Artists Rights Society (ARS) New York
Altri articoli dell'autore
Il volume di Giulio Iacchetti esplora e analizza quelle cose spesso di ottimo gusto che fanno di tutto per sparire dalla nostra vi(s)ta
Nel Labirinto della Masone le evoluzioni dell’aeropittura, tra nuove possibilità figurative e scavo nell’interiorità dell'uomo
Una mostra in compagnia di Stefano Salis: «Una mostra bellissima e memorabile, molto più importante di quanto essa stessa non sembri credere»
In prima mondiale da Einaudi il libro dei disegni di William Jones, capolavoro di arte e scienza