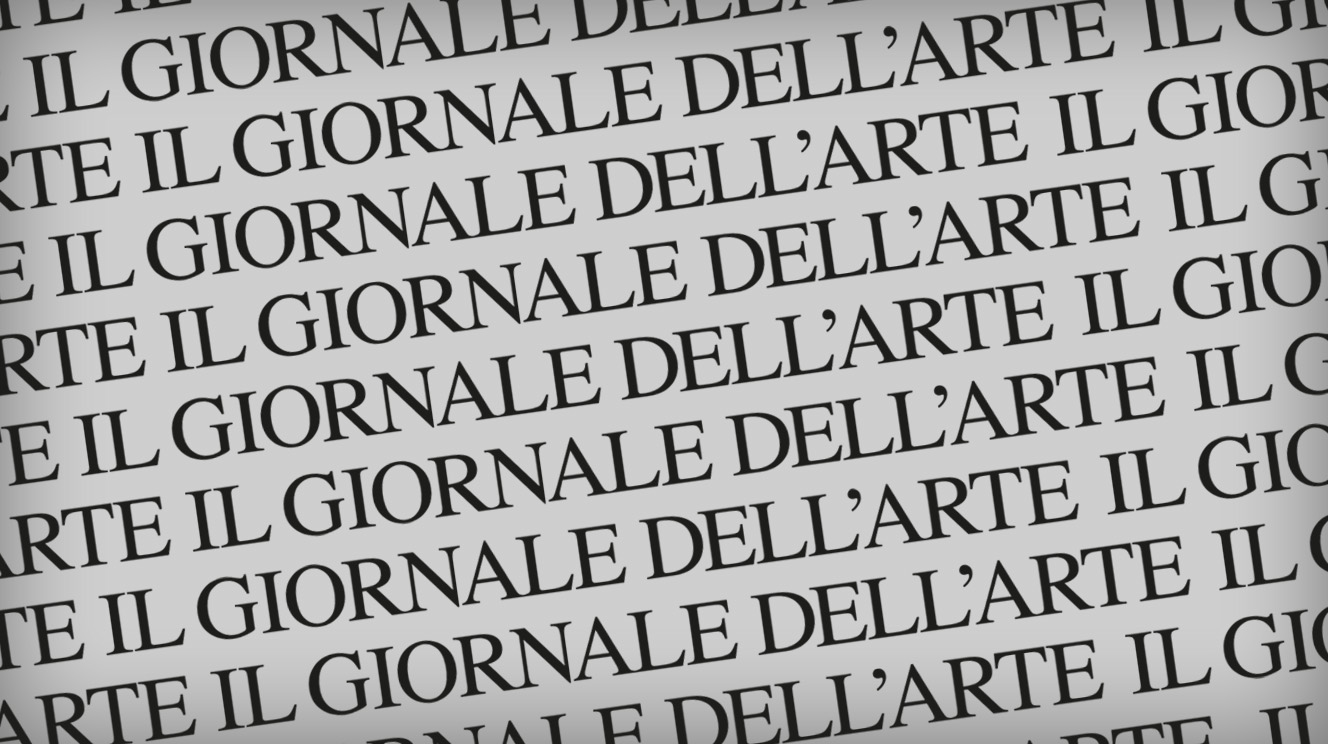Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Laura Lombardi
Leggi i suoi articoliFirenze. Dal 10 febbraio al 24 maggio la Galleria degli Uffizi presenta la prima mostra monografica mai dedicata, non solo in Italia, ma anche all’estero a Gerrit van Honthorst (1592-1656) che nel nostro Paese, dove visse per circa un decennio tra il 1610 e il 1620, si conquistò l’appellativo di Gherardo delle Notti. Le opere più celebri dell’artista sono infatti le scene a lume di notte, nelle quali il maestro, nativo di Utrecht, rivela una qualità pittorica strepitosa, che avrà grande influenza sui pittori italiani e stranieri, da Trophime Bigot a Giovan Francesco Guerrieri, da Francesco Rustici a Adam de Coster, da Rutilio Manetti a Mathias Stomer, da Domenico Fiasella a Paolo Guidotti. La mostra, come ci spiega Gianni Papi che ne è ideatore e curatore, sotto la direzione di Antonio Natali, «si concentra soprattutto sull’attività italiana di Honthorst riunendo circa l’80% dei dipinti realizzati in Italia (ma ora conservati anche all’estero), in anni di grande attività e successo. Egli riparte infatti per Utrecht nel 1620, improvvisamente, all’apice della sua fama, dopo aver dipinto nel 1619 la pala commissionata da Piero Guicciardini, ambasciatore mediceo a Roma, per l’altare della sua cappella in Santa Felicita» (la grande «Adorazione dei pastori» violentemente offesa dall’attentato mafioso agli Uffizi del 1993). Ma, oltre al Guicciardini, grandi ammiratori di Honthorst sono il marchese Vincenzo Giustiniani e suo fratello Benedetto, cardinale, mentre a Firenze è Cosimo II de’ Medici a nutrire una vera passione per l’olandese tanto che, alla sua partenza, avendo saputo da Guicciardini dell’esistenza di sei opere sul mercato romano, si mette alla ricerca per acquistarle; dalle fonti non sappiamo quali dipinti fossero, ma alcuni sono di certo presenti in mostra. «Da una pittura più cruda e nordica, che caratterizza le prime opere dipinte in Italia, aggiunge Papi, Honthorst evolve verso un maggior plasticismo, assumendo un tono più severo e monumentale come si vede, ad esempio, nel “Cristo dinanzi a Caifa”, importante prestito dalla National Gallery di Londra, o nella “Decollazione del Battista” per Santa Maria della Scala a Roma».
In mostra sono presentati vari confronti con pittori che influenzarono Van Honthorst o che furono attenti alla sua lezione; centrale la figura di Caravaggio, presente con «Il cavadenti» della Galleria Palatina di Firenze, soggetto che Gerrit ripete ben due volte anche dopo il ritorno in Olanda. Ma anche quella di Luca Cambiaso, le cui opere erano nella collezione Giustiniani. «Una delle novità della mostra, prosegue Papi, è l’approfondimento dei rapporti di Van Honthorst con Genova, forse proprio tramite i Giustiniani, le cui origini erano genovesi». Troviamo così, ad esempio, la «Santa Teresa incoronata» eseguita per la chiesa di Sant’Anna a Genova, prima fondazione carmelitana fuori dalla Spagna, a ricordarci che Honthorst fu il pittore preferito da quell’ordine. Vi sono poi i suoi concittadini, Dirck van Baburen o Hendrick Terbrugghen, oppure lo Spadarino (il cui «Convito degli dei» agli Uffizi era prima assegnato a Honthorst) e Bartolomeo Manfredi, che condivide con Gherardo delle Notti la predilezione per le scene conviviali.
Dopo la partenza dall’Italia, Van Honthorst allenta la produzione di quadri di soggetto sacro, dedicandosi soprattutto alle scene conviviali e schiarendo la sua tavolozza. «Nella selezione delle opere ho scelto di fermarmi alla fine del terzo decennio, escludendo la ritrattistica tarda», conclude Papi, poiché negli anni della maturità, quando lavora per teste coronate come Carlo I o Cristiano IV di Danimarca, Honthorst perde vigore nell’invenzione e nello stile. La mostra, che appartiene al ciclo di «Un anno ad arte 2015», gode del consueto sostegno dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
Altri articoli dell'autore
L’intervento è stato condotto nel laboratorio del Settore bronzi e armi antiche dell’Opificio delle Pietre Dure prima sulla Porta dei Martiri e poi, con il sostegno dei Friends of Florence, sulla Porta degli Apostoli. Ora sono tornate nel mausoleo mediceo progettato da Brunelleschi
Nel centenario della morte, e a quasi un secolo dall’ultima antologica, la Fondazione Ragghianti riunisce un ampio corpus di opere (molte inedite) di uno dei sette fondatori del gruppo Novecento
La Galleria dell’Accademia ha restaurato il Trittico firmato e datato 1391, cruciale per ricostruire la carriera pittore del Trecento, e racconta l’intervento in una mostra
«Il mio lavoro non è politico, ma piuttosto sociale, perché in politica ci si rivolge a un periodo troppo breve, mentre io mi occupo di questioni più esistenziali», spiega l’artista belga