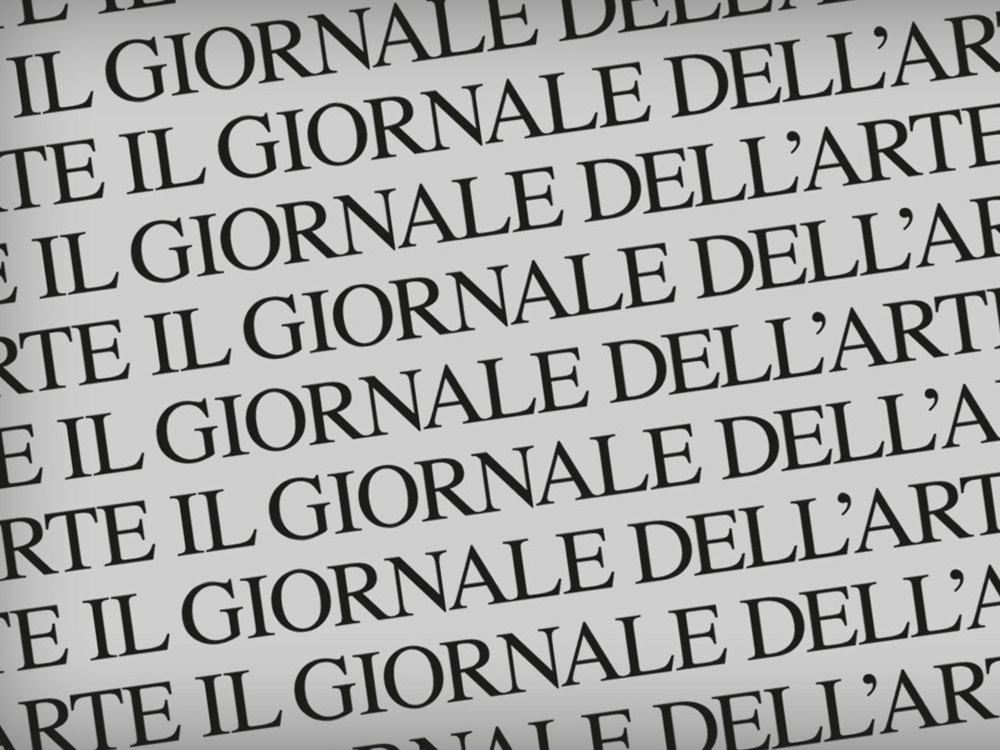Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Bernard Berenson lo sosteneva sin dal 1954: Pieter Paul Rubens «è un pittore italiano». Ma già un autorevole contemporaneo, il padre oratoriano Flaminio Ricci, notava nel 1608 come l’artista fosse sì «fiammingo, ma da putto allevato a Roma». Eppure non sono stati molti gli studiosi ad allinearsi alle loro voci, perché di Rubens (Siegen, 1577-Anversa, 1640; dal 1600 al 1608 in Italia, ben presto pittore di corte dei Gonzaga) la storiografia evidenzia sempre la cultura fiamminga, mentre trascura la componente italiana della formazione e, più ancora, l’impronta da lui lasciata sui contemporanei e sulle generazioni successive, da Pietro da Cortona, Gian Lorenzo Bernini, Lanfranco, fino a Luca Giordano e Salvator Rosa.
È proprio lungo questo filo, inedito, che si dipana la grande mostra (oltre 75 opere) «Pietro Paolo Rubens e la nascita del Barocco», ideata da un comitato scientifico internazionale (Eloisa Dodero, David Jaffé, Johann Kraeftner, Cecilia Paolini, Alejandro Vergara e Anna Lo Bianco, cui si deve la curatela), promossa dal Comune di Milano e organizzata da Civita Mostre (catalogo Marsilio), che si tiene a Palazzo Reale dal 26 ottobre al 26 febbraio 2017. Ne parliamo con la curatrice.
Anna Lo Bianco, non sono state rare, in Italia, le mostre di Rubens. In che cosa si differenzia la vostra?
La mostra mette in scena per la prima volta attraverso confronti puntuali lo stretto rapporto di Rubens con l’Italia, la sua ammirazione per la grande arte italiana (Michelangelo, Tiziano, Tintoretto, Parmigianino e Correggio) e la sua devozione per il mondo classico, ma al tempo stesso evidenzia l’importanza della sua lezione sui nostri artisti del primo Seicento: i maestri del Barocco. Sinora, specie in Italia, si sottolineava soprattutto la sua appartenenza all’arte fiamminga. Noi intendiamo invece evidenziare il tema, mai esplorato prima in una mostra, del suo rapporto con l’Italia.
Come provate tale rapporto?
L’influsso sulla sua creatività dell’arte italiana e del mondo classico, approfondita per primo da Michael Jaffé, è evidente in numerose sue opere: dalla «Susanna e i vecchioni» della Galleria Borghese, che evoca lo «Spinario» dei Musei Capitolini, ai dipinti dedicati a Eracle, ispirati all’«Ercole Farnese», si individuano innumerevoli derivazioni compositive da opere da lui viste in Italia. Non si tratta però di citazioni filologiche: come già segnalava nel Seicento (con tono un po’ critico) il Giovanni Bellori, Rubens aveva un approccio anticonformista all’antico e una singolare capacità d’interpretare l’arte classica, quasi di identificarsi in una cultura studiata a fondo già negli anni della formazione ad Anversa ma che nel suo soggiorno in Italia diviene punto di partenza per una rievocazione personale, che ingloba e reinterpreta la fonte antica, con una scossa inventiva fortissima. Inoltre, giungendo in Italia nel 1600, anno giubilare e denso di novità sconvolgenti (si pensi a Caravaggio e Annibale Carracci) è fortemente impressionato dai grandi italiani del suo tempo, che si aggiungono a maestri come Michelangelo, Tiziano, Tintoretto.
Che cosa ha insegnato Rubens agli italiani?
Ha trasmesso loro l’idea di una pittura concitata, in movimento, in cui la rappresentazione invade lo spazio circostante. Il grandioso trittico dell’altare maggiore della Chiesa Nuova, a Roma, si dilata e «ingloba», per così dire, lo spazio. Lo stesso accade nella «Famiglia Gonzaga in adorazione della Trinità» (che tanto conterà per Bernini, nelle sue cappelle) o nel ritratto di Giovan Carlo Doria a cavallo. È evidente che il tema dello spazio, al pari della drammaticità infusa da Rubens nelle scene, sono concetti già profondamente barocchi. Ma non solo: attingendo liberamente all’antico, egli è protagonista di quella «secolarizzazione» della pittura sacra che è la vera novità del Barocco. L’elegantissima «Santa Domitilla» della Chiesa Nuova sembra una matrona romana, i santi sono eroi classici. La sua è un’interpretazione più disinvolta della pittura sacra, lontana dall’ortodossia eppure profondamente religiosa.