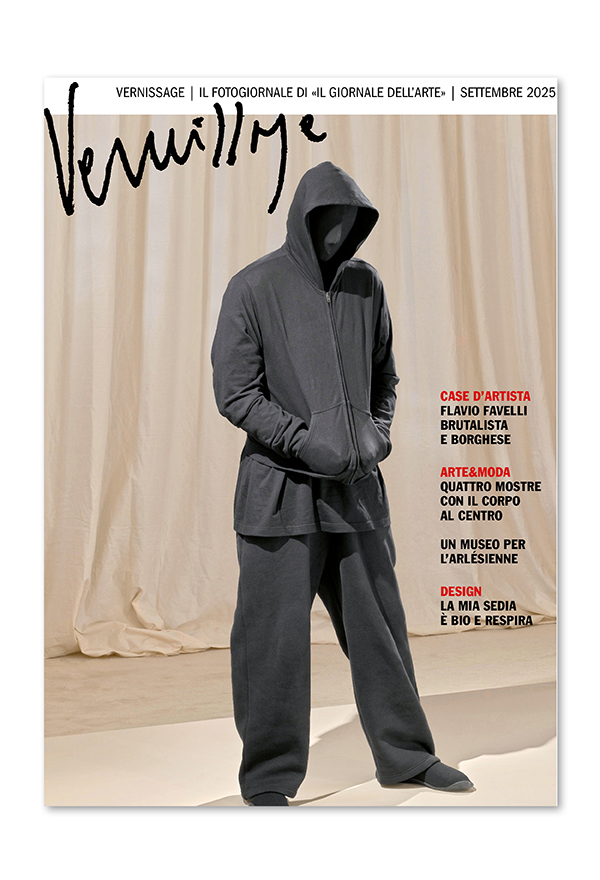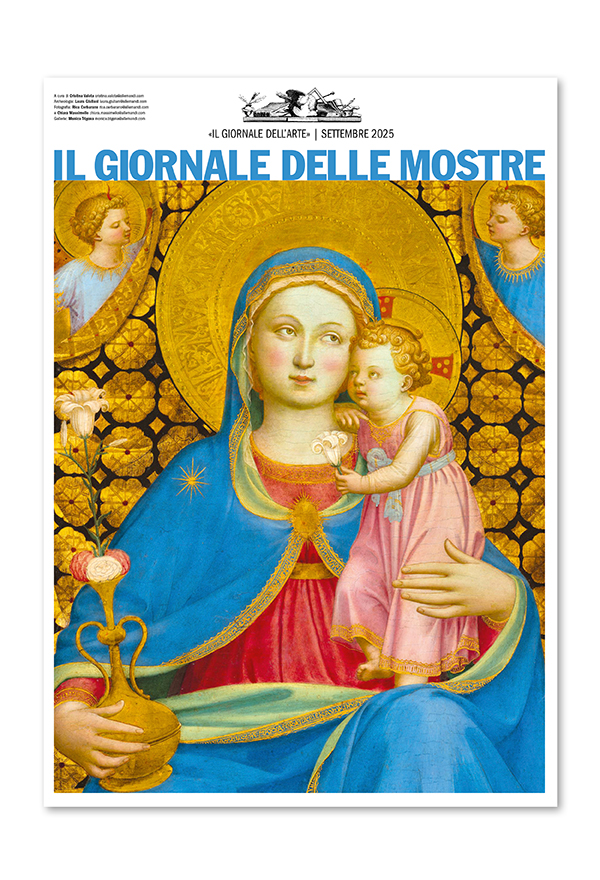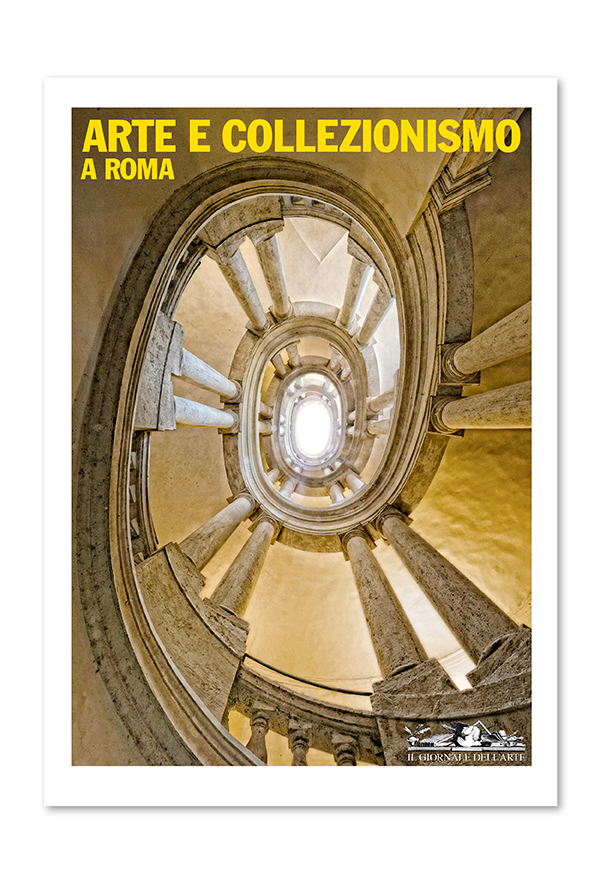Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Giuseppe Mancini
Leggi i suoi articoliÈ Max von Oppenheim, diplomatico tedesco convertitosi all’archeologia, l’eroe della mostra in programma dal 2 maggio al 12 agosto nella Hall Napoléon del Louvre: «Regni ritrovati. Dall’impero ittita agli Aramei», dedicata alla storia, poco conosciuta, dal grande pubblico, degli imperi e dei regni della Anatolia tra l’Età del Bronzo e l’Età del Ferro. L’impero ittita, che estese il suo dominio fin sul Levante rivaleggiando con l’Egitto di Ramses II. I regni neoittiti o aramei emersi dopo la sua caduta improvvisa, verso il 1180 a. C., e considerati «eredi delle tradizioni politiche, culturali e artistiche dell’impero scomparso», come si legge nel dotto catalogo edito da Lienart.
Membro di una famiglia di banchieri e appassionato sin da giovane di Medio Oriente e di Islam, impegnato in una missione per definire il tracciato della linea ferroviaria Berlino-Baghdad, nel 1899 von Oppenheimer s’imbatté nella città sepolta di Guzana, in Mesopotamia, al confine tra le odierne Turchia e Siria (col nome moderno di Tell Halaf).
Localizzò le principali strutture della città e il palazzo del re arameo Kapara, trovò sculture monumentali in basalto e ortostati pregevolmente decorati a bassorilievo, tornò nel 1911-14 per una vera e propria campagna di scavi.
Fu però solo dopo la fine della prima guerra mondiale (nel 1927 e nel 1930) che poté istituire un piccolo museo ad Aleppo e un altro spettacolare direttamente a Berlino, dove le sculture riproducevano l’ingresso maestoso del palazzo reale di Tell Halaf. Il museo tedesco venne colpito da una bomba al fosforo durante la seconda guerra mondiale, i reperti sbriciolati in 27mila frammenti recuperati tra le rovine e per decenni dimenticati nei depositi del Pergamonmuseum.
Solo negli anni 2000 sono iniziati i restauri, che nel corso di un decennio hanno prodotto un centinaio di pezzi tra sculture ed elementi architettonici; da solo, il grifone in basalto posto a guardia della porta interiore del cosiddetto «palazzo occidentale» conta 2.600 frammenti.
«È un prestito eccezionale, un’occasione unica», ha dichiarato a «Il Giornale dell’Arte» Vincent Blanchard, il commissario della mostra. «Abbiamo ottenuto tutte le opere principali, che verranno integrate alle collezioni permanenti del Pergamon una volta finiti i lavori di ristrutturazione attualmente in corso». Per ovvie ragioni cronologiche, i visitatori scoprono per primo l’impero ittita, con capitale Hattusa in Anatolia centrale, di cui vengono presentate le varie fasi storiche e l’espansione territoriale.
Tra gli oggetti esposti spiccano i rhyton rituali a forma di cervo e di toro, capolavori di oreficeria, prestati dal Metropolitan Museum of Art di New York, figurine cultuali in terracotta e in bronzo od oro, sigilli, i calchi dei rilievi della Porta delle sfingi di Alaca Höyük (gli originali sono ad Ankara), le straordinarie figurine di divinità in oro e lapislazzuli di Karkemish, tavolette in terracotta iscritte e stele, il Papiro della battaglia tra Ittiti ed Egizi di Qadesh conservato proprio al Louvre.
Il percorso espositivo si concentra poi sugli Stati successori dell’impero, nel sud dell’Anatolia e in Siria: «neoittiti» perché ne ereditarono la cultura e persino gli amministratori, «aramei» per consonanza linguistica. I loro centri urbani hanno fatto la storia dell’archeologia pioneristica a cavallo del XIX e XX secolo, resi celebri da personaggi mediatici e controversi come Lawrence d’Arabia e Agatha Christie: Sama’al, Tabal, Gurgum, Kunuluwa, Hamath, Karkemish e Melid/Malatya dove sono attive prestigiose missioni archeologiche italiane, la Guzana di Max von Oppenheim.
Vennero poi conquistati attorno al 700 a.C. dagli Assiri, a cui trasmisero le proprie competenze artistiche: come si può notare nei grandi ortostati dei palazzi di Nimrud o Ninive, chiaramente influenzati dalle sculture monumentali dei loro predecessori, o nei meravigliosi avori sempre di Nimrud in prestito anche in questo caso dal Met e di Arslan Tash posseduti dal museo parigino.

Lo scavo del sito di Tell Halaf in Mesopotamia nei primi decenni del Novecento. © Fondation Max Freiherr von Oppenheim